
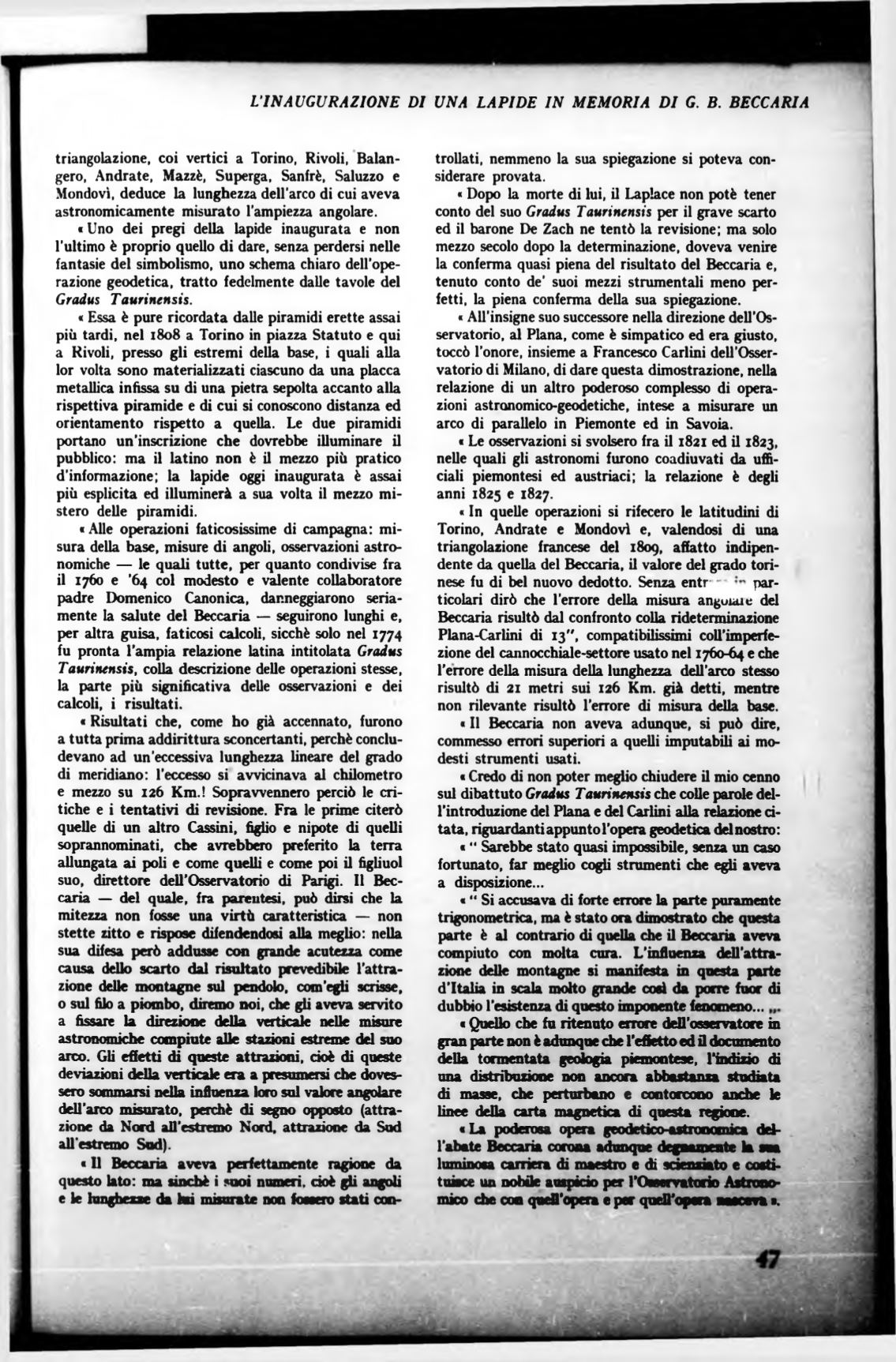
L 'I N A U G U R A Z I O N E D I U N A L A P I D E I N M E M O R I A D I G. B . B E C C A R I A
triangolazione, coi vertici a Torino, Rivoli, Balan-
gero, Andrate, Mazzè, Superga, Sanfrè, Saluzzo e
Mondovì, deduce la lunghezza dell’arco di cui aveva
astronomicamente misurato l'ampiezza angolare.
«Uno dei pregi della lapide inaugurata e non
l’ultimo è proprio quello di dare, senza perdersi nelle
fantasie del simbolismo, uno schema chiaro dell’ope
razione geodetica, tratto fedelmente dalle tavole del
Gradus Taurinensis.
«Essa è pure ricordata dalle piramidi erette assai
più tardi, nel 1808 a Torino in piazza Statuto e qui
a Rivoli, presso gli estremi della base, i quali alla
lor volta sono materializzati ciascuno da una placca
metaUica infìssa su di una pietra sepolta accanto alla
rispettiva piramide e di cui si conoscono distanza ed
orientamento rispetto a quella. Le due piramidi
portano un’inscrizione che dovrebbe illuminare il
pubblico: ma il latino non è il mezzo più pratico
d’informazione; la lapide oggi inaugurata è assai
più esplicita ed illuminerà a sua volta il mezzo mi
stero delle piramidi.
«Alle operazioni faticosissime di campagna: mi
sura della base, misure di angoli, osservazioni astro
nomiche — le quali tutte, per quanto condivise fra
il 1760 e '64 col modesto e valente collaboratore
padre Domenico Canonica, danneggiarono seria
mente la salute del Beccaria — seguirono lunghi e,
per altra guisa, faticosi calcoli, sicché solo nel 1774
fu pronta l ’ampia relazione latina intitolata
Gradus
Taurinensis,
colla descrizione delle operazioni stesse,
la parte più significativa delle osservazioni e dei
calcoli, i risultati.
«Risultati che, come ho già accennato, furono
a tutta prima addirittura sconcertanti, perchè conclu
devano ad un’eccessiva lunghezza lineare del grado
di meridiano: l’eccesso si avvicinava al chilometro
e mezzo su 126 Km.! Sopravvennero perciò le cri
tiche e i tentativi di revisione. Fra le prime citerò
quelle di un altro Cassini, figlio e nipote di quelli
soprannominati, che avrebbero preferito la terra
allungata ai poli e come quelli e come poi il fìgliuol
suo, direttore dell’Osservatorio di Parigi. Il Bec
caria — del quale, fra parentesi, può dirsi che la
mitezza non fosse ima virtù caratteristica — non
stette zitto e rispose difendendosi alla meglio: nella
sua difesa però addusse con grande acutezza come
causa dello scarto dal risultato prevedibile l’attra
zione delle montagne sul pendolo, com’egli scrisse,
o sul filo a piombo, diremo noi, che gli aveva servito
a fissare là direzione della verticale nelle misure
astronomiche compiute alle stazioni estreme del suo
arco. Gli effetti di queste attrazioni, cioè di queste
deviazioni della verticale era a presumersi che doves
sero sommarsi nella influenza loro sul valore angolare
dell’arco misurato, perchè di segno opposto (attra
zione da Nord all’estremo Nord, attrazione da Sud
all'estremo Sud).
«
11
Beccaria aveva perfettamente ragione da
questo lato: ma sinché i suoi numeri, cioè gli angoli
e le lunghezze
da
hai misurate non fonerò stati con
trollati, nemmeno la sua spiegazione si poteva con
siderare provata.
«Dopo la morte di lui, il Laplace non potè tener
conto del suo
Gradus Taurinensis
per il grave scarto
ed il barone De Zach ne tentò la revisione; ma solo
mezzo secolo dopo la determinazione, doveva venire
la conferma quasi piena del risultato del Beccaria e,
tenuto conto de’ suoi mezzi strumentali meno per
fetti, la piena conferma della sua spiegazione.
«All’insigne suo successore nella direzione dell’Os
servatorio, al Plana, come è simpatico ed era giusto,
toccò l’onore, insieme a Francesco Carlini dell’Osser
vatorio di Milano, di dare questa dimostrazione, nella
relazione di un altro poderoso complesso di opera
zioni astronomico-geodetiche, intese a misurare un
arco di parallelo in Piemonte ed in Savoia.
«Le osservazioni si svolsero fra il 1821 ed il 1823,
nelle quali gli astronomi furono coadiuvati da uffi
ciali piemontesi ed austriaci; la relazione è degli
anni 1825 e 1827.
«In quelle operazioni si rifecero le latitudini di
Torino, Andrate e Mondovì e, valendosi di ima
triangolazione francese del 1809, affatto indipen
dente da quella del Beccaria, il valore del grado tori
nese fu di bel nuovo dedotto. Senza entr
par
ticolari dirò che l ’errore della misura anguuue del
Beccaria risultò dal confronto colla rideterminazione
Piana-Carlini di 13", compatibilissimi coll’imperfe
zione del cannocchiale-settore usato nel 1760-64 e che
l'errore della misura della lunghezza dell’arco stesso
risultò di 21 metri sui 126 Km. già detti, mentre
non rilevante risultò Terrore di misura della base.
«Il Beccaria non aveva adunque, si può dire,
commesso errori superiori a quelli imputabili ai mo
desti strumenti usati.
«Credo di non poter meglio chiudere il mio cenno
sul dibattuto
Gradus Taurinensis
che colle parole del
l’introduzione del Plana e del Carlini alla relazione ci
tata, riguardanti appunto l’opera geodetica del nostro:
«“ Sarebbe stato quasi impossibile, senza un caso
fortunato, far meglio cogli strumenti che egli aveva
a disposizione...
«“ Si accusava di forte errore la parte puramente
trigonometrica, ma è stato ora dimostrato che questa
parte è al contrario di quella che il Beccaria aveva
compiuto con molta cura. L'influenza dell'attra
zione delle montagne si manifesta in questa parte
d’Italia in scala molto grande codi da porre fuor di
dubbio l’esistenza di questo imponente fenomeno...
«Quello che fu ritenuto errore dell’osservatore in
gran parte non è adunque che l'effetto ed il documento
della tormentata geologia piemontese, l’indizio di
una distribuzione non ancora abbastanza studiata
di masse, che perturbano e contorcono anche le
linee della carta magnetica di questa regione.
«La
poderosa opera geodetico-astrooomka del
l’abate Beccaria corona adunque degnamente k sua
luminosa carriera di maestro e di scienziato e costi
tuisce
un
nobile auspicio per l'Oaservatorio Astrono
mico che con quell’opera e per quell’opera nasceva ».


















