
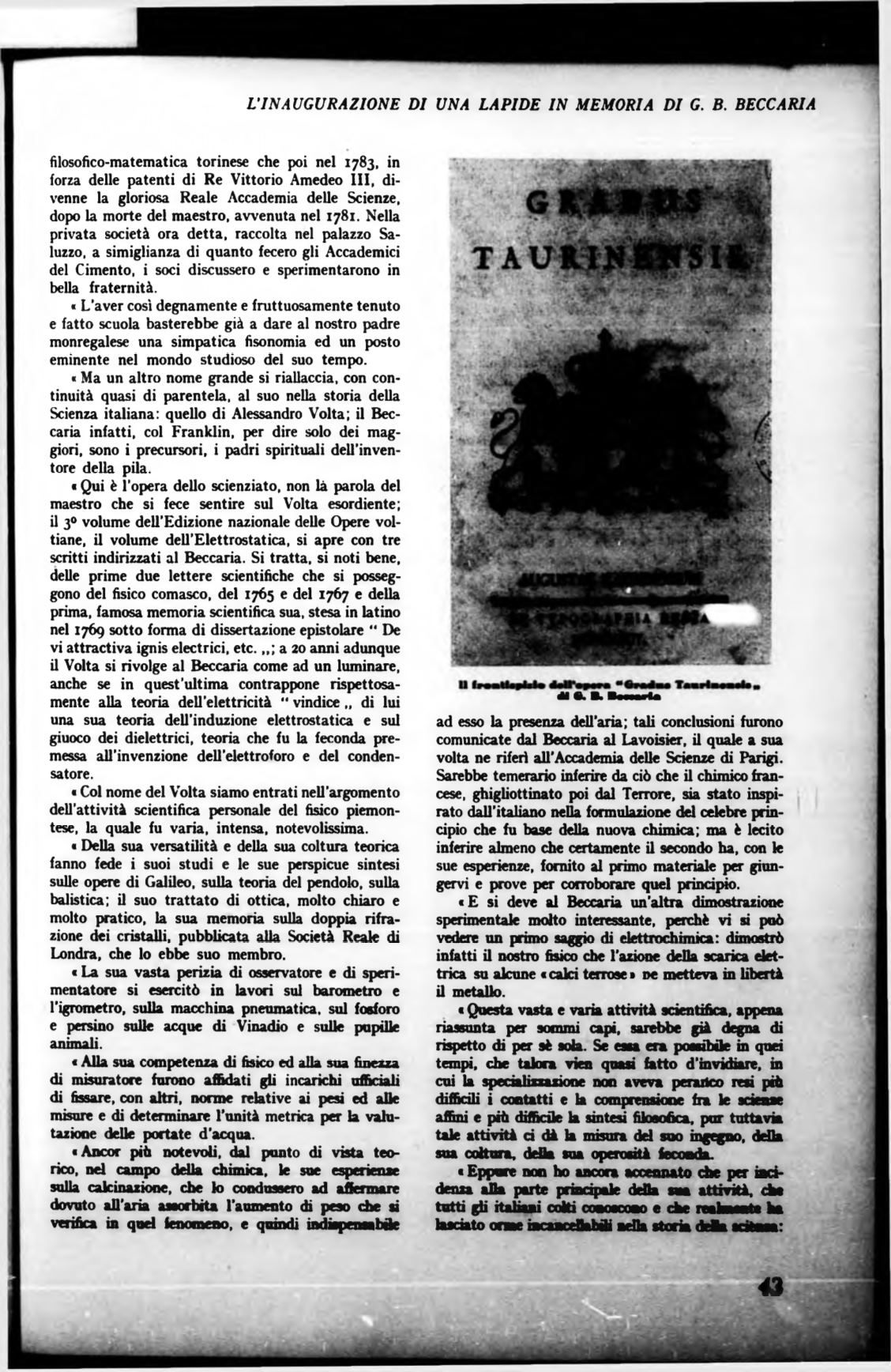
V I N A U G U R A Z I O N E D I U N A L A P I D E I N M E M O R I A D I G. B . B E C C A R IA
filosofico-matematica torinese che poi nel 1783, in
forza delle patenti di Re Vittorio Amedeo III, di
venne la gloriosa Reale Accademia delle Scienze,
dopo la morte del maestro, avvenuta nel 1781. Nella
privata società ora detta, raccolta nel palazzo Sa-
luzzo, a simiglianza di quanto fecero gli Accademici
del Cimento, i soci discussero e sperimentarono in
bella fraternità.
«L ’aver così degnamente e fruttuosamente tenuto
e fatto scuola basterebbe già a dare al nostro padre
monregalese una simpatica fìsonomia ed un posto
eminente nel mondo studioso del suo tempo.
«Ma un altro nome grande si riallaccia, con con
tinuità quasi di parentela, al suo nella storia della
Scienza italiana: quello di Alessandro Volta; il Bec
caria infatti, col Franklin, per dire solo dei mag
giori, sono i precursori, i padri spirituali dell’inven
tore della pila.
«Qui è l ’opera dello scienziato, non là parola del
maestro che si fece sentire sul Volta esordiente;
il 3° volume dell’Edizione nazionale delle Opere vol-
tiane, il volume dell’Elettrostatica, si apre con tre
scritti indirizzati al Beccaria. Si tratta, si noti bene,
delle prime due lettere scientifiche che si posseg
gono del fìsico comasco, del 1765 e del 1767 e della
prima, famosa memoria scientifica sua, stesa in latino
nel 1769 sotto forma di dissertazione epistolare “ De
vi attractiva ignis electrici, e tc .,,; a 20 anni adunque
il Volta si rivolge al Beccaria come ad un luminare,
anche se in quest'ultima contrappone rispettosa
mente alla teoria dell’elettricità “ vindice „ di lui
una sua teoria dell’induzione elettrostatica e sul
giuoco dei dielettrici, teoria che fu la feconda pre
messa all’invenzione dell’elettroforo e del conden
satore.
«Col nome del Volta siamo entrati nell’argomento
dell’attività scientifica personale del fìsico piemon
tese, la quale fu varia, intensa, notevolissima.
«Della sua versatilità e della sua coltura teorica
fanno fede i suoi studi e le sue perspicue sintesi
sulle opere di Galileo, sulla teoria del pendolo, sulla
balistica; il suo trattato di ottica, molto chiaro e
molto pratico, la sua memoria sulla doppia rifra
zione dei cristalli, pubblicata alla Società Reale di
Londra, che lo ebbe suo membro.
«La sua vasta perizia di osservatore e di speri
mentatore si esercitò in lavori sul barometro e
l’igrometro, sulla macchina pneumatica, sul fosforo
e persino sulle acque di Vinadio e sulle pupille
animali.
<Alla sua competenza di fisico ed alla sua finezza
di misuratore furono affidati gli incarichi ufficiali
di fissare, con altri, norme relative ai pesi ed alle
misure e di determinare l'unità metrica per la valu
tazione delle portate d ’acqua.
«Ancor più notevoli, dal punto di vista teo
rico, nel campo della chimica, le sue esperienze
sulla calcinazione, che lo condussero ad
affermare
dovuto all’aria assorbita l’aumento di peso che si
verifica in quel fenomeno, e quindi indispensabile
4
I & E iM N ik
ad esso la presenza dell’aria; tali conclusioni furono
comunicate dal Beccaria al Lavoisier, il quale a sua
volta ne riferì all’Accademia delle Scienze di Parigi.
Sarebbe temerario inferire da ciò che il chimico fran
cese, ghigliottinato poi dal Terrore, sia stato inspi
rato dall’italiano nella formulazione dd celebre prin
cipio che fu base della nuova chimica; ma è lecito
inferire almeno che certamente il secondo ha, con le
sue esperienze, fornito al primo materiale per giun
gervi e prove per corroborare quel prindpio.
«E si deve al Beccaria un’altra dimostrazione
sperimentale molto interessante, perchè vi si può
vedere un primo saggio di elettrochimica: dimostrò
infatti il nostro fisico che l’azione della scarica elet
trica su alcune «calci terrose » ne metteva in libertà
il metallo.
«Questa vasta e varia attività scientifica, appena
riassunta per sommi capi, sarebbe già degna di
rispetto di per sè sola. Se essa era possibile in quei
tempi, che talora vien quasi fatto d’invidiare, in
cui la specializzazione non aveva peradco resi più
difficili i contatti e la comprensione Ira le scienze
affini e più difficile la sintesi filosofica, pur tuttavia
tale attività d dà la misura dd suo ingegno, della
sua cottura, della sua operosità feconda.
«Eppure non ho ancora accennato che per inci
denza alla patte principale de&a sua attività, che
tutti gli italiani colti conoscono e che lealmente I
m
lasciato orme incanceDabfli neOa storia dd k satana:
43


















