
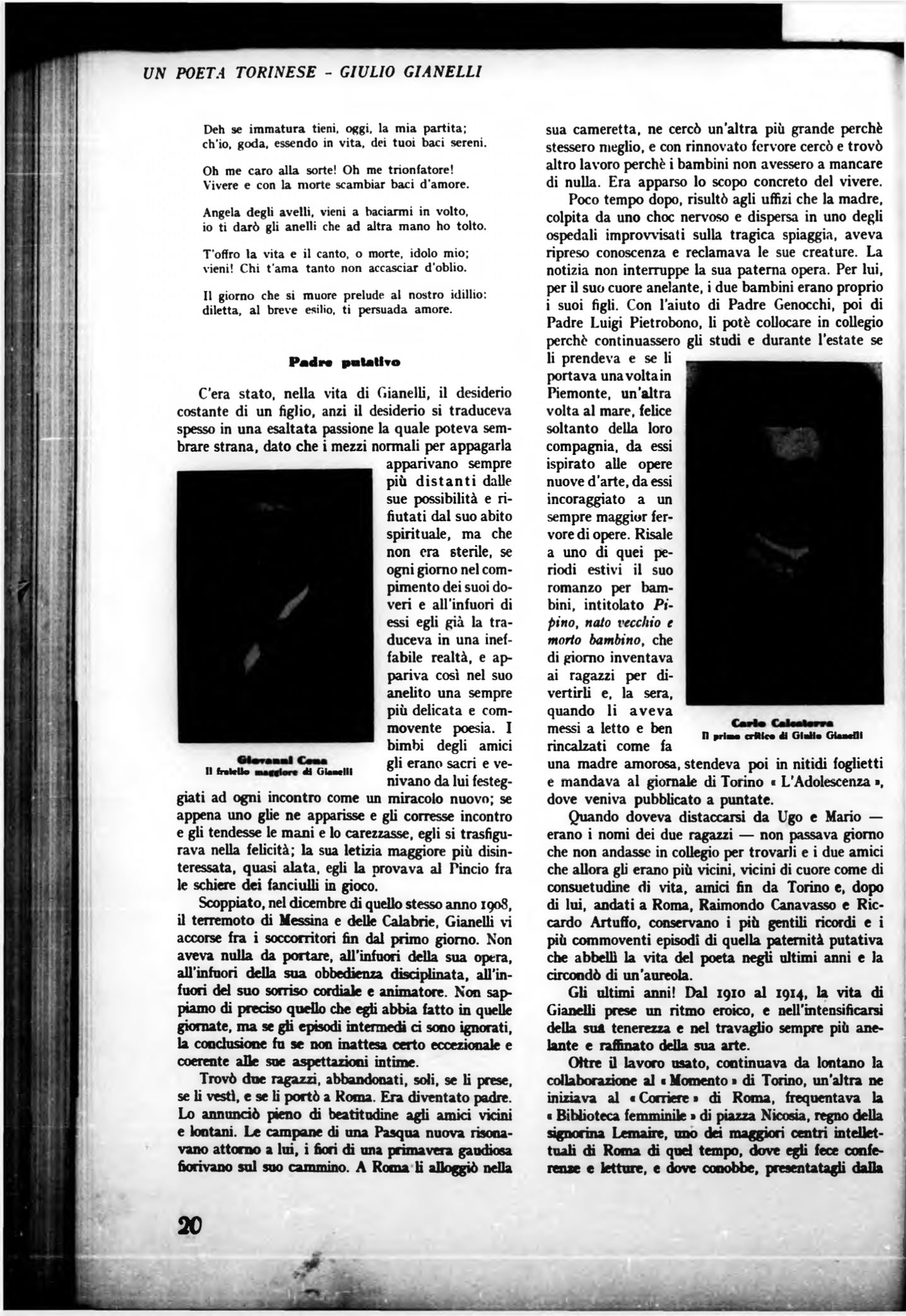
UN POETA TORINESE - GIULIO G IANELLI
Deh se immatura tieni, oggi, la mia partita;
ch’io, goda, essendo in vita, dei tuoi baci sereni.
Oh me caro alla sorte! Oh me trionfatore!
Vivere e con la morte scambiar baci d ’amore.
Angela degli avelli, vieni a baciarmi in volto,
10 ti darò gli anelli che ad altra mano ho tolto.
T ’offro la vita e il canto, o morte, idolo mio;
vieni! Chi t'ama tanto non accasciar d ’oblio.
11 giorno che si muore prelude al nostro idillio:
diletta, al breve esilio, ti persuada amore.
Padre putativo
C’era stato, nella vita di Gianelli, il desiderio
costante di un figlio, anzi il desiderio si traduceva
spesso in una esaltata passione la quale poteva sem
brare strana, dato che i mezzi normali per appagarla
apparivano sempre
più d is tan ti dalle
sue possibilità e ri
fiutati dal suo abito
spirituale, ma che
non era sterile, se
ogni giorno nel com
pimento dei suoi do
veri e all’infuori di
essi egli già la tra
duceva in una inef
fabile realtà, e ap
pariva così nel suo
anelito una sempre
più delicata e com
movente poesia. I
bimbi degli amici
gli erano sacri e ve
nivano da lui festeg
giati ad ogni incontro come un miracolo nuovo; se
appena uno glie ne apparisse e gli corresse incontro
e gli tendesse le mani e lo carezzasse, egli si trasfigu
rava nella felicità; la sua letizia maggiore più disin
teressata, quasi alata, egli la provava al Pincio fra
le schiere dei fanciulli in gioco.
Scoppiato, nel dicembre di quello stesso anno 1908,
il terremoto di Messina e delle Calabrie, Gianelli vi
accorse fra i soccorritori fin dal primo giorno. Non
aveva nulla da portare, all’infuori della sua opera,
all’infuori della sua obbedienza disciplinata, all’in
fuori del suo sorriso cordiale e animatore. Non sap
piamo di preciso quello che egli abbia fatto in quelle
giornate, ma se gli episodi intermedi ci sono ignorati,
la conclusione fu se non inattesa certo eccezionale e
coerente alle sue aspettazioni intime.
Trovò due ragazzi, abbandonati, sdi, se li prese,
se li vestì, e se li portò a Roma. Era diventato padre.
Lo annunciò pieno di beatitudine agli amici vicini
e lontani. Le campane di una Pasqua nuova risona
vano attorno a lui, i fiori di una primavera gaudiosa
fiorivano sul suo cammino. A Roma li alloggiò nella
Il fratello
41 C ian cili
sua cameretta, ne cercò un’altra più grande perchè
stessero meglio, e con rinnovato fervore cercò e trovò
altro lavoro perchè i bambini non avessero a mancare
di nulla. Era apparso lo scopo concreto del vivere.
Poco tempo dopo, risultò agli uffizi che la madre,
colpita da uno choc nervoso e dispersa in uno degli
ospedali improvvisati sulla tragica spiaggia, aveva
ripreso conoscenza e reclamava le sue creature. La
notizia non interruppe la sua paterna opera. Per lui,
per il suo cuore anelante, i due bambini erano proprio
i suoi figli. Con l’aiuto di Padre Genocchi, poi di
Padre Luigi Pietrobono, li potè collocare in collegio
perchè continuassero gli studi e durante l’estate se
li prendeva e se li
portava unavolta in
Piemonte, un’altra
volta al mare, felice
soltanto della loro
compagnia, da essi
ispirato alle opere
nuove d’arte, da essi
incoraggiato a un
sempre maggior fer
vore di opere. Risale
a uno di quei pe
riodi estivi il suo
romanzo per bam
bini, intitolato
P i
pino, nato vecchio e
morto bambino,
che
di giorno inventava
ai ragazzi per di
vertirli e, la sera,
quando li aveva
messi a letto e ben
rincalzati come fa
una madre amorosa, stendeva poi in nitidi foglietti
e mandava al giornale di Torino « L ’Adolescenza »,
dove veniva pubblicato a puntate.
Quando doveva distaccarsi da Ugo e Mario —
erano i nomi dei due ragazzi — non passava giorno
che non andasse in collegio per trovarli e i due amici
che allora gli erano più vicini, vicini di cuore come di
consuetudine di vita, amici fin da Torino e, dopo
di lui, andati a Roma, Raimondo Canavasso e Ric
cardo Artuffo, conservano i più gentili ricordi e i
più commoventi episodi di quella paternità putativa
che abbellì la vita del poeta negli ultimi anni e la
circondò di un’aureola.
Gli ultimi anni! Dal
1910
al
1914,
la vita di
Gianelli prese un ritmo eroico, e nell’intensificarsi
della sua tenerezza e nel travaglio sempre più ane
lante e raffinato della sua arte.
Oltre il lavoro usato, continuava da lontano la
collaborazione al «Momento » di Torino, un’altra ne
iniziava al • Corriere » di Roma, frequentava la
«Biblioteca femminile »di piazza Nicosia, regno della
signorina Lemaire, uno dei maggiori centri intellet
tuali di Roma di quel tempo, dove egli fece confe
renze e letture, e dove conobbe, presentatagli dalla
n
priato critico di Giallo Giaaetil
20


















