
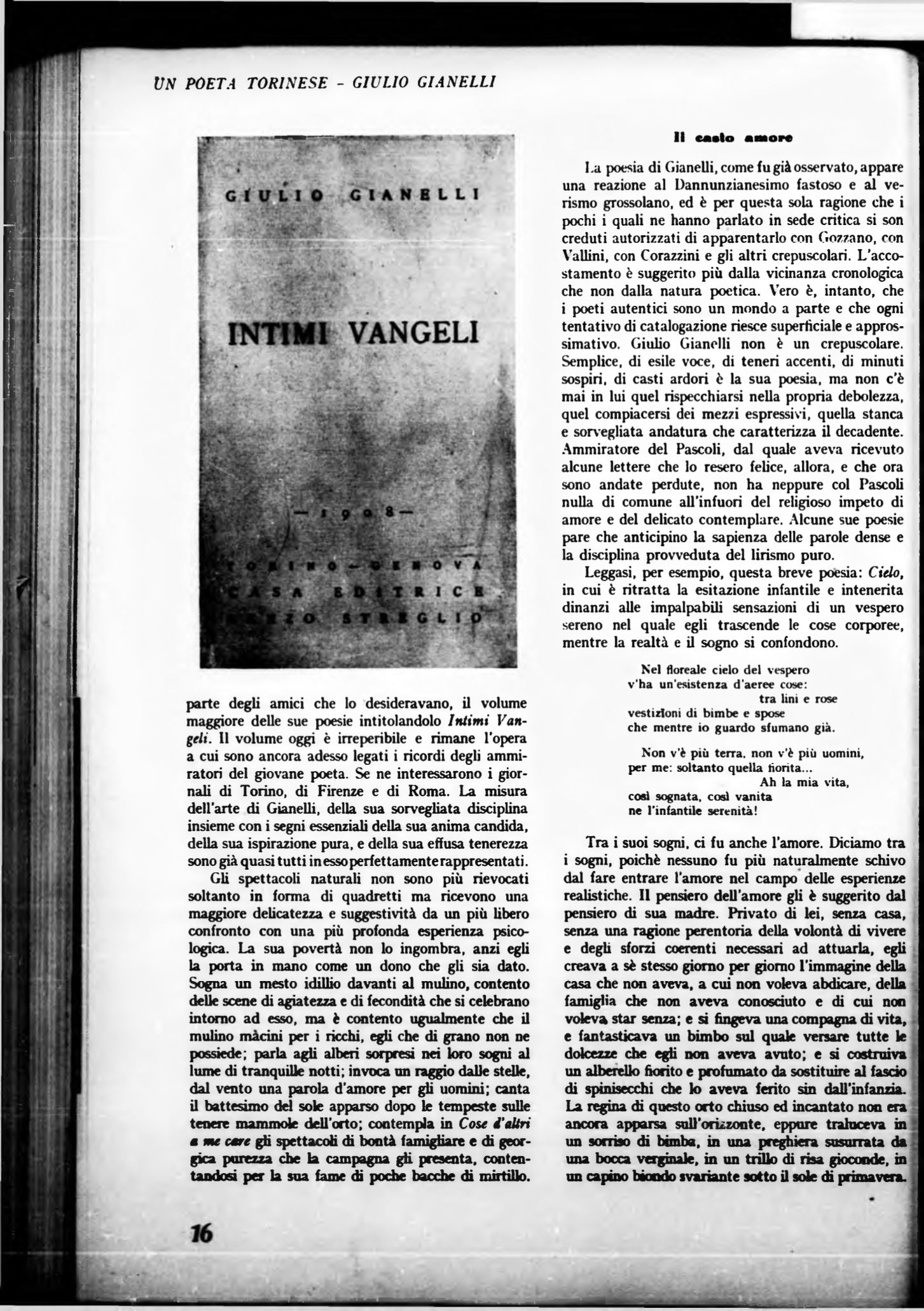
UN POETA TORINESE - GIULIO G IANELL I
Il casto am o re
La poesia di Gianelli, come fu già osservato, appare
una reazione al Dannunzianesimo fastoso e al ve
rismo grossolano, ed è per questa sola ragione che i
pochi i quali ne hanno parlato in sede critica si son
creduti autorizzati di apparentarlo con Gozzano, con
Vailini, con Corazzini e gli altri crepuscolari. L'acco
stamento è suggerito più dalla vicinanza cronologica
che non dalla natura poetica. Vero è, intanto, che
i poeti autentici sono un mondo a parte e che ogni
tentativo di catalogazione riesce superficiale e appros
simativo. Giulio Gianelli non è un crepuscolare.
Semplice, di esile voce, di teneri accenti, di minuti
sospiri, di casti ardori è la sua poesia, ma non c'è
mai in lui quel rispecchiarsi nella propria debolezza,
quel compiacersi dei mezzi espressivi, quella stanca
e sorvegliata andatura che caratterizza il decadente.
Ammiratore del Pascoli, dal quale aveva ricevuto
alcune lettere che lo resero felice, allora, e che ora
sono andate perdute, non ha neppure col Pascoli
nulla di comune aU’infuori del religioso impeto di
amore e del delicato contemplare. Alcune sue poesie
pare che anticipino la sapienza delle parole dense e
la disciplina provveduta del lirismo puro.
Leggasi, per esempio, questa breve poesia:
Cielo,
in cui è ritratta la esitazione infantile e intenerita
dinanzi alle impalpabili sensazioni di un vespero
sereno nel quale egli trascende le cose corporee,
mentre la realtà e il sogno si confondono.
Nel floreale cielo del vespero
v ’ha un’esistenza d'aeree cose:
tra lini e rose
vestizioni di bimbe e spose
che mentre io guardo sfumano già.
Non v’è più terra, non v'è più uomini,
per me: soltanto quella tìorita...
Ah la mia vita,
cosi sognata, così vanita
ne l’infantile serenità!
Tra i suoi sogni, ci fu anche l’amore. Diciamo tra
i sogni, poiché nessuno fu più naturalmente schivo
dal fare entrare l’amore nel campo delle esperienze
realistiche. Il pensiero dell’amore gli è suggerito dal
pensiero di sua madre. Privato di lei, senza casa,
senza una ragione perentoria della volontà di vivere
e degli sforzi coerenti necessari ad attuarla, egli
creava a sè stesso giorno per giorno l ’immagine della
casa che non aveva, a cui non voleva abdicare, della
famiglia che non aveva conosciuto e di cui non
voleva star senza;
e
si fingeva una compagna di vita,
e fantasticava un bimbo sul quale versare tutte le
dolcezze che egli non aveva avuto;
e
si costruiva
un alberello fiorito
e
profumato da sostituire al fascio
di spinisecchi che lo aveva ferito sin dall’infanzia.
La regina di questo orto chiuso ed incantato non era
ancora apparsa suU’orùzonte, eppure traluceva
in
un sorriso
di
bimba,
in
una preghiera susurrata
da
una bocca verginale, in un trillo di risa gioconde,
in
un
capino biondo
s
variante sotto
il sole
di primavera.
_________________
parte degli amici che lo desideravano, il volume
maggiore delle sue poesie intitolandolo
Intimi Van
geli.
Il volume oggi è irreperibile e rimane l’opera
a cui sono ancora adesso legati i ricordi degli ammi
ratori del giovane poeta. Se ne interessarono i gior
nali di Torino, di Firenze e di Roma. La misura
dell’arte di Gianelli, della sua sorvegliata disciplina
insieme con i segni essenziali della sua anima candida,
della sua ispirazione pura, e della sua effusa tenerezza
sono già quasi tutti inessoperfettamenterappresentati.
Gli spettacoli naturali non sono più rievocati
soltanto in forma di quadretti ma ricevono una
maggiore delicatezza e suggestività da un più Ubero
confronto con una più profonda esperienza psico
logica. La sua povertà non lo ingombra, anzi egli
la porta in mano come un dono che gli sia dato.
Sogna un mesto idillio davanti al mulino, contento
delle scene di agiatezza e di fecondità che si celebrano
intorno ad esso, ma è contento ugualmente che il
mulino macini per i ricchi, egli che di grano non ne
possiede; parla agli alberi sorpresi nei loro sogni al
lume di tranquille notti; invoca un raggio dalle stelle,
dal vento una parola d’amore per gli uomini; canta
il battesimo del sole apparso dopo le tempeste sulle
tenere mammole dell’orto; contempla in
Cose d’altri
mme cétre
gli spettacoli di bontà famigliare e di geor-
gica purezza che la campagna gli presenta, conten
tandosi per la sua fame
di
poche bacche
di
mirtillo.


















