
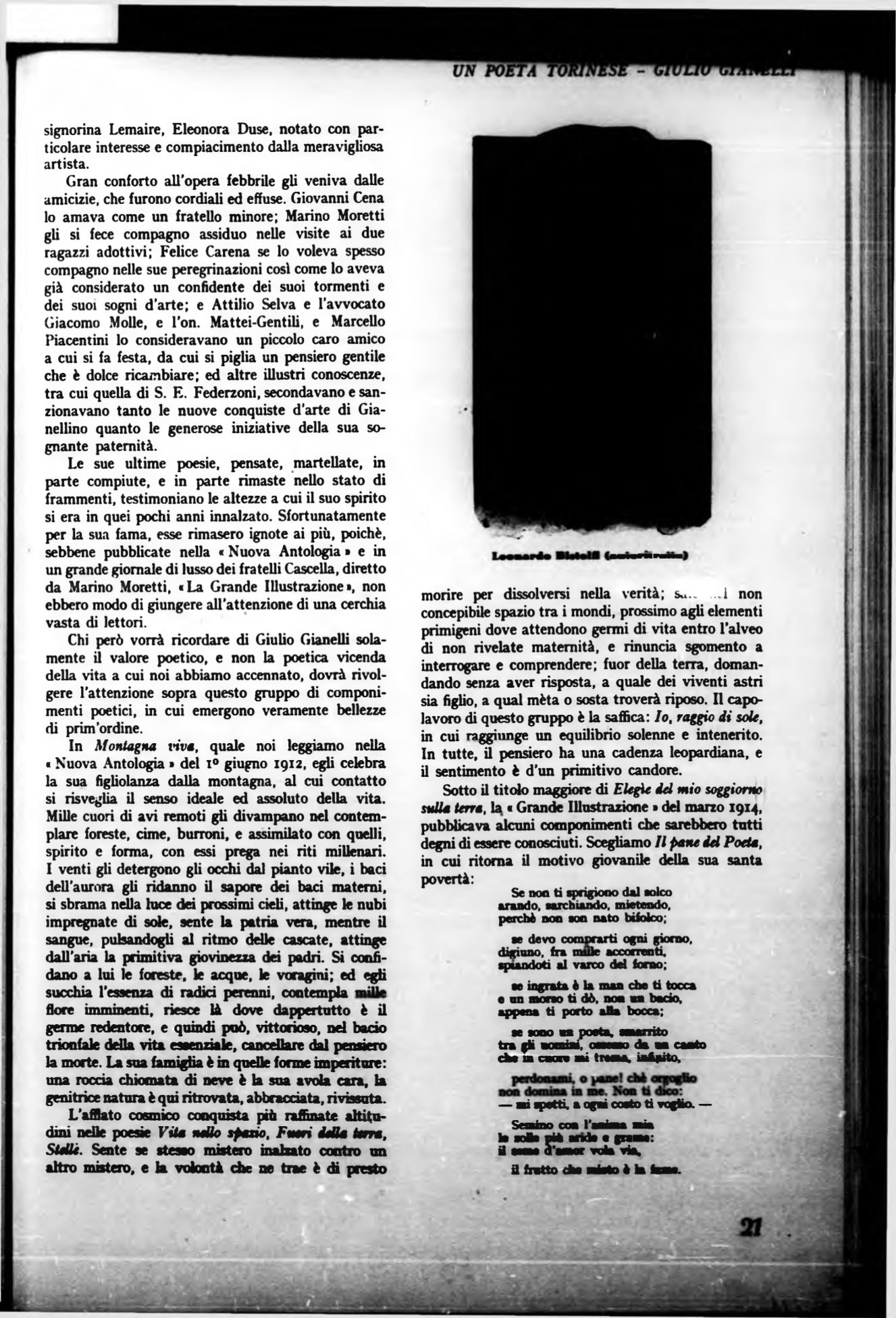
signorina Lemaire, Eleonora Duse, notato con par
ticolare interesse e compiacimento dalla meravigliosa
artista.
Gran conforto all’opera febbrile gli veniva dalle
amicizie, che furono cordiali ed effuse. Giovanni Cena
lo amava come un fratello minore; Marino Moretti
gli si fece compagno assiduo nelle visite ai due
ragazzi adottivi; Felice Carena se lo voleva spesso
compagno nelle sue peregrinazioni così come lo aveva
già considerato un confidente dei suoi tormenti e
dei suoi sogni d ’arte; e Attilio Selva e l’avvocato
Giacomo Molle, e l’on. Mattei-Gentili, e Marcello
Piacentini lo consideravano un piccolo caro amico
a cui si fa festa, da cui si piglia un pensiero gentile
che è dolce ricambiare; ed altre illustri conoscenze,
tra cui quella di S. E. Federzoni, secondavano e san
zionavano tanto le nuove conquiste d’arte di Gia-
nellino quanto le generose iniziative della sua so
gnante paternità.
Le sue ultime poesie, pensate, martellate, in
parte compiute, e in parte rimaste nello stato di
frammenti, testimoniano le altezze a cui il suo spirito
si era in quei pochi anni innalzato. Sfortunatamente
per la sua fama, esse rimasero ignote ai più, poiché,
sebbene pubblicate nella «Nuova Antologia » e in
un grande giornale di lusso dei fratelli Cascella, diretto
da Marino Moretti, «La Grande Illustrazione », non
ebbero modo di giungere all’attenzione di una cerchia
vasta di lettori.
Chi però vorrà ricordare di Giulio Gianelli sola
mente il valore poetico, e non la poetica vicenda
della vita a cui noi abbiamo accennato, dovrà rivol
gere l’attenzione sopra questo gruppo di componi
menti poetici, in cui emergono veramente bellezze
di prim’ordine.
In
Montagna viva,
quale noi leggiamo nella
«Nuova Antologia » del i ° giugno 1912, egli celebra
la sua figliolanza dalla montagna, al cui contatto
si risveglia il senso ideale ed assoluto della vita.
Mille cuori di avi remoti gli divampano nel contem
plare foreste, cime, burroni, e assimilato con quelli,
spirito e forma, con essi prega nei riti millenari.
I venti gli detergono gli occhi dal pianto vile, i baci
dell’aurora gli ridanno il sapore dei baci materni,
si sbrama nella luce dei prossimi cieli, attinge le nubi
impregnate di sole, sente la patria vera, mentre il
sangue, pulsandogli al ritmo delle cascate, attinge
dall'aria la primitiva giovinezza dei padri. Si confi
dano a lui le foreste, le acque, le voragini; ed egli
succhia l'essenza di radici perenni, contempla milU>
flore imminenti, riesce là dove dappertutto è il
germe redentore, e quindi
può, vittorioso,
nel bado
trionfale della vita
essenziale,
cancellare dal pensiero
la morte.
La sua famiglia
è
in quelle
forme imperiture:
una roccia chiomata di
neve
è
la sua avola cara, la
genitrice natura è
qui ritrovata,
abbracciata,
rivissuta.
L’afflato cosmico conquista più raffinate altitu
dini nelle poesie
Vita nello
spazio, Fuori
itila ima,
SteUé.
Sente se stesso mistero inalzato contro un
altro mistero, e la volontà die ne trae è di presto
morire per dissolversi nella verità; s«..........1 non
concepibile spazio tra i mondi, prossimo agli elementi
primigeni dove attendono germi di vita entro l’alveo
di non rivelate maternità, e rinuncia sgomento a
interrogare e comprendere; fuor della terra, doman
dando senza aver risposta, a quale dei viventi astri
sia figlio, a qual mèta o sosta troverà riposo. Il capo
lavoro di questo gruppo è la saffica:
Io, raggio i i sole,
in cui raggiunge un equilibrio solenne e intenerito.
In tutte, il pensiero ha una cadenza leopardiana, e
il sentimento è d’un primitivo candore.
Sotto il titolo maggiore di
Elegie del mio soggiorno
sulla terra,
la «Grande Illustrazione »del marzo
1914,
pubblicava alcuni componimenti che sarebbero tutti
degni di essere conosciuti. Scegliamo
II pane i d Poeta,
in cui ritorna il motivo giovanile della sua santa
povertà:
Se non ti sprigiono dal solco
arando, sarchiando, mietendo,
perchè non soa nato bifolco;
se devo comprarti ogni giorno,
digiuno, fra mule accorrenti,
spiandoti al varco d d forno;
se ingrata è la man che ti tocca
e an mono ti dò. non an bado,
appena ti porto alla bocca;
se sono
uo
poeta, smarrito
tra gli nomini, omesso da an canto
che mcuore mi trema, infinito,
—mi spetti, a agni costo ti vagho. —
Semino con l'anima mia
le
aoUe pii and» e
grame:
il asme d’amar vaia ria,
il fratto
che minio è la fame.


















