
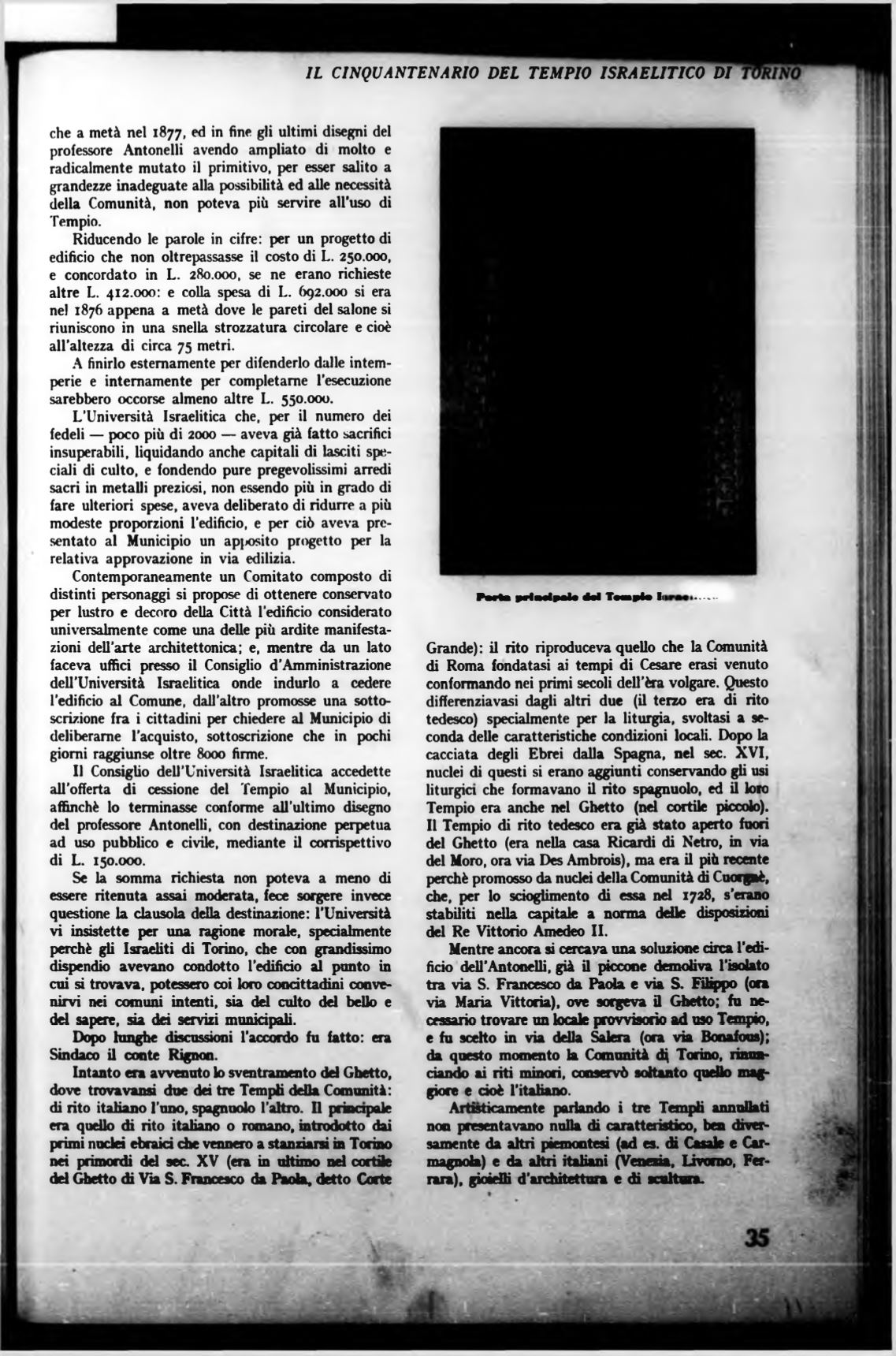
IL CINQUANTENARIO DEL TEMPIO ISRAEL IT ICO D I
che a metà nel 1877, ed in fine gli ultimi disegni del
professore Antonelli avendo ampliato di molto e
radicalmente mutato il primitivo, per esser salito a
grandezze inadeguate alla possibilità ed alle necessità
della Comunità, non poteva più servire all’uso di
Tempio.
Riducendo le parole in cifre: per un progetto di
edificio che non oltrepassasse il costo di L. 250.000,
e concordato in L. 280.000, se ne erano richieste
altre L. 412.000: e colla spesa di L. 692.000 si era
nel 1876 appena a metà dove le pareti del salone si
riuniscono in una snella strozzatura circolare e cioè
all'altezza di circa 75 metri.
A finirlo esternamente per difenderlo dalle intem
perie e internamente per completarne l’esecuzione
sarebbero occorse almeno altre L. 550.000.
L ’Università Israelitica che, per il numero dei
fedeli — poco più di 2000 — aveva già fatto sacrifici
insuperabili, liquidando anche capitali di lasciti spe
ciali di culto, e fondendo pure pregevolissimi arredi
sacri in metalli preziosi, non essendo più in grado di
fare ulteriori spese, aveva deliberato di ridurre a più
modeste proporzioni l’edificio, e per ciò aveva pre
sentato al Municipio un ap|*osito progetto per la
relativa approvazione in via edilizia.
Contemporaneamente un Comitato composto di
distinti personaggi si propose di ottenere conservato
per lustro e decoro della Città l’edificio considerato
universalmente come una delle più ardite manifesta
zioni dell’arte architettonica; e, mentre da un lato
faceva uffici presso il Consiglio d ’Amministrazione
dell’Università Israelitica onde indurlo a cedere
l’edificio al Comune, dall’altro promosse una sotto-
scrizione fra i cittadini per chiedere al Municipio di
deliberarne l’acquisto, sottoscrizione che in pochi
giorni raggiunse oltre 8000 firme.
Il Consiglio dell’Università Israelitica accedette
all’offerta di cessione del Tempio al Municipio,
affinchè lo terminasse conforme a ll’ultimo disegno
del professore Antonelli, con destinazione perpetua
ad uso pubblico e civile, mediante il corrispettivo
di L. 150.000.
Se la somma richiesta non poteva a meno di
essere ritenuta assai moderata, fece sorgere invece
questione la clausola della destinazione: l’Università
vi insistette per una ragione morale, specialmente
perchè gli Israeliti di Torino, che con grandissimo
dispendio avevano condotto l’edificio al punto in
cui si trovava, potessero coi loro concittadini conve
nirvi nei comuni intenti, sia del culto del bello e
del sapere, sia dei servizi municipali.
Dopo lunghe discussioni l’accordo fu fatto: era
Sindaco il conte Rignon.
Intanto era avvenuto lo sventramento dd Ghetto,
dove trovavansi due dd tre Templi della Comunità:
di rito italiano l’uno, spagnuolo l’altro. Il principale
era quello di rito italiano o romano, introdotto dai
primi nuctei ebraid che vennero a stanziarsi in Torino
nei primordi dd sec. XV (era in ultimo nd cortile
dd Ghetto di Via S. Francesco da Paola, detto Corte
Parto j t t o l p r f » M T m p l* li
Grande): il rito riproduceva quello che la Comunità
di Roma fondatasi ai tempi di Cesare erasi venuto
conformando nei primi secoli dell’èra volgare. Questo
differenziavasi dagli altri due (il terzo era di rito
tedesco) specialmente per la liturgia, svoltasi a se
conda delle caratteristiche condizioni locali. Dopo la
cacciata degli Ebrei dalla Spagna, nel sec. XV I,
nuclei di questi si erano aggiunti conservando gli usi
liturgia che formavano il rito spagnuolo, ed U loro
Tempio era anche nel Ghetto (nd cortile piccolo).
Il Tempio di rito tedesco era già stato aperto fuori
del Ghetto (era nella casa Ricardi di Netro, in via
del Moro, ora via Des Ambrois), ma era il più recente
perchè promosso da nudd della Comunità di Cuorgnè,
che, per lo scioglimento di essa nel 1728, s’erano
stabiliti nella capitale a norma delle disposizioni
del Re Vittorio Amedeo II.
Mentre ancora si cercava una soluzione dica l’edi
ficio dell’AntoneUi, già il piccone demoliva l’isolato
tra via S. Francesco da Paola e via S. Filippo (ora
via Maria Vittoria), ove sorgeva il Ghetto; fu ne
cessario trovare un locale provvisorio ad uso Tempio,
e fu scelto in via della Salera (ora via Bonafoos);
da questo momento la Comunità d^ Torino, rinun
ciando ai riti minori, conservò soltanto quello mag
giore e doè l’italiano.
Artìsticamente parlando i tre Templi annullati
non presentavano nulla di caratteristico,
ben
diver
samente da altri piemontesi (ad es. di
Casale e Car
magnola) e da altri italiani
(Venezia, Livorno, Fer
rara), gioielli d’architettura e
di scultura.


















