
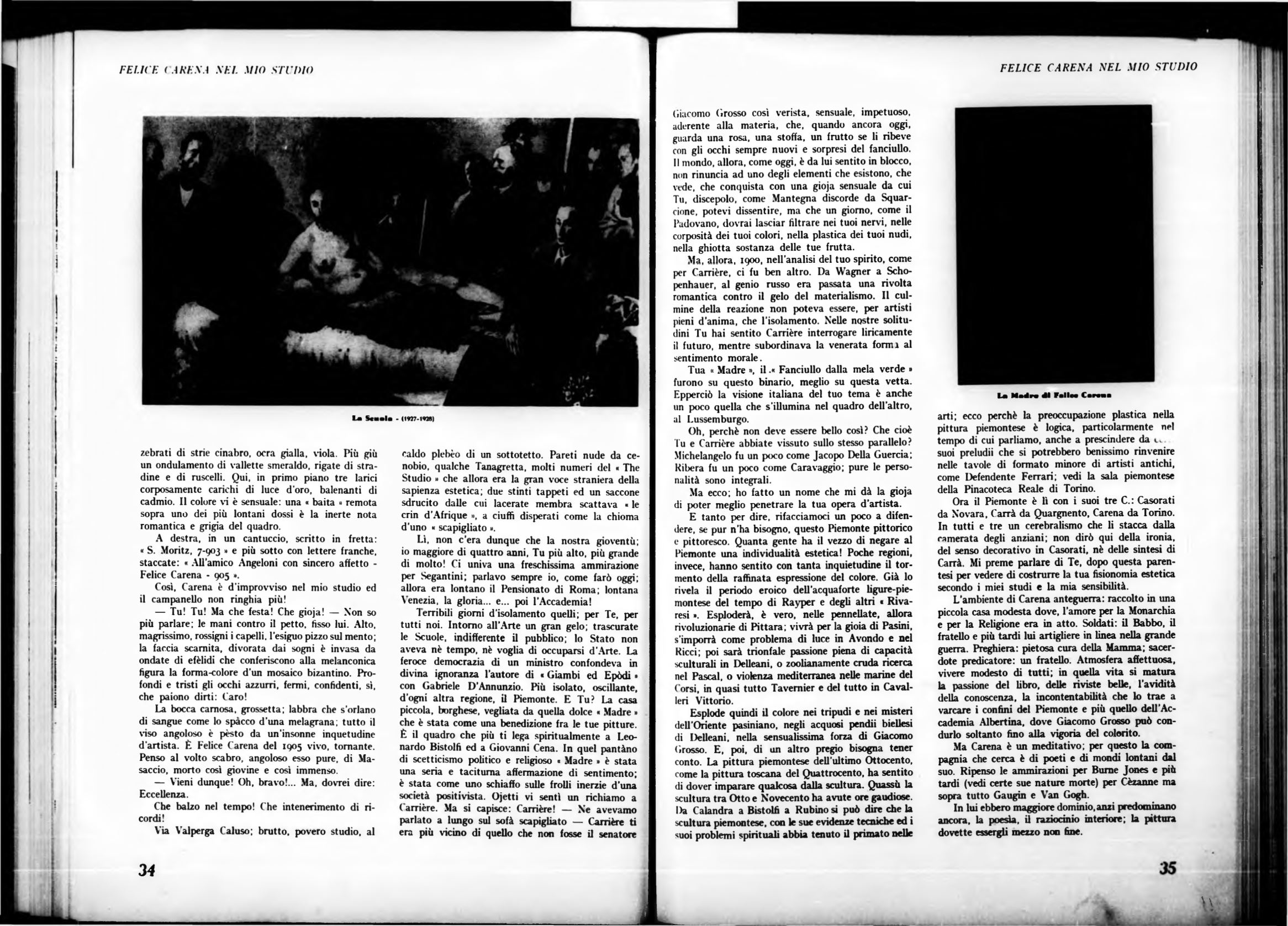
FELICE ( A RE SA S E I . MIO S T I ’PIO
FE L IC E CARENA NEL MIO STUDIO
L a S c u o l a •
(1937-1<KH)
zebrati di strie cinabro, ocra gialla, viola. Più giù
un ondulamento di vallette smeraldo, rigate di stra
dine e di ruscelli. Qui, in primo piano tre larici
corposamente carichi di luce d’oro, balenanti di
cadmio. Il colore vi è sensuale: una « baita » remota
sopra uno dei più lontani dossi è la inerte nota
romantica e grigia del quadro.
A destra, in un cantuccio, scritto in fretta:
« S. Moritz, 7-903 » e più sotto con lettere franche,
staccate: « All’amico Angeloni con sincero affetto -
Felice Carena - 905 ».
Così, Carena è d’improvviso nel mio studio ed
il campanello non ringhia più!
— Tu! Tu! Ma che festa! Che gioja! — Non so
più parlare: le mani contro il petto, fìsso lui. Alto,
magrissimo, rossigni i capelli, l’esiguo pizzo sul mento;
la faccia scarnita, divorata dai sogni è invasa da
ondate di efèlidi che conferiscono alla melanconica
figura la forma-colore d’un mosaico bizantino. Pro
fondi e tristi gli occhi azzurri, fermi, confidenti, sì,
che paiono dirti: Caro!
La bocca carnosa, grassetta; labbra che s’orlano
di sangue come lo spacco d’una melagrana; tutto il
viso angoloso è pésto da un’insonne inquetudine
d’artista. È Felice Carena del 1905 vivo, tornante.
Penso al volto scabro, angoloso esso pure, di Ma
saccio, morto così giovine e così immenso.
— Vieni dunque! Oh, bravo!... Ma, dovrei dire:
Eccellenza.
Che balzo nel tempo! Che intenerimento di ri
cordi!
Via Valperga Caiuso; brutto, povero studio, al
caldo plebèo di un sottotetto. Pareti nude da ce
nobio, qualche Tanagretta, molti numeri del « The
Studio » che allora era la gran voce straniera della
sapienza estetica; due stinti tappeti ed un saccone
sdrucito dalle cui lacerate membra scattava « le
crin d’Afrique », a ciuffi disperati come la chioma
d’uno « scapigliato ».
Li, non c ’era dunque che la nostra gioventù;
io maggiore di quattro anni, Tu più alto, più grande
di molto! Ci univa una freschissima ammirazione
per Segantini; parlavo sempre io, come farò oggi;
allora era lontano il Pensionato di Roma; lontana
\enezia, la gloria... e... poi l ’Accademia!
Terribili giorni d'isolamento quelli; per Te, per
tutti noi. Intorno all’Arte un gran gelo; trascurate
le Scuole, indifferente il pubblico; lo Stato non
aveva nè tempo, nè voglia di occuparsi d’Arte. La
feroce democrazia di un ministro confondeva in
divina ignoranza l’autore di «Giambi ed Epòdi »
con Gabriele D’Annunzio. Più isolato, oscillante,
d’ogni altra regione, il Piemonte. E Tu? La casa
piccola, borghese, vegliata da quella dolce «Madre »
che è stata come una benedizione fra le tue pitture.
È il quadro che più ti lega spiritualmente a Leo
nardo Bistolfi ed a Giovanni Cena. In quel pantàno
di scetticismo politico e religioso « Madre » è stata
una seria e taciturna affermazione di sentimento;
è stata come uno schiaffo sulle frolli inerzie d’una
società positivista. Ojetti vi sentì un richiamo a
Carrière. Ma si capisce: Carrière! — Ne avevamo
parlato a lungo sul sofà scapigliato — Carrière ti
era più vicino di quello che non fosse il senatore
Giacomo Grosso così verista, sensuale, impetuoso,
aderente alla materia, che, quando ancora oggi,
guarda una rosa, una stoffa, un frutto se li ribeve
con gli occhi sempre nuovi e sorpresi del fanciullo.
Il mondo, allora, come oggi, è da lui sentito in blocco,
non rinuncia ad uno degli elementi che esistono, che
vede, che conquista con una gioja sensuale da cui
Tu, discepolo, come Mantegna discorde da Squar-
cione, potevi dissentire, ma che un giorno, come il
Padovano, dovrai lasciar filtrare nei tuoi nervi, nelle
corposità dei tuoi colori, nella plastica dei tuoi nudi,
nella ghiotta sostanza delle tue frutta.
Ma, allora, 1900, nell’analisi del tuo spirito, come
per Carrière, ci fu ben altro. Da Wagner a Scho
penhauer, al genio russo era passata una rivolta
romantica contro il gelo del materialismo. Il cul
mine della reazione non poteva essere, per artisti
pieni d’anima, che l ’isolamento. Nelle nostre solitu
dini Tu hai sentito Carrière interrogare liricamente
il futuro, mentre subordinava la venerata formi al
sentimento morale.
Tua «Madre », il.« Fanciullo dalla mela verde »
furono su questo binario, meglio su questa vetta.
Epperciò la visione italiana del tuo tema è anche
un poco quella che s'illumina nel quadro dell’altro,
al Lussemburgo.
Oh, perchè non deve essere bello così? Che cioè
Tu e Carrière abbiate vissuto sullo stesso parallelo?
Michelangelo fu un poco come Jacopo Della Guercia;
Kibera fu un poco come Caravaggio; pure le perso
nalità sono integrali.
Ma ecco; ho fatto un nome che mi dà la gioja
di poter meglio penetrare la tua opera d’artista.
E tanto per dire, rifacciamoci un poco a difen
dere, se pur n’ha bisogno, questo Piemonte pittorico
e pittoresco. Quanta gente ha il vezzo di negare al
Piemonte una individualità estetica! Poche regioni,
invece, hanno sentito con tanta inquietudine il tor
mento della raffinata espressione del colore. Già lo
rivela il periodo eroico dell’acquafòrte ligure-pie
montese del tempo di Rayper e degli altri « Riva
resi ». Esploderà, è vero, nelle pennellate, allora
rivoluzionarie di Pittara; vivrà per la gioia di Pasini,
s’imporrà come problema di luce in Avondo e nel
Ricci; poi sarà trionfale passione piena di capacità
sculturali in Delleani, o zoolianamente cruda ricerca
nel Pascal, o violenza mediterranea nelle marine del
( orsi, in quasi tutto Tavemier e del tutto in Caval
ieri Vittorio.
Esplode quindi il colore nei tripudi e nei misteri
deU’Oriente pasiniano, negli acquosi pendii biellesi
di Delleani, nella sensualissima forza di Giacomo
Grosso. E, poi, di un altro pregio bisogna tener
conto. La pittura piemontese dell’ultimo Ottocento,
come la pittura toscana del Quattrocento, ha sentito
di dover imparare qualcosa dalla scultura. Quassù la
scultura tra Otto e Novecento ha avute ore gaudiose.
!)a Calandra a Bistolfi a Rubino si può dire che la
scultura piemontese, con le sue evidenze tecniche ed i
suoi problemi spirituali abbia tenuto il primato nelle
L a M a d r e 4 1 F a l l e * C ar a u a
arti; ecco perchè la preoccupazione plastica nella
pittura piemontese è logica, particolarmente nel
tempo di cui parliamo, anche a prescindere da
suoi preludii che si potrebbero benissimo rinvenire
nelle tavole di formato minore di artisti antichi,
come Defendente Ferrari; vedi la sala piemontese
della Pinacoteca Reale di Torino.
Ora il Piemonte è lì con i suoi tre C.: Casorati
da Novara, Carrà da Quargnento, Carena da Torino.
In tutti e tre un cerebralismo che li stacca dalla
camerata degli anziani; non dirò qui della ironia,
del senso decorativo in Casorati, nè delle sintesi di
Carrà. Mi preme parlare di Te, dopo questa paren
tesi per vedere di costrurre la tua fisionomia estetica
secondo i miei studi e la mia sensibilità.
L ’ambiente di Carena anteguerra: raccolto in una
piccola casa modesta dove, l ’amore per la Monarchia
e per la Religione era in atto. Soldati: il Babbo, il
fratello e più tardi lui artigliere in linea nella grande
guerra. Preghiera: pietosa cura della Mamma; sacer
dote predicatore: un fratello. Atmosfera affettuosa,
vivere modesto di tutti; in quella vita si matura
la passione del libro, delle riviste belle, l’avidità
della conoscenza, la incontentabilità che lo trae a
varcare i confini del Piemonte e più quello dell'Ac
cademia Albertina, dove Giacomo Grosso può con
durlo soltanto fino alla vigoria del colorito.
Ma Carena è un meditativo; per questo la com
pagnia che cerca è di poeti e di mondi lontani dal
suo. Ripenso le ammirazioni per Burne Jones e più
tardi (vedi certe sue nature morte) per Cèzanne ma
sopra tutto Gaugin e Van Gogh.
In lui ebbero maggiore dominio, anzi predominano
ancora, la poesìa, il raziocinio interiore; la pittura
dovette essergli mezzo non fine.
li
il
34
\\


















