
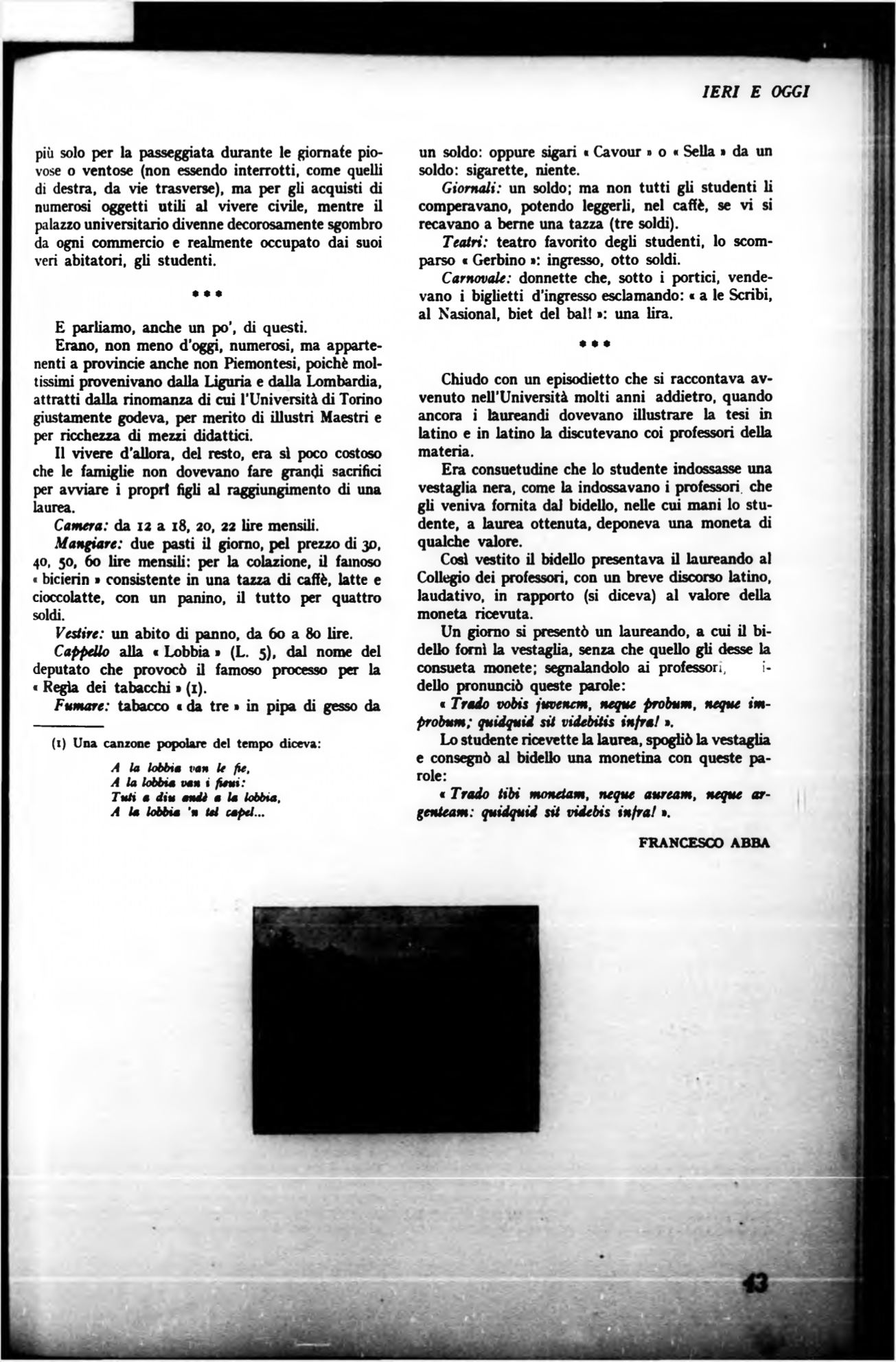
IERI E OGGI
più solo per la passeggiata durante le giornate pio
vose o ventose (non essendo interrotti, come quelli
di destra, da vie trasverse), ma per gli acquisti di
numerosi oggetti utili al vivere civile, mentre il
palazzo universitario divenne decorosamente sgombro
da ogni commercio e realmente occupato dai suoi
veri abitatori, gli studenti.
• • •
E parliamo, anche un po’, di questi.
Erano, non meno d’oggi, numerosi, ma apparte
nenti a provincie anche non Piemontesi, poiché mol
tissimi provenivano dalla Liguria e dalla Lombardia,
attratti dalla rinomanza di cui l’Università di Torino
giustamente godeva, per merito di illustri Maestri e
per ricchezza di mezzi didattici.
Il vivere d ’allora, del resto, era sì poco costoso
che le famiglie non dovevano fare grandi sacrifici
per avviare i propri figli al raggiungimento di una
laurea.
Camera:
da 12 a 18, 20, 22 lire mensili.
Mangiare:
due pasti il giorno, pel prezzo di 30,
40, 50, 60 lire mensili: per la colazione, il famoso
«bicierin » consistente in una tazza di caffè, latte e
cioccolatte, con un panino, il tutto per quattro
soldi.
Vestire:
un abito di panno, da 60 a 80 lire.
Cappello
alla « Lobbia » (L. 5), dal nome del
deputato che provocò il famoso processo per la
«Regia dei tabacchi >(1).
Fumare:
tabacco «da tre » in pipa di gesso da
(1) Una canzone popolare del tempo diceva:
A la lobbia van le fie,
A la lobbia van i fieni:
Tuli a din ondi a la lobbia,
A la lobbia ’n tei capei...
un soldo: oppure sigari «Cavour » o « Sella » da un
soldo: sigarette, niente.
Giornali:
un soldo; ma non tutti gli studenti li
comperavano, potendo leggerli, nel caffè, se vi si
recavano a berne una tazza (tre soldi).
Teatri:
teatro favorito degli studenti, lo scom
parso «Gerbino »: ingresso, otto soldi.
Carnovale:
donnette che, sotto i portici, vende
vano i biglietti d’ingresso esclamando: « a le Scribi,
al Kasional, biet del bai! »: una lira.
• * *
Chiudo con un episodietto che si raccontava av
venuto nell’Università molti anni addietro, quando
ancora i laureandi dovevano illustrare la tesi in
latino e in latino la discutevano coi professori della
materia.
Era consuetudine che lo studente indossasse una
vestaglia nera, come la indossavano i professori, che
gli veniva fornita dal bidello, nelle cui mani lo stu
dente, a laurea ottenuta, deponeva una moneta di
qualche valore.
Così vestito il bidello presentava il laureando al
Collegio dei professori, con un breve discorso latino,
laudativo, in rapporto (si diceva) al valore della
moneta ricevuta.
Un giorno si presentò un laureando, a cui il bi
dello fornì la vestaglia, senza che quello gli desse la
consueta monete; segnalandolo ai professore
i-
dello pronunciò queste parole:
«
Trado vobis juvencm, ncque probum, ncque im-
probum; quidquid sii videbitis infra!
».
Lo studente ricevette la laurea, spogliò la vestaglia
e consegnò al bidello una monetina con queste pa
role:
«
Trado tibi monetam, ncque auream, ncque ar-
genteam: quidquid sii vidcbis infra!
».
FRANCESCO ABBA


















