
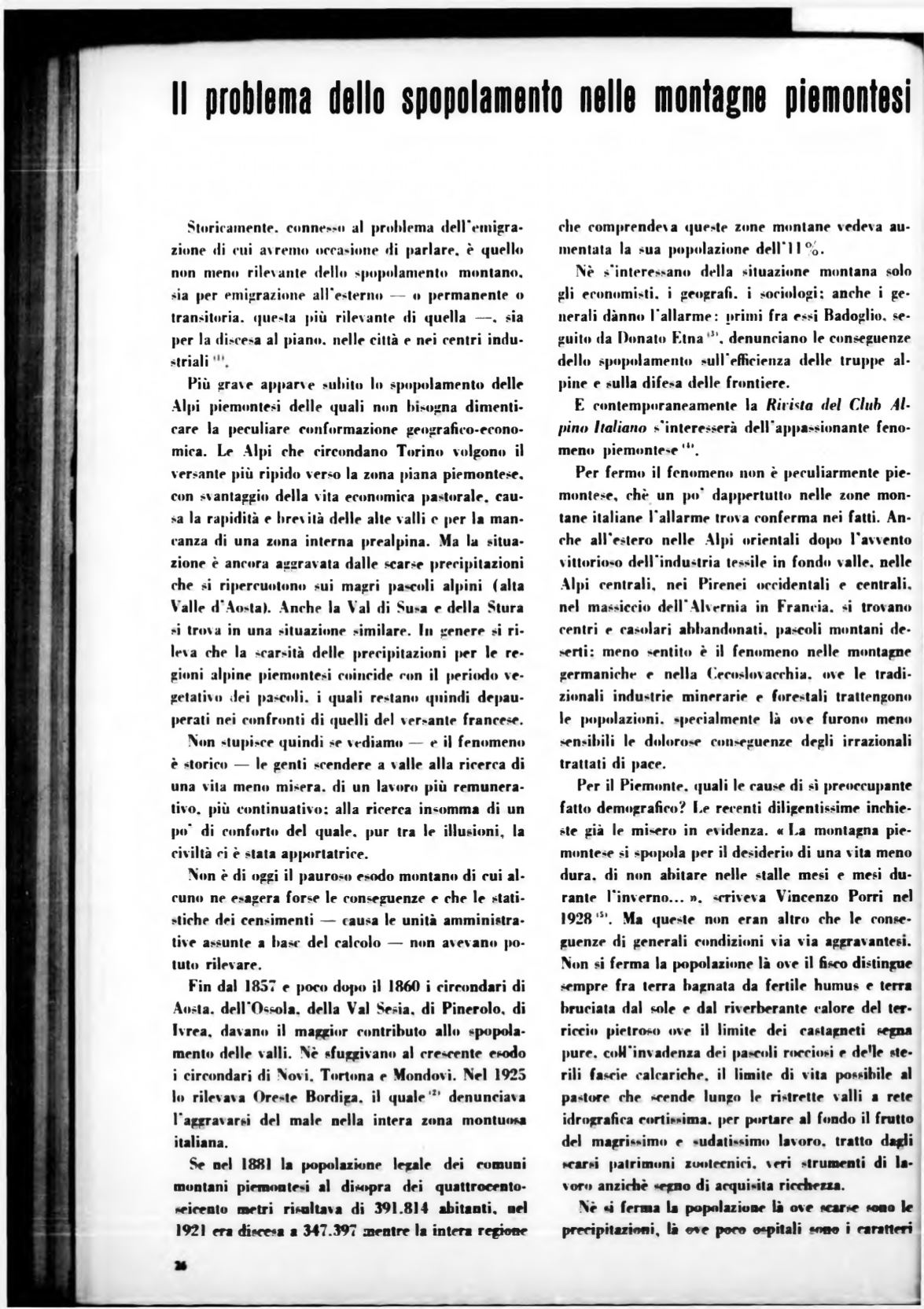
Il problema dello spopolamento nelle montagne piemontesi
Storicamente. connesso al problema dell'emigra
zione di cui avremo ocra-ione di parlare, è quello
non meno rile\ante dello spopolamento montano,
sia per emigrazione all'esterno — o permanente o
transitoria, questa più rilevante di quella —, sia
per la discesa al piano, nelle città e nei centri indu
striali
Più gra\e apparve rullilo lo spopolamento delle
Alpi piemontesi delle quali non Insogna dimenti
care la peculiare conformazione geografico-econo-
mica. Le Alpi che circondano Torino volgono il
versante più ripido verso la zona piana piemontese,
con svantaggio della vita economica pastorale, cau
sa la rapidità e brevità delle alte valli e per la man
canza di una zona interna prealpina. Ma la situa
zione è ancora aggravata dalle scarse precipitazioni
che si ripercuotono sui magri pascoli alpini (alta
\alle d'Aosta). Anche la Val di Susa e della Stura
ri trova in una situazione similare. V
ii
genere si ri
leva che la scarsità delle precipitazioni per le re
gioni alpine piemontesi coincide con il periodo ve
getativo dei pascoli, i quali restano quindi depau
perati nei confronti di quelli del versante francese.
Non stupisce quindi se vediamo — e il fenomeno
è storico — le genti scendere a valle alla ricerca di
una vita meno misera, di un lavoro più remunera
tivo. più continuativo: alla ricerca ingomma di un
po' di conforto del quale, pur tra le illusioni, la
civiltà ci è stata ap|n>rtatrice.
Non è di oggi il pauroso esodo montano di cui al
cuno ne esagera forse le conseguenze e che le stati
stiche dei censimenti — causa le unità amministra
tive assunte a base del calcolo — non avevano po
tuto rilevare.
Fin dal 1857 e poco dopo il 1860 i circondari di
Aosta. dell'Ossola. della Val Sesia, di Pinerolo, di
Ivrea, davano il maggior contributo allo spopola
mento delle valli. Nè sfuggivano al crescente esodo
i circondari di Novi. Tortona e Mondovi. Nel 1925
lo rilevava Oreste Bordiga. il quale'2' denunciava
l'aggravarsi del male nella intera zona montuosa
italiana.
Se nel 1881 la popolazione legale dei comuni
montani piemontesi al dis«»pra dei quattrocento-
seicento metri risultava di 391.814 abitanti, nel
1921 era discesa a 347.397 mentre la intera regione
che comprendeva queste zone montane vedeva au
mentata la sua popolazione dell*ll%.
Nè s'interessano della situazione montana solo
gli economisti, i geografi, i sociologi; anche i ge
nerali dànno l'allarme: primi fra essi Badoglio, se
guito da Donato Etna ". denunciano le conseguenze
dello spopolamento suH'efficienza delle truppe al
pine e sulla difesa delle frontiere.
E contemporaneamente la
Rivinta ilei Club Al
pini» Italiano
s'interesserà dell'appassionante feno
meno piemontese'**.
Per fermo il fenomeno non è peculiarmente pie
montese, chè un po' dappertutto nelle zone mon
tane italiane l'allarme trova conferma nei fatti. An
che all'estero nelle Alpi orientali dopo l'avvento
vittorioso dell'industria tessile in fondo valle, nelle
Alpi centrali, nei Pirenei occidentali e centrali,
nel massiccio deH'Alvernia in Francia, si trovano
centri e casolari abbandonati, pascoli montani de
serti: meno sentito è il fenomeno nelle montagne
germaniche e nella Cecoslovacchia, ove le tradi
zionali industrie minerarie e forestali trattengono
le popolazioni, specialmente là ove furono meno
sensibili le dolorose conseguenze degli irrazionali
trattati di pace.
Per il Piemonte, quali le cause di sì preoccupante
fatto demografico? Le recenti diligentissime inchie
ste già le misero in evidenza. « La montagna pie
montese si spopola per il desiderio di una vita meno
dura, di non abitare nelle stalle mesi e mesi du
rante l'inverno... ». scriveva Vincenzo Porri nel
1928,s’. Ma queste non eran altro che le conse
guenze di generali condizioni via via aggravante».
Non si ferma la popolazione là ove il fisco distingue
sempre fra terra bagnata da fertile humus e terra
bruciata dal sole e dal riverberante calore del ter
riccio pietroso ove il limite dei castagneti segna
pure. coU'invadenza dei pascoli ri»cciosi e de’le ste
rili fascie calcariche. il limite di vita possibile al
pastore che scende lungo le ristrette valli a rete
idrografica cortissima, per portare al fondo il frutto
del magrissimo e sudatissimo lavoro, tratto dagli
scarsi patrimoni zootecnici, veri strumenti di la
voro anziché segno di acquisita ricchezza.
Nè «i ferma la popolazione là ove scarse sono le
precipitazioni, là ove poco ospitali «ooo i caratteri


















