
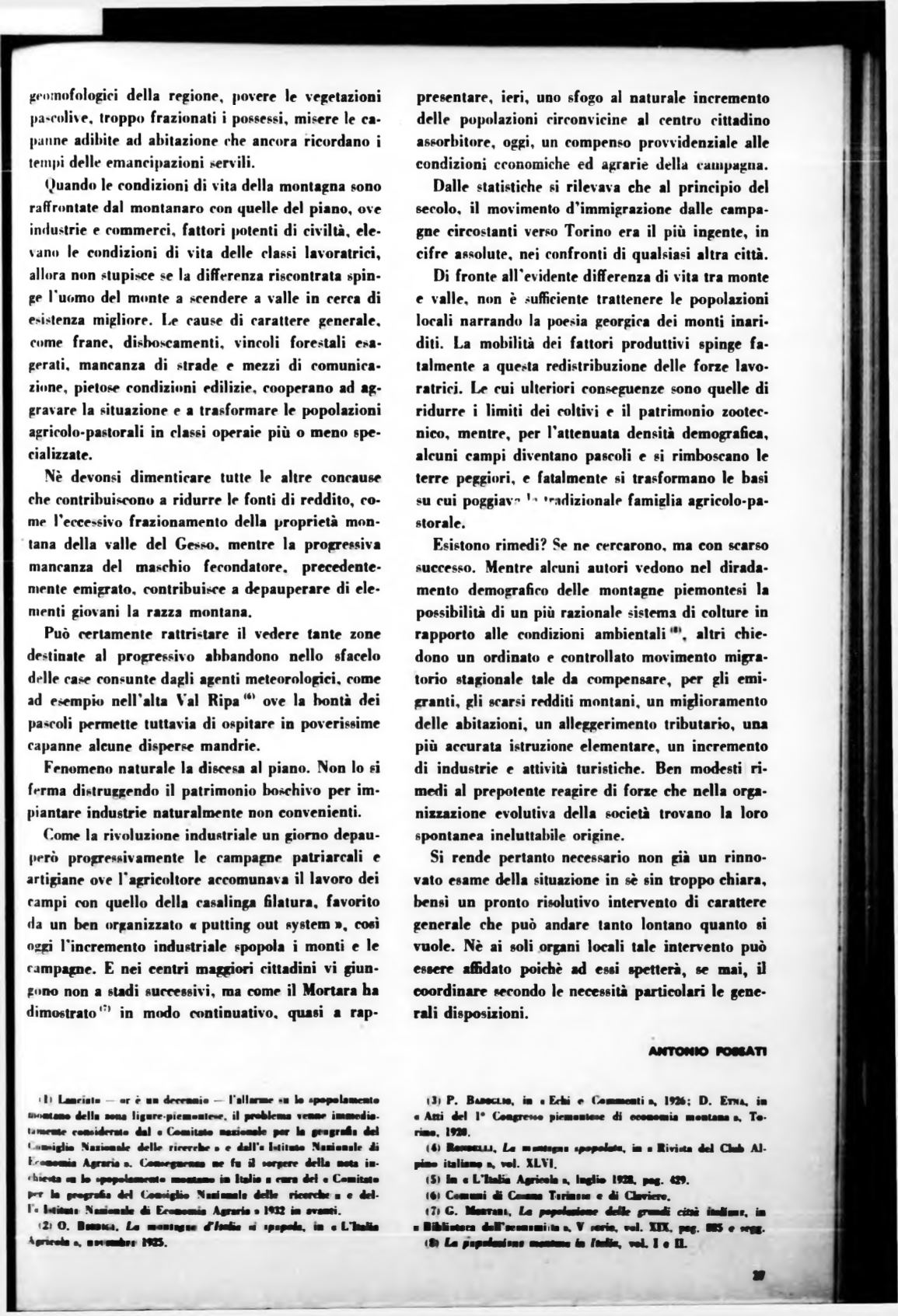
pteomofologici della regione, povere le vegetazioni
l>a«<*oli\e, troppo frazionati i possessi, misere le ca-
panne adibite ad abitazione che ancora ricordano i
tempi delle emancipazioni servili.
Ouando le condizioni di vita della montagna sono
raffrontate dal montanaro con quelle del piano, ove
industrie e commerci, fattori potenti di civiltà, ele
vano le condizioni di vita delle classi lavoratrici,
allora non stupisce se la differenza riscontrata spin
ge l'uomo del monte a scendere a valle in cerca di
esistenza migliore. Le cause di carattere generale,
come frane, disboscamenti, vincoli forestali esa
gerati, mancanza di strade e mezzi di comunica
zione, pietose condizioni edilizie, cooperano ad ag
gravare la situazione e a trasformare le popolazioni
agricolo-pastorali in classi operaie più o meno spe
cializzate.
Nè devonsi dimenticare tutte le altre concause
che contribuiscono a ridurre le fonti di reddito, co
me l'eccessivo frazionamento della proprietà mon
tana della valle del Cesso, mentre la progressiva
mancanza del maschio fecondatore, precedente-
niente emigrato, contribuisce a depauperare di ele
menti giovani la razza montana.
Può certamente rattristare il vedere tante zone
destinate al progressivo abbandono nello sfacelo
delle case consunte dagli agenti meteorologici, come
ad esempio nell'alta Val Ripa “* ove la bontà dei
pascoli permette tuttavia di ospitare in poverissime
capanne alcune disperse mandrie.
Fenomeno naturale la discesa al piano. Non lo si
ferma distruggendo il patrimonio boschivo per im
piantare industrie naturalmente non convenienti.
Come la rivoluzione industriale un giorno depau
però progressivamente le campagne patriarcali e
artigiane ove l'agricoltore accomunava il lavoro dei
campi con quello della casalinga filatura, favorito
da un ben organizzato « putting out system », così
oggi l'incremento industriale spopola i monti e le
campagne. E nei centri maggiori cittadini vi giun
gono non a stadi successivi, ma come il Mortara ha
dimostrato<7> in modo continuativo, quasi a rap
presentare, ieri, uno sfogo ai naturale incremento
delle popolazioni circonvicine al centro cittadino
assorbitore, oggi, un compenso provvidenziale alle
condizioni economiche ed agrarie della campagna.
Dalle statistiche si rilevava che al principio del
secolo, il movimento d'immigrazione dalle campa
gne circostanti verso Torino era il più ingente, in
cifre assolute, nei confronti di qualsiasi altra città.
Di fronte all'evidente differenza di vita tra monte
e valle, non è sufficiente trattenere le popolazioni
locali narrando la poesia georgica dei monti inari
diti. La mobilità dei fattori produttivi spinge fa
talmente a questa redistribuzione delle forze lavo
ratrici. Le cui ulteriori conseguenze sono quelle di
ridurre i limiti dei coltivi e il patrimonio zootec
nico, mentre, per l'attenuata densità demografica,
alcuni campi diventano pascoli e si rimboscano le
terre peggiori, e fatalmente si trasformano le basi
su cui poggiav*' ' • *r.idizionale famiglia agricolo-pa-
storale.
Esistono rimedi? Se ne cercarono, ma con scarso
successo. Mentre alcuni autori vedono nel dirada
mento demografico delle montagne piemontesi la
possibilità di un più razionale sistema di colture in
rapporto alle condizioni ambientali
altri chie
dono un ordinato e controllato movimento migra
torio stagionale tale da compensare, per gli emi
granti, gli scarsi redditi montani, un miglioramento
delle abitazioni, un alleggerimento tributario, una
più accurata istruzione elementare, un incremento
di industrie e attività turistiche. Ben modesti ri
medi al prepotente reagire di forze che nella orga
nizzazione evolutiva della società trovano la loro
spontanea ineluttabile origine.
Si rende pertanto necessario non già un rinno
vato esame della situazione in sè sin troppo chiara,
bensì un pronto risolutivo intervento di carattere
generale che può andare tanto lontano quanto si
vuole. Nè ai soli organi locali tale intervento può
essere affidato poiché ad essi spetterà, se mai, il
coordinare secondo le necessità particolari le gene
rali disposizioni.
ANTONIO POSSATI
• 1 • Lancialo—or è un drrrwio —l'allarme *u lo «popolamento
I'X
i
M
mh
della tona lijurc-piem«nie»e. il problema venne immedlia-
t-intenteconsideralo dal • Comitato nazionale per la p agraia dei
<>n*iglio Nazionale delle ricerche• e dall*» latitato N«rionale di
^•ataia Afrana a. Cmwfwmi ne fa il torgere della nata in-
<biHa
m
lo «popolamento montano in Italia aenra del «Comitato
per la papaia del CntHigUo Natianale delle ricard» a e del-
I* I tif a Nmanale di Enaoma Agraria• l«S2 Iti arasti.
<* O. B—Ut. La manici,
f h
afta «a .papaia, m « L'Italia
ttrMofaa.
mutmktt
H».
IJi P. Binatila, in • Echi e (/otinnenti a, 192*; D. Ent, in
aAni del 1*
C—
grama piemontese di economia montanaa, To
rino. 1920.
(4) a— 111, La nawapa ipnpalata, in aRivista del CU Al-
pino italiano a, voi. XLVI.
(Si la aL'Italia Aprica laa. Inolio 192*. pag. 429.
<*i Cininni di CeaatmTarma» • di Ckviere.
IT*C. Marnai.
Lmpmpmlmimmr
delle grandi
dai
ttahaar, in
aBiliaten delTaranimiitaa. V («ria, vai. XIX. paf. MS * tegg.
<S»
Lm
papalarian» amnaaaafa Italia, tal I c IL
W


















