
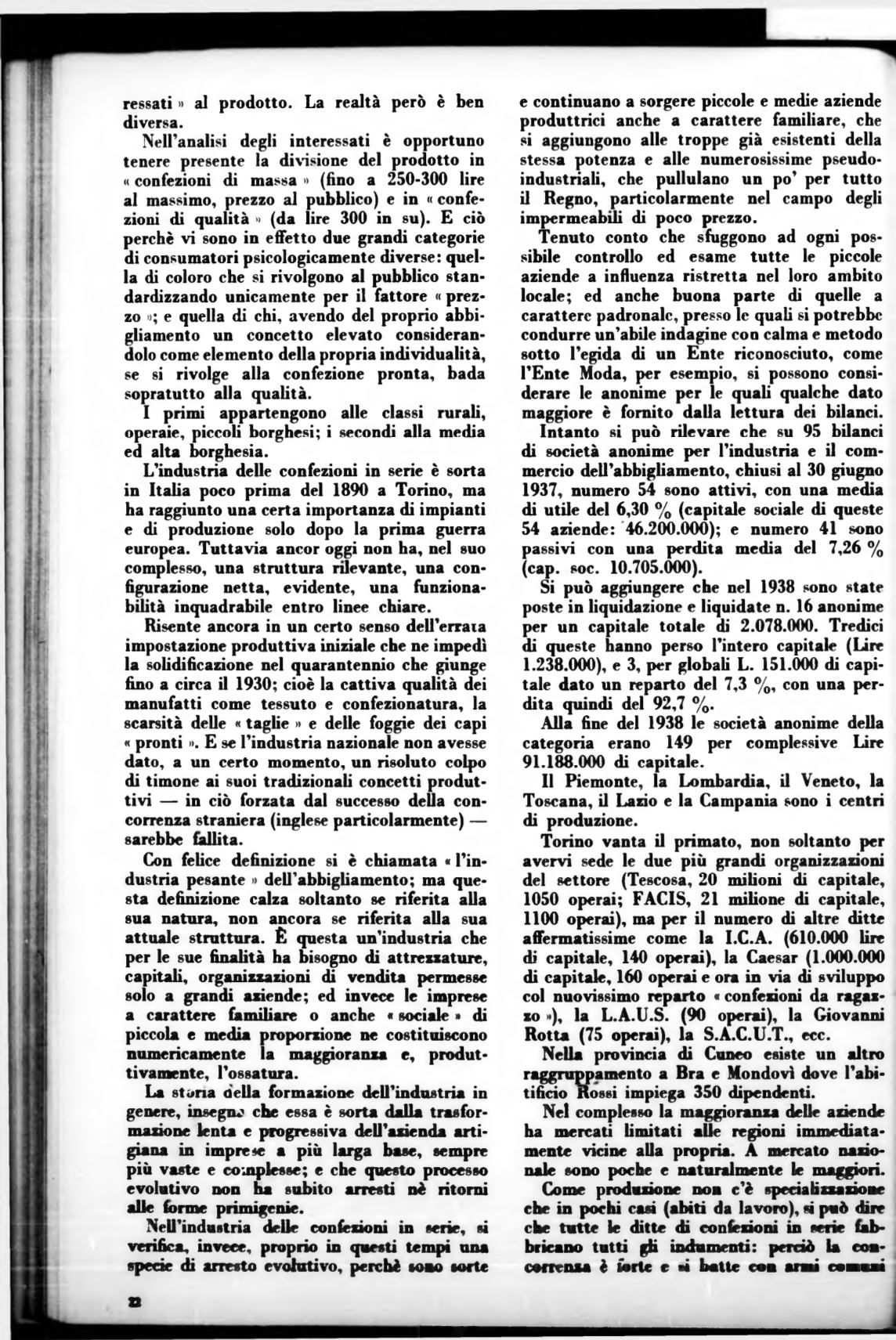
ressati » al prodotto. La realtà però è ben
diversa.
Nell’analisi degli interessati è opportuno
tenere presente la divisione del prodotto in
« confezioni di massa » (fino a 250-300 lire
al massimo, prezzo al pubblico) e in « confe
zioni di qualità » (da lire 300 in su). E ciò
perchè vi sono in effetto due grandi categorie
di consumatori psicologicamente diverse: quel
la di coloro che si rivolgono al pubblico stan
dardizzando unicamente per il fattore « prez
zo »; e quella di chi, avendo del proprio abbi
gliamento un concetto elevato consideran
dolo come elemento della propria individualità,
se si rivolge alla confezione pronta, bada
sopratutto alla qualità.
I
primi appartengono alle classi rurali,
operaie, piccoli borghesi; i secondi alla media
ed alta borghesia.
L'industria delle confezioni in serie è sorta
in Italia poco prima del 1890 a Torino, ma
ha raggiunto una certa importanza di impianti
e di produzione solo dopo la prima guerra
europea. Tuttavia ancor oggi non ha, nel suo
complesso, una struttura rilevante, una con
figurazione netta, evidente, una funziona-
bilità inquadrabile entro linee chiare.
Risente ancora in un certo senso dell'erraia
impostazione produttiva iniziale che ne impedì
la solidificazione nel quarantennio che giunge
fino a circa il 1930; cioè la cattiva qualità dei
manufatti come tessuto e confezionatura, la
scarsità delle « taglie » e delle foggie dei capi
« pronti ». E se l'industria nazionale non avesse
dato, a un certo momento, un risoluto colpo
di timone ai suoi tradizionali concetti produt
tivi — in ciò forzata dal successo della con
correnza straniera (inglese particolarmente) —
sarebbe fallita.
Con felice definizione si è chiamata « l'in
dustria pesante » dell'abbigliamento; ma que
sta definizione calza soltanto se riferita alla
sua natura, non ancora se riferita alla sua
attuale struttura. È questa un'industria che
per le sue finalità ha bisogno di attrezzature,
capitali, organizzazioni di vendita permesse
solo a grandi aziende; ed invece le imprese
a carattere familiare o anche « sociale » di
piccola e media proporzione ne costituiscono
numericamente la maggioranza e, produt
tivamente, l'ossatura.
La stana della formazione dell'industria in
genere, insegna che essa è sorta dalla trasfor
mazione lenta e progressiva dell'azienda arti
giana in imprese a più larga base, sempre
più vaste e complesse; e che questo processo
evolutivo non ha subito arresti nè ritorni
alle forme primigenie.
Nell'industria delle confezioni in serie, si
verifica, invece, proprio in questi tempi una
specie di arresto evolutivo, perchè sono torte
a
e continuano a sorgere piccole e medie aziende
produttrici anche a carattere familiare, che
si aggiungono alle troppe già esistenti della
stessa potenza e alle numerosissime pseudo
industriali, che pullulano un po' per tutto
il Regno, particolarmente nel campo degli
impermeabili di poco prezzo.
Tenuto conto che sfuggono ad ogni pos
sibile controllo ed esame tutte le piccole
aziende a influenza ristretta nel loro ambito
locale; ed anche buona parte di quelle a
carattere padronale, presso le quali si potrebbe
condurre un'abile indagine eoa calma e metodo
sotto l'egida di un Ente riconosciuto, come
l'Ente Moda, per esempio, si possono consi
derare le anonime per le quali qualche dato
maggiore è fornito dalla lettura dei bilanci.
Intanto si può rilevare che su 95 bilanci
di società anonime per l'industria e il com
mercio dell'abbigliamento, chiusi al 30 giugno
1937, numero 54 sono attivi, con una media
di utile del 6,30 % (capitale sociale di queste
54 aziende: 46.200.000); e numero 41 sono
passivi con una perdita media del 7,26 %
(cap. soc. 10.705.000).
Si può aggiungere che nel 1938 sono state
poste in liquidazione e liquidate n. 16 anonime
per un capitale totale di 2.078.000. Tredici
di queste hanno perso l'intero capitale (Lire
1.238.000), e 3, per globali L. 151.000 di capi
tale dato un reparto del 7,3 %, con una per
dita quindi del 92,7 %.
Alla fine del 1938 le società anonime della
categoria erano 149 per complessive Lire
91.188.000 di capitale.
Il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, la
Toscana, il Lazio e la Campania sono i centri
di produzione.
Torino vanta il primato, non soltanto per
avervi sede le due più grandi organizzazioni
del settore (Tescosa, 20 milioni di capitale,
1050 operai; FACIS,
2 1
milione di capitale,
1100
operai), ma per il numero di altre ditte
affermatissime come la I.C.A. (610.000 lire
di capitale, 140 operai), la Caesar (1.000.000
di capitale, 160 operai e ora in via di sviluppo
col nuovissimo reparto « confezioni da ragaz
zo »), la L.A.U.S. (90 operai), la Giovanni
Rotta (75 operai), la S.A.C.U.T., ecc.
Nella provincia di Cuneo esiste un altro
raggruppamento a Bra e Mondovì dove l'abi-
tificio fiossi impiega 350 dipendenti.
Nel complesso la maggioranza delle aziende
ha mercati limitati alle regioni immediata
mente vicine alla propria. A mercato nazio
nale sono poche e naturalmente le maggiori.
Come produzione non c'è specializzazione
che in pochi casi (abiti da lavoro), si può dire
che tutte le ditte di confezioni in serie fab
bricano tutti gli indumenti: perciò la con
correnza è forte e ai batte con anni comuni


















