
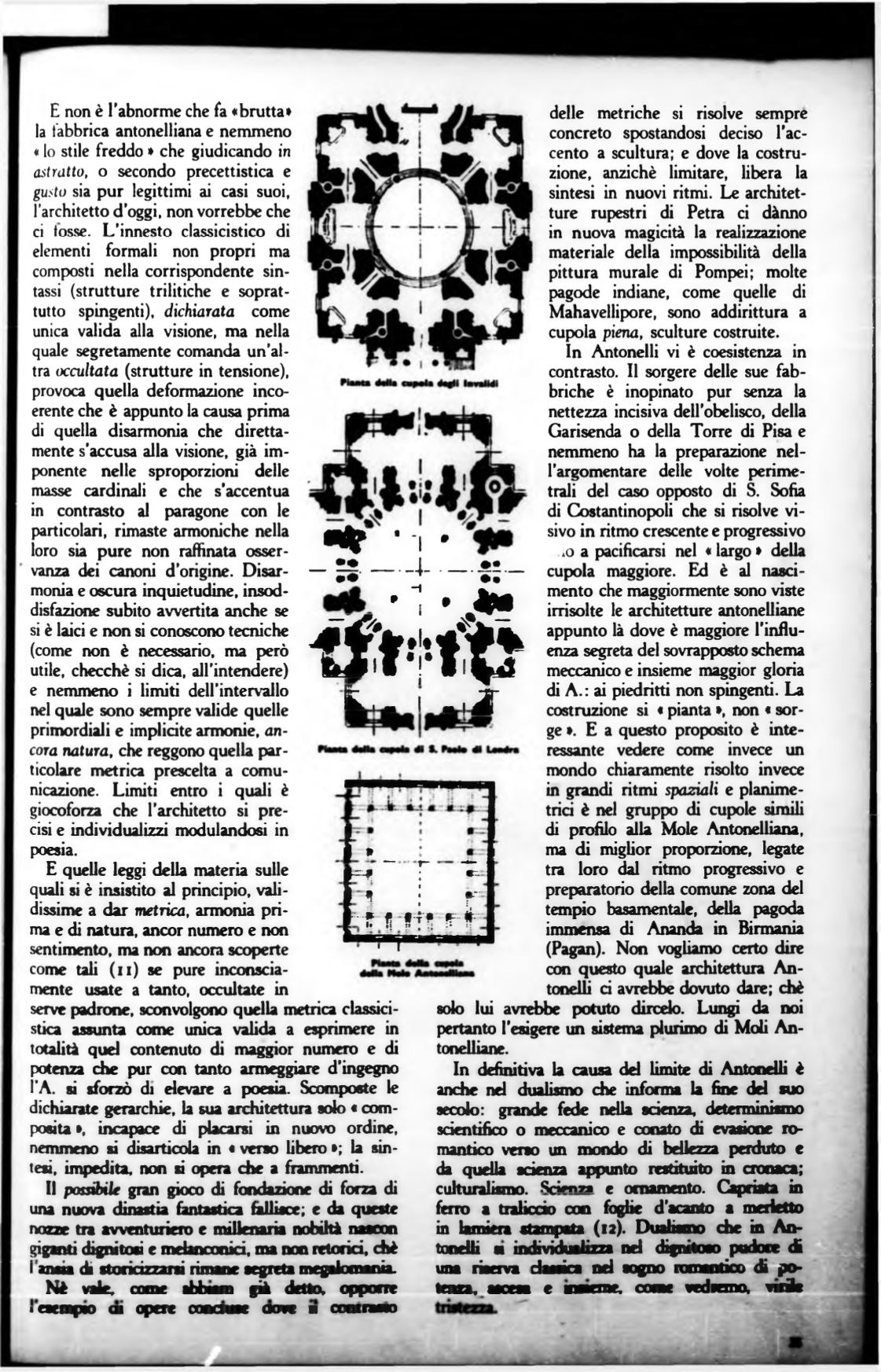
E non è l’abnorme che fa «brutta*
la fabbrica antonelliana e nemmeno
«lo stile freddo » che giudicando in
astratto,
o
secondo precettistica e
gusto
sia pur legittimi ai casi suoi,
l’architetto d ’oggi, non vorrebbe che
ci tosse. L ’innesto classicistico di
elementi formali non propri ma
composti nella corrispondente sin
tassi (strutture trilitiche e soprat
tutto spingenti),
dichiarata
come
unica valida alla visione, ma nella
quale segretamente comanda un’al
tra
occultata
(strutture in tensione),
provoca quella deformazione inco
erente che è appunto la causa prima
di quella disarmonia che diretta-
mente s’accusa alla visione, già im
ponente nelle sproporzioni delle
masse cardinali e che s’accentua
in contrasto al paragone con le
particolari, rimaste armoniche nella
loro sia pure non raffinata osser
vanza dei canoni d’origine. Disar
monia e oscura inquietudine, insod
disfazione subito avvertita anche se
si è laici e non si conoscono tecniche
(come non è necessario, ma però
utile, checché si dica, all'intendere)
e nemmeno i limiti deU’intervallo
nel quale sono sempre valide quelle
primordiali e implicite armonie,
an
cora natura,
che reggono quella par
ticolare metrica prescelta a comu
nicazione. Limiti entro i quali è
giocoforza che l’architetto si pre
cisi e individualizzi modulandosi in
poesia.
E quelle leggi della materia sulle
quali si è insistito al principio, vali
dissime a dar
metrica,
armonia pri
ma e di natura, ancor numero e non
sentimento, ma non ancora scoperte
come tali ( i i ) se pure inconscia
mente usate a tanto, occultate in
serve padrone, sconvolgono quella metrica classici
stica assunta come unica valida a esprimere in
totalità quel contenuto di maggior numero e di
potenza che pur con tanto armeggiare d’ingegno
l'A. si sforzò di elevare a poesia. Scomposte le
dichiarate gerarchie, la sua architettura solo « com
posita », incapace di placarsi in nuovo ordine,
nemmeno si disarticola in « verso Ubero »; la sin
tesi, impedita, non si opera che a frammenti.
Il
passibile
gran gioco di fondazione di forza di
una
nuova dinastia fantastica fallisce; e da queste
nozze tra avventuriero e millenaria nobiltà nascon
giganti dignitosi e melanconici, ma non retorici, cfaè
i
ansu di stohdzzani rimane segreta megalomania.
Nè vale, come
tbbum
già dello, appone
•esempio ai opere concime oowe ■ contrasto
delle metriche si risolve sempre
concreto spostandosi deciso l’ac
cento a scultura; e dove la costru
zione, anziché limitare, libera la
sintesi in nuovi ritmi. Le architet
ture rupestri di Petra ci dànno
in nuova magicità la realizzazione
materiale della impossibilità della
pittura murale di Pompei; molte
pagode indiane, come quelle di
Mahavellipore, sono addirittura a
cupola
piena,
sculture costruite.
In Antonelli vi è coesistenza in
contrasto. Il sorgere delle sue fab
briche è inopinato pur senza la
nettezza incisiva dell’obelisco, della
Garisenda o della Torre di Pisa e
nemmeno ha la preparazione nel-
l’argomentare delle volte perime
trali del caso opposto di S. Sofìa
di Costantinopoli che si risolve vi
sivo in ritmo crescente e progressivo
.o a pacificarsi nel « largo » della
cupola maggiore. Ed è al nasci
mento che maggiormente sono viste
irrisolte le architetture antonelliane
appunto là dove è maggiore l’influ
enza segreta del sovrapposto schema
meccanico e insieme maggior gloria
di A .: ai piedritti non spingenti. La
costruzione si «pianta *, non « sor
ge *. E a questo proposito è inte
ressante vedere come invece un
mondo chiaramente risolto invece
in grandi ritmi
spaziali
e pianime
trici è nel gruppo di cupole simili
di profilo alla Mole Antonelliana,
ma di miglior proporzione, legate
tra loro dal ritmo progressivo e
preparatorio della comune zona del
tempio basamentale, della pagoda
immensa di Ananda in Birmania
(Pagan). Non vogliamo certo dire
con questo quale architettura An
tonelli d avrebbe dovuto dare; chè
solo lui avrebbe potuto dircelo. Lungi da noi
pertanto l’esigere un sistema plurimo di Moli An
tonelliane.
In definitiva la causa del limite di Antonelli
è
anche nel dualismo che informa la fine del suo
secolo: grande fede nella scienza, determinismo
scientifico o meccanico e conato di evasione ro
mantico verso un mondo di bellezza perduto
e
da quella scienza appunto restituito in
cronaca;
culturalismo. SfiwiM e ornamento.
Capriata in
ferro
a traliccio con
foglie
d’acanto a
merletto
in
lamiera stampata
(
12
).
Dualismo che in An
tonelli
m
individualizza nel dignitoso pudore di
una riserva r lw in nel sogno mmwtico di po
tenza, ascesa e materne, come vedremo, virile
* *
’ -l
*
- 3 — -
4
- — 4 5 -
’ 1 •
J »
m
m
L, .
1
. i ^r
*
_
i=*
r
t
1
« :
r
i t m r t
• r
*


















