
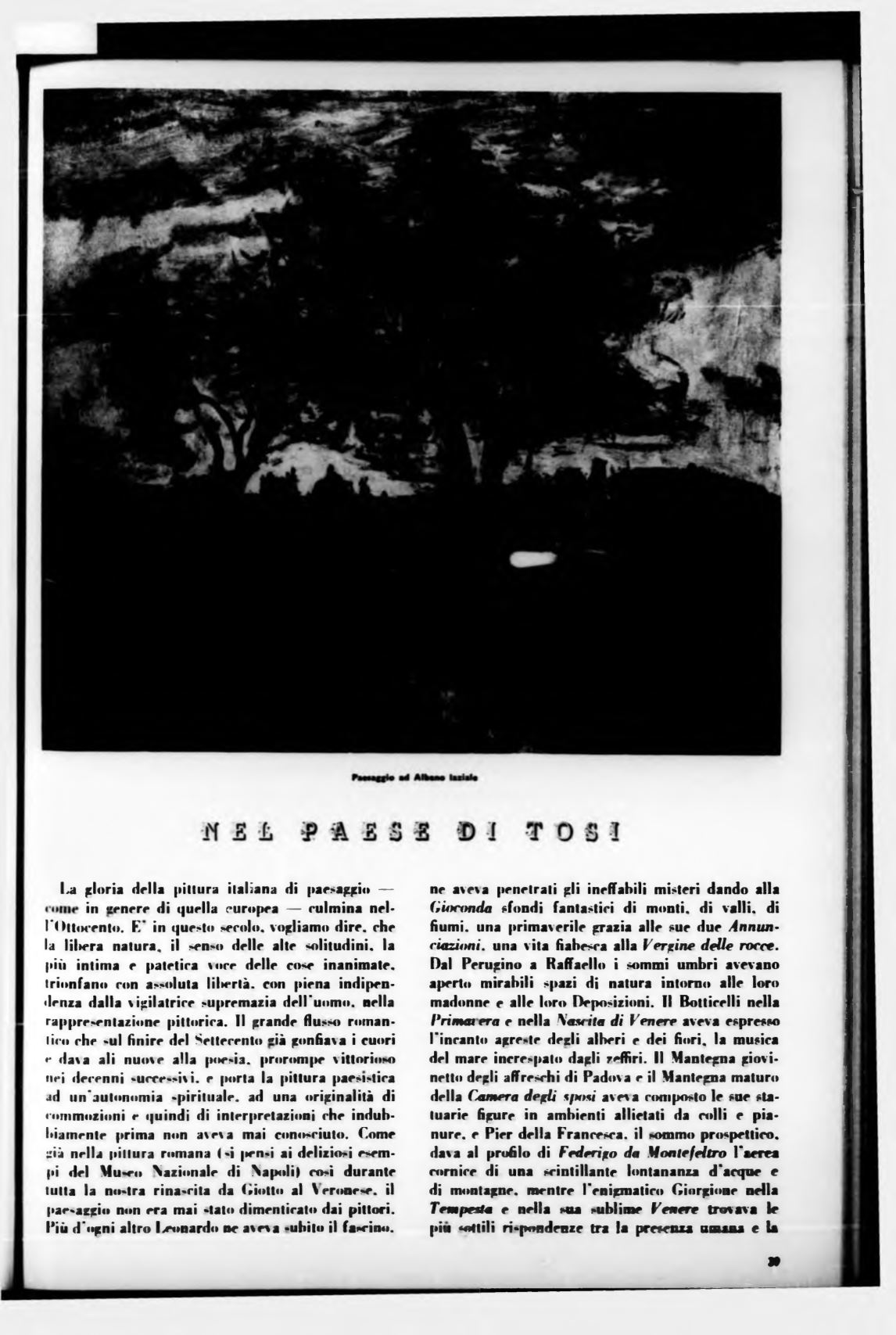
La gloria della pittura italiana di paesaggio —
in •'«•neri* di quella europea — culmina nel*
l'Ottocento. K in questo secolo. vogliamo dire, rhe
la liltera natura, il senso delle alte solitudini, la
più intima e patetica \oce delle cose inanimate,
trionfano con assoluta lilwrtà. con piena indipen-
•lenza dalla vipilatrice supremazia dell'uomo. nella
rappresentazione pittorica. Il grande flusso roman
i c o che sul finire del Settecento "ià gonfiava i cuori
e
da\a ali nuove alla poesia, prorompe vittorioso
nei decenni successivi. e porta la pittura paeM^ica
ad un'autonomia «pirituale, ad una originalità di
commozioni e quindi di interpretazioni che indub
biamente prima non a\c\a mai con<»sciuto. dome
già nella pittura romana I «i |*en«i ai deliziosi esem
pi del Mu«eo Nazionale di Napoli) cosi durante
tutta la nostra rinascita da (biotto al \ eroncse. il
|»ae-as?io non era mai -tato dimenticato dai pittori.
Più d'ogni altro I.conardo n r a m a •ubilo il fascino.
ne aveva penetrali pii ineffabili misteri dando alla
(gioconda
sfondi fantastici di monti, di valli, di
fiumi, una primaverile grazia alle sue due
Annuii-
dazioni,
una vita fiabesca alla
Vergine delle rocce.
Dal Perugino a Raffaello i sommi umbri avevano
aperto mirabili spazi di natura intorno alle loro
madonne e alle loro Deposizioni. Il Botticelli nella
Primai era
e nella
Ramila di Venere
aveva espresso
l'incanto aprente degli alberi e dei fiori, la musica
del mare increspato dagli seffiri. Il Mantella giovi
netto degli affreschi di Padova e il Mantegna maturo
della
Camera degli s/tosi
aveva composto le sue sta
tuarie fipure in ambienti allietati da colli e pia
nure. e Pier della Francesca, il sommo prospettico,
dava al profilo di
Federigo da Montefeltro
l'aerea
cornice di una scintillante lontananza d'acque e
di montagne. mentre l'enigmatico Giorgione nella
Temftesta
e nella sua sublime
Venere
trovava le
pia cottili rispondenze tra la presenza umana e la
9


















