
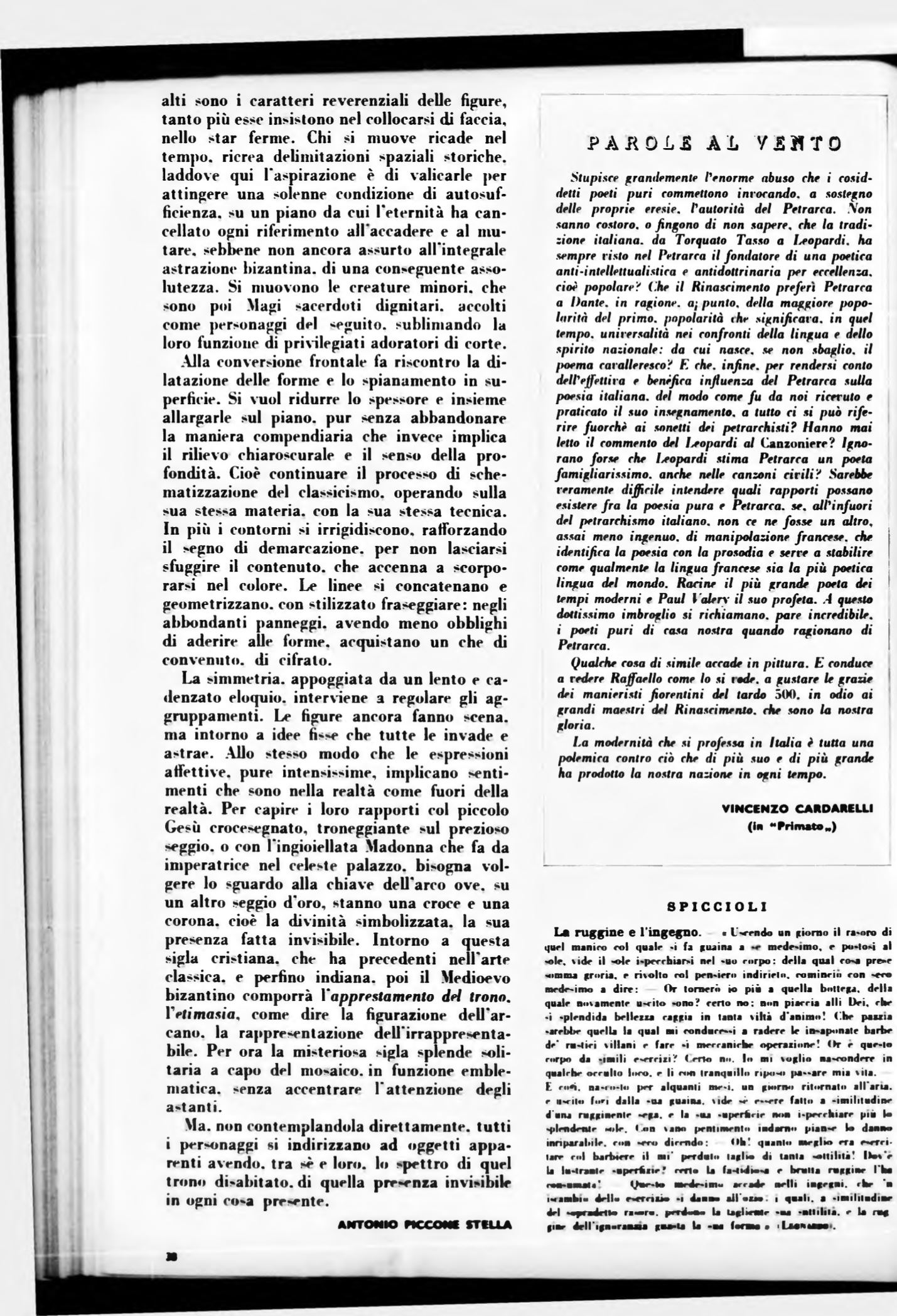
PAROLA AL
Y I H T O
alti sono i caratteri reverenziali delle figure,
tanto più esse insistono nel collocarsi di faccia,
nello star ferme. Chi si muove ricade nel
tempo, ricrea delimitazioni spaziali storiche,
laddove qui l'aspirazione è di valicarle per
attingere una solenne condizione di autosuf
ficienza, su un piano da cui l'eternità ha can-
celiato ogni riferimento all accadere e al mu
tare. sebbene non ancora assurto all'integrale
astrazione bizantina, di una conseguente asso
lutezza. Si muovono le creature minori, che
sono poi Magi sacerdoti dignitari, accolti
come personaggi del seguito, sublimando la
loro funzione di privilegiati adoratori di corte.
Alla conversione frontale fa riscontro la di
latazione delle forme e lo spianamento in su
perficie. Si vuol ridurre lo spessore e insieme
allargarle sul piano, pur senza abbandonare
la maniera compendiaria che invece implica
il rilievo chiaroscurale e il senso della pro
fondità. Cioè continuare il processo di sche
matizzazione del classicismo, operando sulla
sua stessa materia, con la sua stessa tecnica.
In più i contorni si irrigidiscono, rafforzando
il segno di demarcazione, per non lasciarsi
sfuggire il contenuto, che accenna a scorpo
rarsi nel colore. Le linee si concatenano e
geometrizzano, con stilizzato fraseggiare: negli
abbondanti panneggi, avendo meno obblighi
di aderire alle forme, acquistano un che di
convenuto, di cifralo.
La simmetria, appoggiata da un lento e ca
denzato eloquio, interviene a regolare gli ag
gruppamenti. Le figure ancora fanno scena,
ma intorno a idee fisse che tutte le invade e
astrae. Allo stesso modo che le espressioni
affettive, pure intensissime, implicano senti
menti che sono nella realtà come fuori della
realtà. Per capire i loro rapporti col piccolo
Gesù crocesegnato, troneggiante sul prezioso
seggio, o con l'ingioiellata Madonna che fa da
imperatrice nel celeste palazzo, bisogna vol
gere lo sguardo alla chiave dell'arco ove. su
un altro seggio d'oro, stanno una croce e una
corona, cioè la divinità simbolizzata, la sua
presenza fatta invisibile. Intorno a questa
sigla cristiana, che ha precedenti nell'arte
classica, e perfino indiana, poi il Medioevo
bizantino comporrà
Yapprestamento del irono.
Yetimasia
, come dire la figurazione dell'ar
cano. la rappresentazione dell'irrappresenta-
bile. Per ora la misteriosa sigla splende soli
taria a capo del molaico. in funzione emble
matica. senza accentrare l'attenzione degli
aitanti.
Ma. non contemplandola direttamente, tutti
i personaggi si indirizzano ad oggetti appa
renti avrndo. tra sè e loro, lo spettro di quel
trono disabitato, di quella presenza invisibile
in ogni co*>a predente.
ANTONIO PICCONI STILLA
Stupisce grandemente l'enorme abuso che i cosid
detti poeti puri commettono invocando, a sostegno
delle proprie eresie, l'autorità del Petrarca.
Son
sanno costoro, o fingono di non sapere, che la tradi
zione italiana, da Torquato Tasso a Leopardi, ha
sempre visto nel Petrarca il fondatore di una poetica
anti-intellettualistica e antidottrinaria per eccellenza,
cioè popolareY Che il Rinascimento preferì Petrarca
a Dante, in ragione,
a;
punto, della maggiore popo
larità del primo, popolarità
thè
significava, in quel
tempo, universalità nei confronti della lingua e dello
spirito nazionale: da cui nasce, se non sbaglio, il
[toema cavallerescoY E che. infine, per rendersi conto
dell'effettiva e benefica influenza del Petrarca sulla
poesia italiana, del modo come fu da noi ricevuto e
praticato il suo insegnamento, a tutto ci si può rife
rire fuorché ai sonetti dei petrarchisti? Hanno mai
letto il commento del leopardi al
Canzoniere?
Igno
rano forse che leopardi stima Petrarca un poeta
famigliarissimo. anche nelle canzoni civiliY Sarebbe
veramente difficile intendere quali rapporti possano
esistere fra la poesia pura e Petrarca, se. all'infuori
del petrarchismo italiano, non ce ne fosse un altro,
assai meno ingenuo, di manipolazione francese, che
identifica la poesia con la prosodia e serre a stabilire
come qualmente la lingua francese sia la più poetica
lingua del mondo. Racine il più grande poeta dei
tempi moderni e Paul l ’alery il suo profeta. A questo
dottissimo imbroglio si richiamano, pare incredibile,
i poeti puri di casa nostra quando ragionano di
Petrarca.
Qualche cosa di simile accade in pittura. E conduce
a vedere Raffaello come lo si t «de. a gustare le grazie
dei manieristi fiorentini del tardo
500. in
odio ai
grandi maestri del Rinascimento, che sono la nostra
gloria.
La modernità che si professa in Italia è tutta una
polemica contro ciò che di più suo e di più grande
ha prodotto la nostra nazione in ogni tempo.
VINCENZO CARDARELLI
(in “ Primato „ )
S P I C C I O L I
La ruggine e l’ingegno.
« IV rndo un giorno il ra-oro di
quel manico col quale *i fa guaina a
mede-imo, r po-losi al
«ole, vide il -ole i.prrrhiaoi nel ~uu corpo: della qual ro-J pre»f
minima proria. r rivolto co! pensiero indirtelo, comincio con -eco
medesimo a dire:
Or tornerò io più a quella bottega, della
quale novamente u«cito «ono? reno no: non piaccia alli Dei. che
*i splendida belletta cangia in tanta viltà d'animo! Che pauia
«arebbe quella la qual mi conducessi a radere le insaponate barbe
de' ru-tiei villani e fare *i meccaniche operazione! ((r e questo
corpo da -imili eserciti? ( rrtn no. lo mi voglio nascondere in
qualche occulto loco, e li con tranquillo riponi pa«*are mia vila.
E co«i. na-io-in per alquanti nw-i. un giorno ritornato all'aria,
r iim"ito fori dalla -uà guaina, vide «è »— ere fatto a -imilitudine
d'una rugginente *ega. e la -uà -uperheie non i*pecchiare più In
-jilrtidenlr «ole.
I
.on vano pentimento indarno pian*e lo danno
inriparahilr. con -ero dicendo:
Oh! quanto meglio era eserci
tare col barbiere il m i' perdalo taglio di tanta sottilità! Ikov'e
la la>traale -a p e rtin e ' ceri» la fastidiosa e bruita raggine l'ha
nM h ia u li'
Investo medesimo arrade aedi iagegai. rhe ‘ a
imambio dello eserciti» »i
danno
all'u t*»: i quali, a
-imilitadine
del
M«pradrtto ri .oro. perdoao
ia taglieMe
-aa -altilita. e
la
rag
giae dell'ignoranza gBasta la -aa forma • •L u v u n .
»


















