
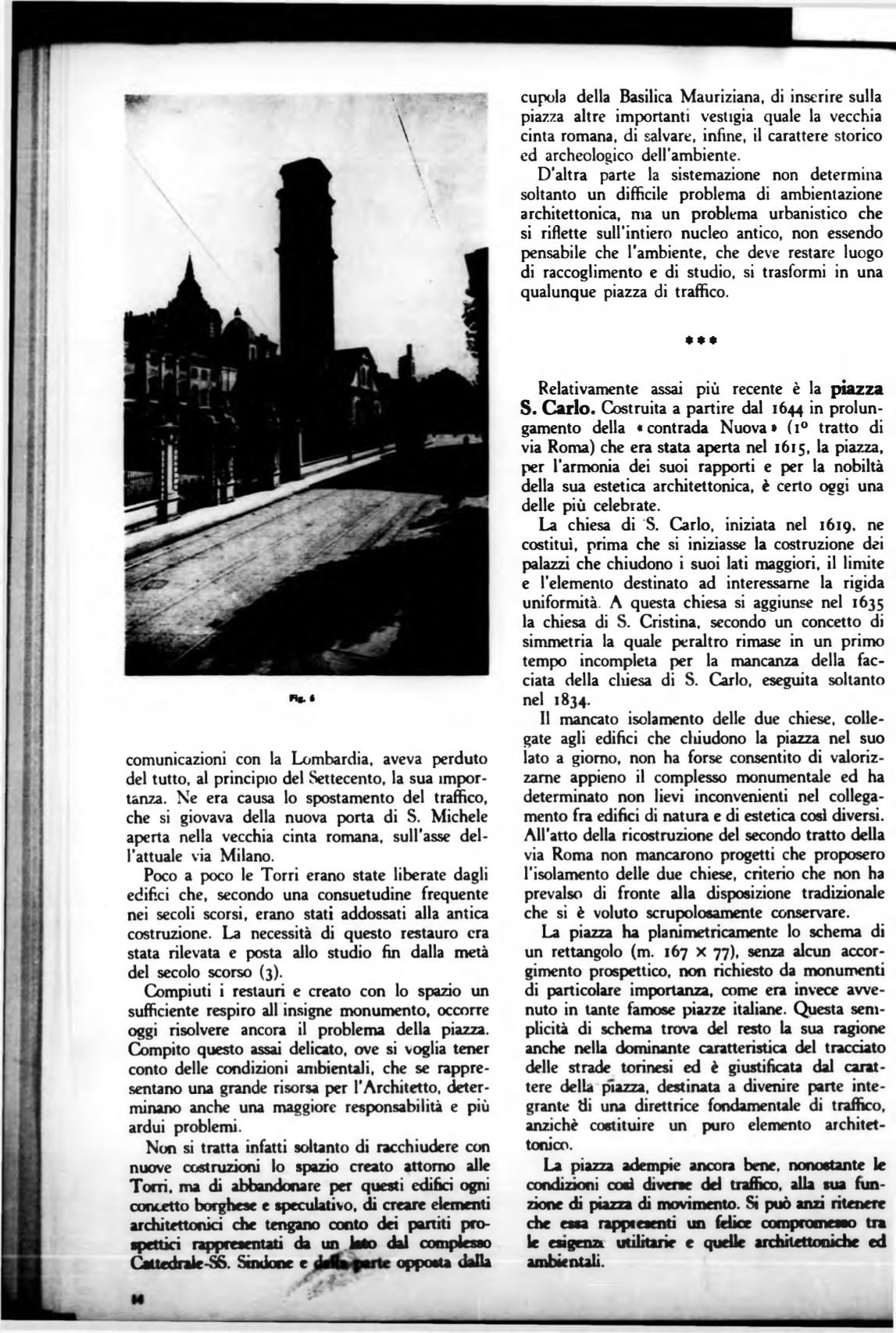
\
■W-
\
H « .é
comunicazioni con la Lombardia, aveva perduto
del tutto, al principio del Settecento, la sua impor
tanza. Ne era causa lo spostamento del traffico,
che si giovava della nuova porta di S. Michele
aperta nella vecchia cinta romana, sull’asse del
l’attuale via Milano.
Poco a poco le Torri erano state liberate dagli
edifìci che, secondo una consuetudine frequente
nei secoli scorsi, erano stati addossati alla antica
costruzione. La necessità di questo restauro era
stata rilevata e posta allo studio fin dalla metà
del secolo scorso (
3
).
Compiuti i restauri e creato con lo spazio un
sufficiente respiro all insigne monumento, occorre
oggi risolvere ancora il problema della piazza.
Compito questo assai delicato, ove si voglia tener
conto delle condizioni ambientali, che se rappre
sentano una grande risorsa per l’Architetto, deter
minano anche una maggiore responsabilità e più
ardui problemi.
Non si tratta infatti soltanto di racchiudere con
nuove costruzioni lo spazio creato attorno alle
Torri, ma di abbandonare per questi edifici ogni
concetto borghese e speculativo, di creare elementi
architettonici che tengano conto dei paniti pro
spettici rappresentati da un lato dal complesso
Cattedrale-SS. Sindone e
opposta dalla
cupola della Basilica Mauriziana, di inserire sulla
piazza altre importanti vestigia quale la vecchia
cinta romana, di salvare, infine, il carattere storico
ed archeologico dell’ambiente.
D ’altra parte la sistemazione non determina
soltanto un difficile problema di ambientazione
architettonica, ma un problema urbanistico che
si riflette sull’intiero nucleo antico, non essendo
pensabile che l’ambiente, che deve restare luogo
di raccoglimento e di studio, si trasformi in una
qualunque piazza di traffico.
* * *
Relativamente assai più recente è la piazza
S. Carlo . Costruita a partire dal
1644
in prolun
gamento della « contrada Nuova * ( i° tratto di
via Roma) che era stata aperta nel
1615
, la piazza,
per l’armonia dei suoi rapporti e per la nobiltà
della sua estetica architettonica, è certo oggi una
delle più celebrate.
La chiesa di S. Carlo, iniziata nel
1619
. ne
costituì, prima che si iniziasse la costruzione dei
palazzi che chiudono i suoi lati maggiori, il limite
e l’elemento destinato ad interessarne la rigida
uniformità. A questa chiesa si aggiunse nel
1635
la chiesa di S. Cristina, secondo un concetto di
simmetria la quale peraltro rimase in un primo
tempo incompleta per la mancanza della fac
ciata della cliiesa di S. Carlo, eseguita soltanto
nel
1834
.
Il mancato isolamento delle due chiese, colle
gate agli edifìci che dùudono la piazza nel suo
lato a giorno, non ha forse consentito di valoriz
zarne appieno il complesso monumentale ed ha
determinato non lievi inconvenienti nel collega
mento fra edifìci di natura e di estetica così diversi.
All’atto della ricostruzione del secondo tratto della
via Roma non mancarono progetti che proposero
l’isolamento delle due chiese, criterio che non ha
prevalso di fronte alla disposizione tradizionale
che si è voluto scrupolosamente conservare.
La piazza ha planimetricamente lo schema di
un rettangolo (m.
167
x
77
), senza alcun accor
gimento prospettico, non richiesto da monumenti
di particolare importanza, come era invece avve
nuto in tante famose piazze italiane. Questa sem
plicità di schema trova del resto la sua ragione
anche nella dominante caratteristica del tracciato
delle strade torinesi ed è giustificata dal carat
tere della piazza, destinata a divenire parte inte
grante di una direttrice fondamentale di traffico,
anziché costituire un puro elemento architet
tonico.
La piazza adempie ancora bene, nonostante le
condizioni cosi diverse del traffico, alla sua fun
zione di piazza di movimento. Si può anzi ritenere
che essa rapptesenti un felice compromesso tra
le esigenza utilitarie e quelle architettoniche ed
ambientali.


















