
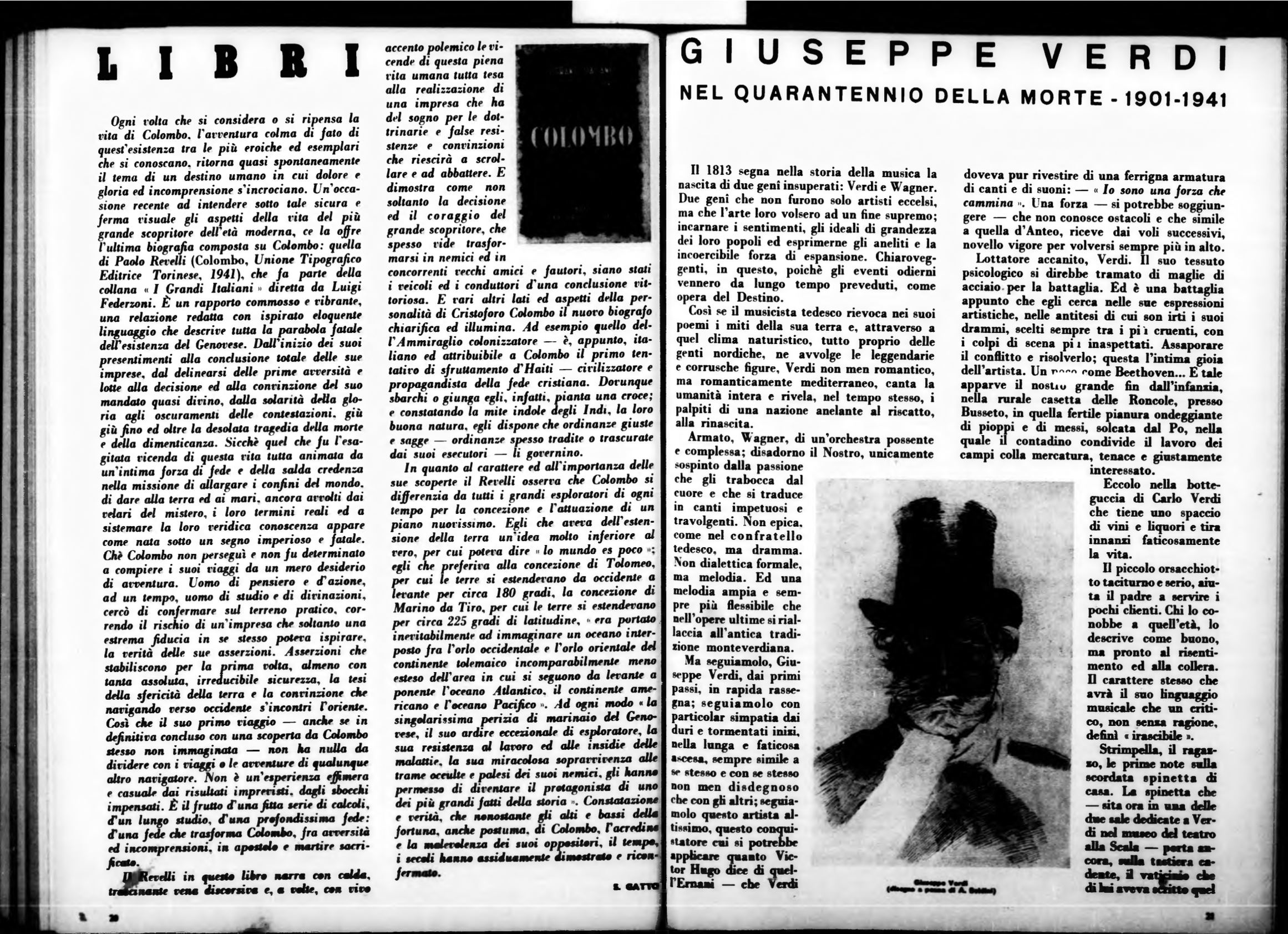
i
I
L
I
B
B I
Ogni volta che si considera o si ripensa la
vita di Colombo. l'avventura colma di fato di
quest'esistenza tra le più eroiche ed esemplari
che si conoscano, ritorna quasi spontaneamente
il tema di un destino umano in cui dolore e
gloria ed incomprensione s'incrociano. Un'occa
sione recente ad intendere sotto tale sicura e
ferma visuale gli aspetti della vita del più
grande scopritore dell'età moderna, ce la offre
l'ultima biografia composta su Colombo: quella
di Paolo Revelli
(Colombo,
Unione Tipografico
Editrice Torinese,
1941),
che fa parte della
collana
«
I Grandi Italiani
»
diretta da Luigi
Federzoni. È un rapporto commosso e vibrante
,
una relazione redatta con ispirato eloquente
linguaggio che descrive tutta la parabola fatale
dell'esistenza del Genovese. Dall'inizio dei suoi
presentimenti alla conclusione totale delle sue
imprese, dal delinearsi delle prime avversità e
lotte alla decisione ed alla convinzione del suo
mandato quasi divino, dalla solarità della glo
ria agli oscuramenti delle contestazioni, giù
giù fino ed oltre la desolata tragedia della morte
e della dimenticanza. Sicché quel che fu l'esa
gitata vicenda di questa vita tutta animata da
un'intima forza di fede e della salda credenza
nella missione di allargare i confini del mondo,
di dare alla terra ed ai mari, ancora avvolti dai
velari del mistero
, i
loro termini reali *d a
sistemare la loro veridica conoscenza appare
come nata sotto un segno imperioso e fatale.
Che Colombo non perseguì e non fu determinato
a compiere i suoi viaggi da un mero desiderio
di avventura. Uomo di pensiero e
<f
azione
,
ad un tempo
,
uomo di studio e di divinazioni
,
cercò di confermare sul terreno pratico, cor
rendo il rischio di un'impresa che soltanto una
estrema fiducia in se stesso poteva ispirare
,
la verità delle sue asserzioni. Asserzioni che
stabiliscono per la prima volta
,
almeno con
tanta assoluta, irreducibile sicurezza
,
la tesi
della sfericità della terra e la convinzione che
navigando verso occidente s'incontri l'oriente.
Così che il suo primo viaggio
—
anche se in
definitiva concluso con una scoperta da Colombo
stesso non immaginata
—
non ha nulla da
dividere con i viaggi o le avventure di qualunque
altro navigatore. Non è un'esperienza effimera
e casuale dai risultati imprevisti, dagli sbocchi
impensati. È il frutto
<f
una fitta serie di calcoli
,
<f
un lungo studio, d 'uno profondissima fede:
d'uno fede che trasforma
Colombo
,
fra avversità
ed incomprensioni, in
apostolo
e martire sacri
ficato.
_
U Revelli in questo libro narra con calda
,
trapanante vena discorsiva
e,
m volte, con vivo
accento polemico le vi
cende di questa piena
vita umana tutta tesa
alla realizzazione di
una impresa che ha
del sogno per le dot
trinarie e false resi
stenze e convinzioni
che riescirà a scrol
lare e ad abbattere. E
dimostra come non
soltanto la decisione
ed il coragg io del
grande scopritore, che
spesso vide trasfor
marsi in nemici ed in
concorrenti vecchi amici e fautori
,
siano stati
i veicoli ed i conduttori d'una conclusione vit
toriosa. E vari altri lati ed aspetti della per
sonalità di Cristoforo Colombo il nuovo biografo
chiarifica ed illumina. A d esempio quello del-
l 'Ammiraglio colonizzatore
— è,
appunto
,
ita
liano ed attribuibile a Colombo il primo ten
tativo di sfruttamento d 'Ha iti
—
civilizzatore e
propagandista della fede cristiana. Dovunque
sbarchi o giunga egli, infatti, pianta una croce;
e constatando la mite indole degli Ind i
,
la loro
buona natura, egli dispone che ordinanze giuste
e sagge
—
ordinanze spesso tradite o trascurate
dai suoi esecutori
—
li governino.
In quanto al carattere ed all'importanza delle
sue scoperte il Revelli osserva che Colombo si
differenzia da tutti i grandi esploratori di ogni
tempo per la concezione e l'attuazione di un
piano nuovissimo. Egli che aveva dell'esten
sione della terra un'idea molto inferiore al
vero
,
per cui poteva dire
«
lo mundo es poco
egli che preferiva alla concezione di Tolomeo
,
per cui le terre si estendevano da occidente a
levante per circa 180 gradi
,
la concezione di
Marino da Tiro, per cui le terre si estendevano
per circa 225 gradi di latitudine,
<•
era portato
inevitabilmente ad immaginare un oceano inter
posto fra l'orlo occidentale e Torlo orientale del
continente tolemaico incomparabilmente meno
esteso dell'area in cui si seguono da levante a
ponente l'oceano Atlantico, il continente ame
ricano e l'oceano Pacifico ». A d ogni modo
«
la
singolarissima perizia di marinaio del Geno
vese
,
il suo ordire eccezionale di esploratore
,
la
sua resistenza al lavoro ed alle insidie delle
malattie, la sua miracolosa sopravvivenza alle
trame occulte e palesi dei suoi nemici, gli hanno
permesso di diventare il protagonista di uno
dei più grandi fatti della storia ». Constatazione
e verità
,
che nonostante gli alti e bassi della
fortuna, anche postuma, di Colombo, P acredine
e la malevolenza dei suoi oppositori
,
il tempo
,
i secoli hanno assiduamente dimostrato e ricon
-
/
it i
G I
U S E P P E
V E R D I
N E L Q U A R A N T E N N I O D E L L A M O R T E -
1901-1941
%.
CATTO
I '
Il 1813 segna nella storia della musica la
nascita di due geni insuperati: Verdi e Wagner.
Due geni che non furono solo artisti eccelsi,
ma che l’arte loro volsero ad un fine supremo;
incarnare i sentimenti, gli ideali di grandezza
dei loro popoli ed esprimerne gli aneliti e la
incoercibile forza di espansione. Chiaroveg
genti, in questo, poiché gli eventi odierni
vennero da lungo tempo preveduti, come
opera del Destino.
Così se il musicista tedesco rievoca nei suoi
poemi i miti della sua terra e, attraverso a
quel clima naturistico, tutto proprio delle
genti nordiche, ne avvolge le leggendarie
e corrusche figure, Verdi non men romantico,
ma romanticamente mediterraneo, canta la
umanità intera e rivela, nel tempo stesso, i
palpiti di una nazione anelante al riscatto,
alla rinascita.
Armato, Wagner, di un’orchestra possente
e complessa; disadorno il Nostro, unicamente
sospinto dalla passione
che gli trabocca dal
cuore e che si traduce
in canti impetuosi e
travolgenti. Non epica,
come nel con fra te llo
tedesco, ma dramma.
Non dialettica formale,
ma melodia. Ed una
melodia ampia e sem
pre più flessibile che
nell’opere ultime si rial
laccia all’antica tradi
zione monteverdiana.
Ma seguiamolo, Giu
seppe Verdi, dai primi
passi, in rapida rasse
gna; seguiamolo con
particolar simpatia dai
duri e tormentati inizi,
nella lunga e faticosa
ascesa, sempre simile
a
se stesso e con se stesso
non men disdegnoso
che con gli altri; seguia
molo questo artista al
tissimo, questo conqui
statore cui si
potrebbe
applicare
quanto
Vic
tor
Hugo dice di quel-
l’Emani — che
Verdi
m
doveva pur rivestire di una ferrigna armatura
di canti e di suoni: — «
Io sono una forza che
cammina ».
Una forza — si potrebbe soggiun
gere — che non conosce ostacoli e che simile
a quella d’Anteo, riceve dai voli successivi,
novello vigore per voiversi sempre più in alto.
Lottatore accanito, Verdi. Il suo tessuto
psicologico si direbbe tramato di maglie di
acciaio per la battaglia. Ed è una battaglia
appunto che egli cerca nelle sue espressioni
artistiche, nelle antitesi di cui son irti i suoi
drammi, scelti sempre tra i pi i cruenti, con
i colpi di scena p i i inaspettati. Assaporare
il conflitto e risolverlo; questa l’intima gioia
dell’artista. Un r n,,n ^orne Beethoven... E tale
apparve il nostio grande fin dall’infanzia,
nella rurale casetta delle Roncole, presso
Busseto, in quella fertile pianura ondeggiante
di pioppi e di messi, solcata dal Po, nella
quale il contadino condivide il lavoro dei
campi colla mercatura, tenace e giustamente
interessato.
Eccolo nella botte-
guccia di Carlo Verdi
che tiene uno spaccio
di vini e liquori e tira
innanzi faticosamente
la vita.
Il piccolo orsacchiot
to taciturno e serio, aiu
ta il padre a servire i
pochi clienti. Chi lo co
nobbe a quell’età, lo
descrive come buono,
ma pronto al risenti
mento ed alla collera.
I l carattere stesso che
avrà il suo linguaggio
musicale che un criti
co, non senza ragione,
definì « irascibile ».
Strimpella, il ragaz
zo, le prime note sulla
scordata spinetta di
casa. La spinetta che
— sita ora in una delle
due sale dedicate
a
Ver
di nel museo del teatro
alla Scala —
parta
an
cora,
culla tastiera ca
dente, il n t jc iM che
di lui
aveva
J titto
quel


















