
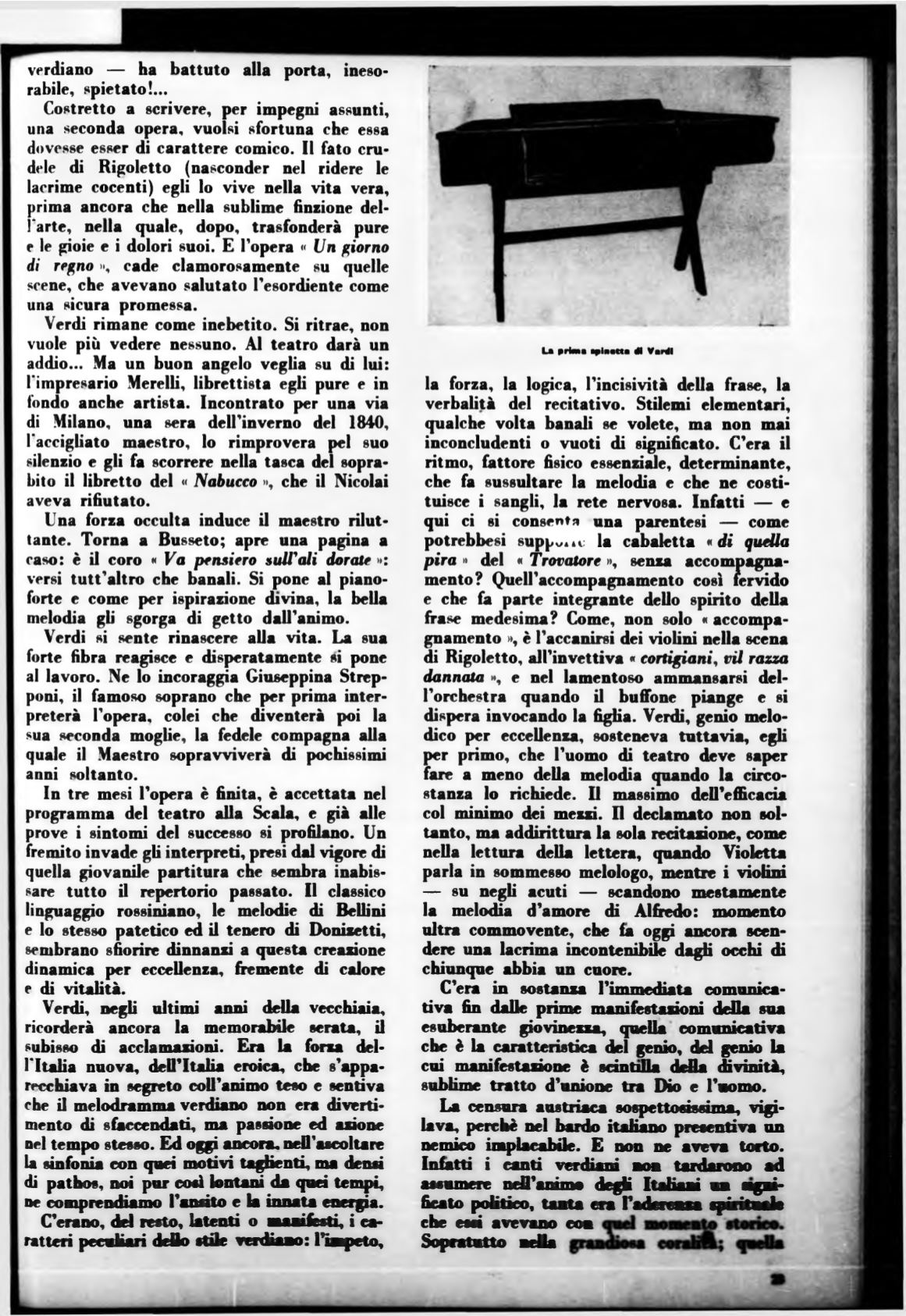
verdiano — ha battuto alla porta, ineso
rabile, spietato!...
Costretto a scrivere, per impegni assunti,
una seconda opera, vuoisi sfortuna che essa
dovesse esser di carattere comico. Il fato cru
dele di Rigoletto (nasconder nel ridere le
lacrime cocenti) egli lo vive nella vita vera,
prima ancora che nella sublime finzione del
l'arte, nella quale, dopo, trasfonderà pure
e le gioie e i dolori suoi. E l’opera «
Un giorno
di regno
», cade clamorosamente su quelle
scene, che avevano salutato l'esordiente come
una sicura promessa.
Verdi rimane come inebetito. Si ritrae, non
vuole più vedere nessuno. Al teatro darà un
addio... Ma un buon angelo veglia su di lui:
l'impresario Merelli, librettista egli pure e in
fondo anche artista. Incontrato per una via
di Milano, una sera dell'inverno del 1840,
l'accigliato maestro, lo rimprovera pel suo
silenzio e gli fa scorrere nella tasca del sopra
bito il libretto del «
Nabucco
», che il Nicolai
aveva rifiutato.
Una forza occulta induce il maestro rilut
tante. Torna a Busseto; apre una pagina a
caso: è il coro «
Va pensiero sull'ali dorate
»:
versi tutt’ altro che banali. Si pone al piano
forte e come per ispirazione divina, la bella
melodia gli sgorga di getto dalTanimo.
Verdi si sente rinascere alla vita. La sua
forte fibra reagisce e disperatamente si pone
al lavoro. Ne lo incoraggia Giuseppina Strep-
poni, il famoso soprano che per prima inter
preterà l'opera, colei che diventerà poi la
sua seconda moglie, la fedele compagna alla
quale il Maestro sopravviverà di pochissimi
anni soltanto.
In tre mesi l’opera è finita, è accettata nel
programma del teatro alla Scala, e già alle
prove i sintomi del successo si profilano. Un
fremito invade gli interpreti, presi dal vigore di
quella giovanile partitura che sembra inabis
sare tutto il repertorio passato. Il classico
linguaggio rossiniano, le melodie di Bellini
e lo stesso patetico ed il tenero di Donizetti,
sembrano sfiorire dinnanzi a questa creazione
dinamica per eccellenza, fremente di calore
e di vitalità.
Verdi, negli ultimi anni della vecchiaia,
ricorderà
ancora la memorabile serata, il
subisso
di acclamazioni. Era la forza del
l'Italia nuova, dell’Italia eroica, che s’appa
recchiava in segreto coll’animo teso e sentiva
che
il melodramma verdiano non era diverti
mento di sfaccendati, ma passione ed azione
nel tempo stesso. Ed oggi ancora, nell'ascoltare
la sinfonia con quei motivi taglienti, ma densi
di pathos, noi pur così lontani da quei tempi,
ne comprendiamo l’ansito e la innata energia.
C’erano, del vesto, latenti o manifesti, i ca
ratteri peculiari dello stile verdiano: l’impeto.
La prima spinetta di Vardi
la forza, la logica, l’incisività della frase, la
verbalità del recitativo. Stilemi elementari,
qualche volta banali se volete, ma non mai
inconcludenti o vuoti di significato. C’era il
ritmo, fattore fisico essenziale, determinante,
che fa sussultare la melodia e che ne costi
tuisce i sangli, la rete nervosa. Infatti — e
qui ci si consenta una parentesi — come
potrebbesi sup^ .tt la cabaletta «
di quella
pira
» del «
Trovatore
», senza accompagna
mento? QueH’accompagnamento così fervido
e che fa parte integrante dello spirito della
frase medesima? Come, non solo « accompa
gnamento », è l’accanirsi dei violini nella scena
di Rigoletto, all’invettiva «
cortigiani
,
vii razza
dannata
», e nel lamentoso ammansarsi del
l’orchestra quando il buffone piange e si
dispera invocando la figlia. Verdi, genio melo
dico per eccellenza, sosteneva tuttavia, egli
per primo, che l’uomo di teatro deve saper
fare a meno della melodia quando la circo
stanza lo richiede. Il massimo dell’efficacia
col minimo dei mezzi. Il declamato non sol
tanto, ma addirittura la sola recitazione, come
nella lettura della lettera, quando Violetta
parla in sommesso melologo, mentre i violini
— su negli acuti — scandono mestamente
la melodia d’amore di Alfiredo: momento
ultra commovente, che fa oggi ancora scen
dere una lacrima incontenibile dagli occhi di
chiunque abbia un cuore.
C’era in sostanza l’immediata comunica
tiva fin dalle prime manifestazioni della sua
esuberante giovinezza, quella comunicativa
che
è
la caratteristica del genio, del genio la
cui manifestazione è scintilla della divinità,
sublime tratto d’unione tra Dio e l’uomo.
La censura austriaca sospettosissima, vigi
lava, perchè nel bardo italiano presentiva un
nemico implacabile. E non ne aveva torto.
Inflitti i canti verdiani non tardarono ad
assumere nell’animo degli Italiani un agni*
ficato politico, tanta era l’aderenza ^ ritu a le
che essi avevano con
Sopratutto nella


















