
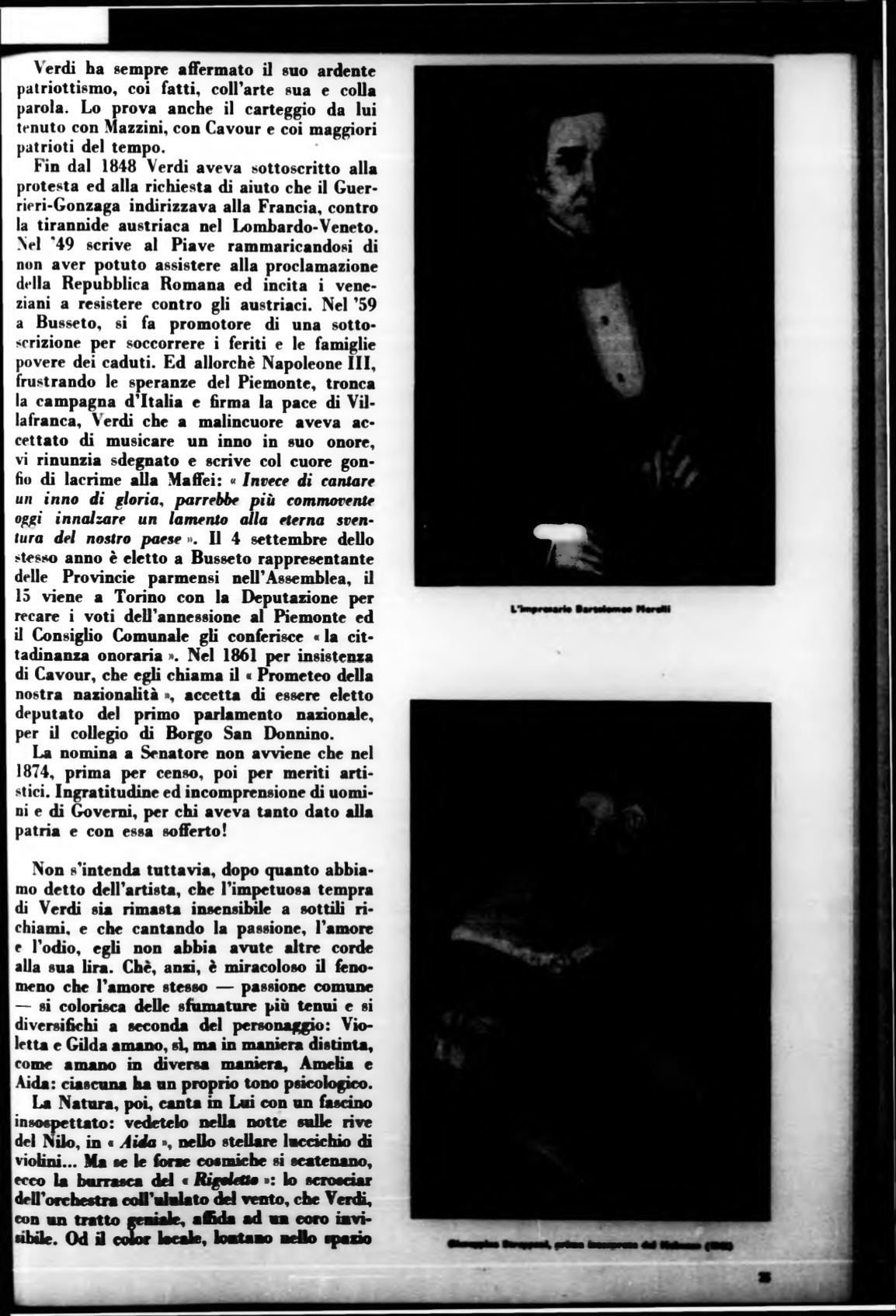
1
Verdi ha sempre affermato il suo ardente
patriottismo, coi fatti, coll’arte sua e colla
parola. Lo prova anche il carteggio da lui
tenuto con Mazzini, con Cavour e coi maggiori
patrioti del tempo.
Fin dal 1848 Verdi aveva sottoscritto alla
protesta ed alla richiesta di aiuto che il Guer-
rieri-Gonzaga indirizzava alla Francia, contro
la tirannide austriaca nel Lombardo-Veneto.
Nel “49 scrive al Piave rammaricandosi di
non aver potuto assistere alla proclamazione
della Repubblica Romana ed incita i vene
ziani a resistere contro gli austriaci. Nel ’59
a Busseto, si fa promotore di una sotto-
scrizione per soccorrere i feriti e le famiglie
povere dei caduti. Ed allorché Napoleone I I I ,
frustrando le speranze del Piemonte, tronca
la campagna d’ Italia e firma la pace di Vil
lafranca, Verdi che a malincuore aveva ac
cettato di musicare un inno in suo onore,
vi rinunzia sdegnato e scrive col cuore gon
fio di lacrime alla Maffei: «
Invece di cantare
un inno di gloria
,
parrebbe più commovente
oggi innalzare un lamento alla eterna sven
tura del nostro paese
». Il 4 settembre dello
stesso anno è eletto a Busseto rappresentante
delle Provincie parmensi nell’Assemblea, il
15 viene a Torino con la Deputazione per
recare i voti dell’annessione al Piemonte ed
il Consiglio Comunale gli conferisce « la cit
tadinanza onoraria ». Nel 1861 per insistenza
di Cavour, che egli chiama il « Prometeo della
nostra nazionalità », accetta di essere eletto
deputato del primo parlamento nazionale,
per il collegio di Borgo San Donnino.
La nomina a Senatore non avviene che nel
1874, prima per censo, poi per meriti arti
stici. Ingratitudine ed incomprensione di uomi
ni e di Governi, per chi aveva tanto dato alla
patria e con essa sofferto!
Non s’intenda tuttavia, dopo quanto abbia
mo detto dell’artista, che l’impetuosa tempra
di Verdi sia rimasta insensibile a sottili ri
chiami. e che cantando la passione, l’amore
e l’odio, egli non abbia avute altre corde
alla
sua lira. Che, anzi, è miracoloso il feno
meno che l’amore stesso — passione comune
— si colorisca delle sfumature più tenui e si
diversifichi a seconda del personaggio: Vio
letta e Gilda amano, si, ma in maniera distinta,
come amano in diversa maniera, Amelia e
Aida: ciascuna ha un proprio tono psicologico.
La Natura, poi, canta in Lui con un Cascino
insospettato: vedetelo nella notte sulle rive
del Nilo, in «
Aida
», nello stellare luccichio di
violini... Ma se le
forse
cosmiche si scatenano,
ecco In burrasca del c
Rigoletto
•: lo
scrosciar
drll’orchestra
coll’ululato del vento,
che
Verdi,
con
un tratto geniale, affida ad un coro invi*
«bile.
Od
il coler locale, lontano nello «palio


















