
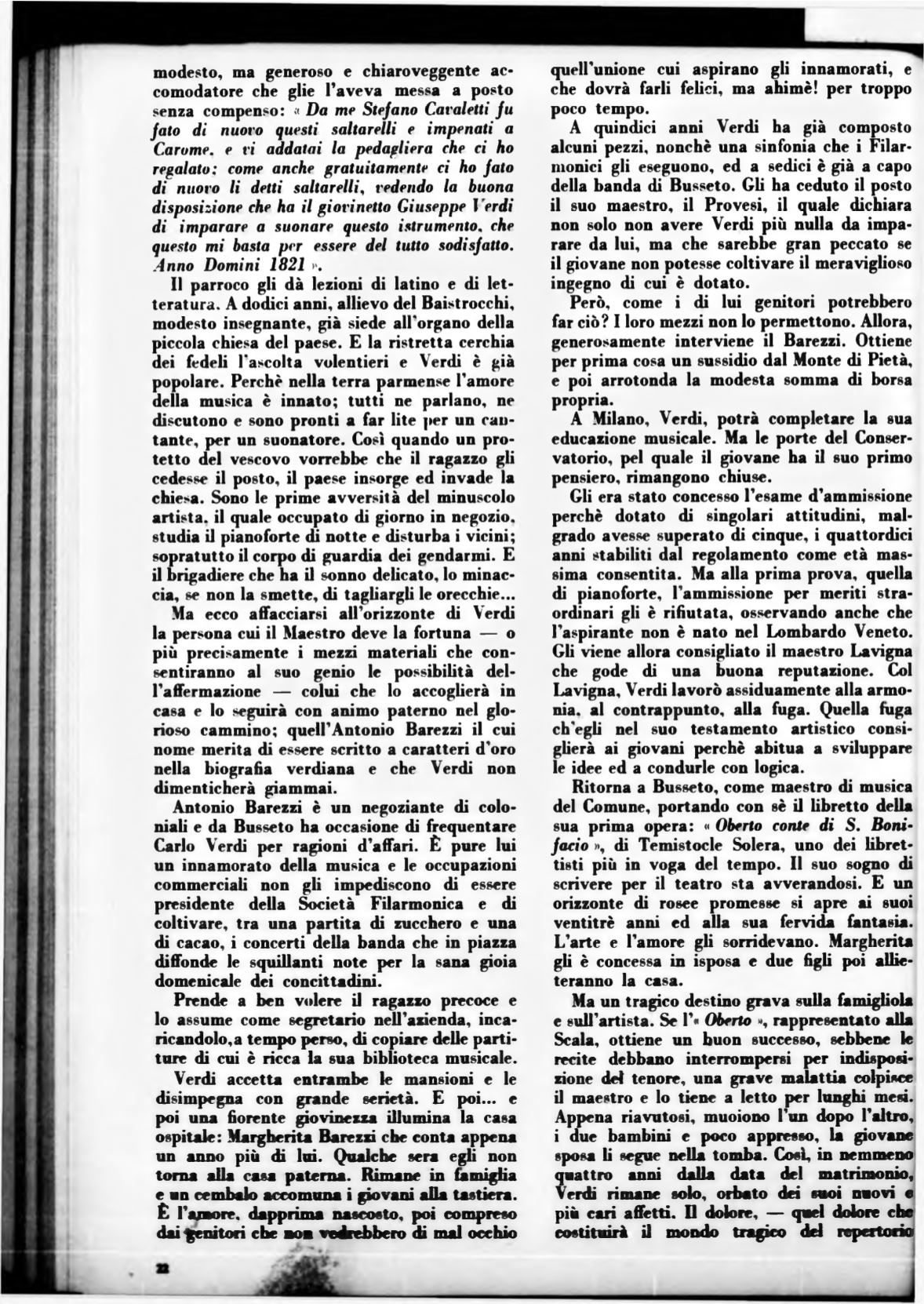
modesto, ma generoso e chiaroveggente ac-
comodatore che glie l’aveva messa a posto
senza compenso: «
Da me Stefano Cavaletti fu
fato di nuovo questi saltarelli e impenati a
Carume. e vi addatai la pedaliera che ci ho
regalato; come anche gratuitamente ci ho fato
di nuovo li detti saltarelli
,
vedendo la buona
disposizione che ha il giovinetto Giuseppe
I
erdi
di imparare a suonare questo istrumento, che
questo mi basta per essere del tutto sodisfatto.
Anno Domini 1821
>«.
Il parroco gli dà lezioni di latino e di let
teratura. A dodici anni, allievo del Baistrocchi,
modesto insegnante, già siede all'organo della
piccola chiesa del paese. E la ristretta cerchia
dei fedeli l'ascolta volentieri e Verdi è già
popolare. Perchè nella terra parmense l'amore
della musica è innato; tutti ne parlano, ne
discutono e sono pronti a far lite per un can
tante, per un suonatore. Così quando un pro
tetto del vescovo vorrebbe che il ragazzo gli
cedesse il posto, il paese insorge ed invade la
chiesa. Sono le prime avversità del minuscolo
artista, il quale occupato di giorno in negozio,
studia il pianoforte dì notte e disturba i vicini;
sopratutto il corpo di guardia dei gendarmi. E
il brigadiere che ha il sonno delicato, lo minac
cia, se non la smette, di tagliargli le orecchie...
Ma ecco affacciarsi airorizzonte di Verdi
la persona cui il Maestro deve la fortuna — o
più precisamente i mezzi materiali che con
sentiranno al suo genio le possibilità del-
l'affermazione — colui che lo accoglierà in
casa e lo seguirà con animo paterno nel glo
rioso cammino; queirAntonio Barezzi il cui
nome merita di essere scritto a caratteri d'oro
nella biografia verdiana e che Verdi non
dimenticherà giammai.
Antonio Barezzi è un negoziante di colo
niali e da Busseto ha occasione di frequentare
Carlo Verdi per ragioni d'affari. È pure lui
un innamorato della musica e le occupazioni
commerciali non gli impediscono di essere
presidente della Società Filarmonica e di
coltivare, tra una partita di zucchero e una
di cacao, i concerti della banda che in piazza
diffonde le squillanti note per la sana gioia
domenicale dei concittadini.
Prende a ben volere il ragazzo precoce e
lo assume come segretario nell'azienda, inca
ricandolo, a tempo perno, di copiare delle parti
ture di cui è ricca la sua biblioteca musicale.
Verdi accetta entrambe le mansioni e le
disimpegna con grande serietà. E poi... e
poi una fiorente giovinezza illumina la casa
ospitale: Margherita Barezzi che conta appena
un anno più di lai. Qualche sera egli non
torna alla casa paterna. Rimane in famiglia
e un cembalo accomuna i giovani alla tastiera.
£ l'amore, dapprima nascosto, poi compreso
dai genitori
che non vedrebbero
di mal occhio
quell'unione cui aspirano gli innamorati, e
che dovrà farli felici, ma ahimè! per troppo
poco tempo.
A quindici anni Verdi ha già composto
alcuni pezzi, nonché una sinfonia che i Filar
monici gli eseguono, ed a sedici è già a capo
della banda di Busseto. Gli ha ceduto il posto
il suo maestro, il Provesi, il quale dichiara
non solo non avere Verdi più nulla da impa
rare da lui, ma che sarebbe gran peccato se
il giovane non potesse coltivare il meraviglioso
ingegno di cui è dotato.
Però, come i di lui genitori potrebbero
far ciò? I loro mezzi non lo permettono. Allora,
generosamente interviene il Barezzi. Ottiene
per prima cosa un sussidio dal Monte di Pietà,
e poi arrotonda la modesta somma di borsa
propria.
A Milano, Verdi, potrà completare la sua
educazione musicale. Ma le porte del Conser
vatorio, pel quale il giovane ha il suo primo
pensiero, rimangono chiuse.
Gli era stato concesso l'esame d'ammissione
perchè dotato di singolari attitudini, mal
grado avesse superato di cinque, i quattordici
anni stabiliti dal regolamento come età mas
sima consentita. Ma alla prima prova, quella
di pianoforte, l'ammissione per meriti stra
ordinari gli è rifiutata, osservando anche che
l'aspirante non è nato nel Lombardo Veneto.
Gli viene allora consigliato il maestro Lavigna
che gode di una buona reputazione. Col
Lavigna, Verdi lavorò assiduamente alla armo
nia. al contrappunto, alla fuga. Quella fuga
ch'egli nel suo testamento artistico consi-
glierà ai giovani perchè abitua a sviluppare
le idee ed a condurle con logica.
Ritorna a Busseto, come maestro di musica
del Comune, portando con sè il libretto della
sua prima opera: «
Oberto conte di S. Boni
-
facio
», di Temistocle Solerà, uno dei libret
tisti più in voga del tempo. Il suo sogno di
scrivere per il teatro sta avverandosi. E un
orizzonte di rosee promesse si apre ai suoi
ventitré anni ed alla sua fervida fantasia.
L'arte e l'amore gli sorridevano. Margherita
gli è concessa in isposa e due figli poi allie
teranno la casa.
Ma un tragico destino grava sulla famigliola
e sull'artista. Se l'«
Oberto
», rappresentato alla
Scala, ottiene un buon successo, sebbene le
recite debbano interrompersi per indisposi
zione de) tenore, una grave malattia colpisce
il maestro e lo tiene a letto per lunghi mesi.
Appena riavutosi, muoiono l'un dopo l'altro,
i due bambini e poco appresso, la giovane
sposa li segue nella tomba. Così, in nemmeno
quattro anni dalla data del matrimonio,
Verdi rimane solo, orbato dei suoi nuovi
e
più cari affetti. I l dolore, — quel dolore
che
costituirà il mondo tragico del repertorio


















