
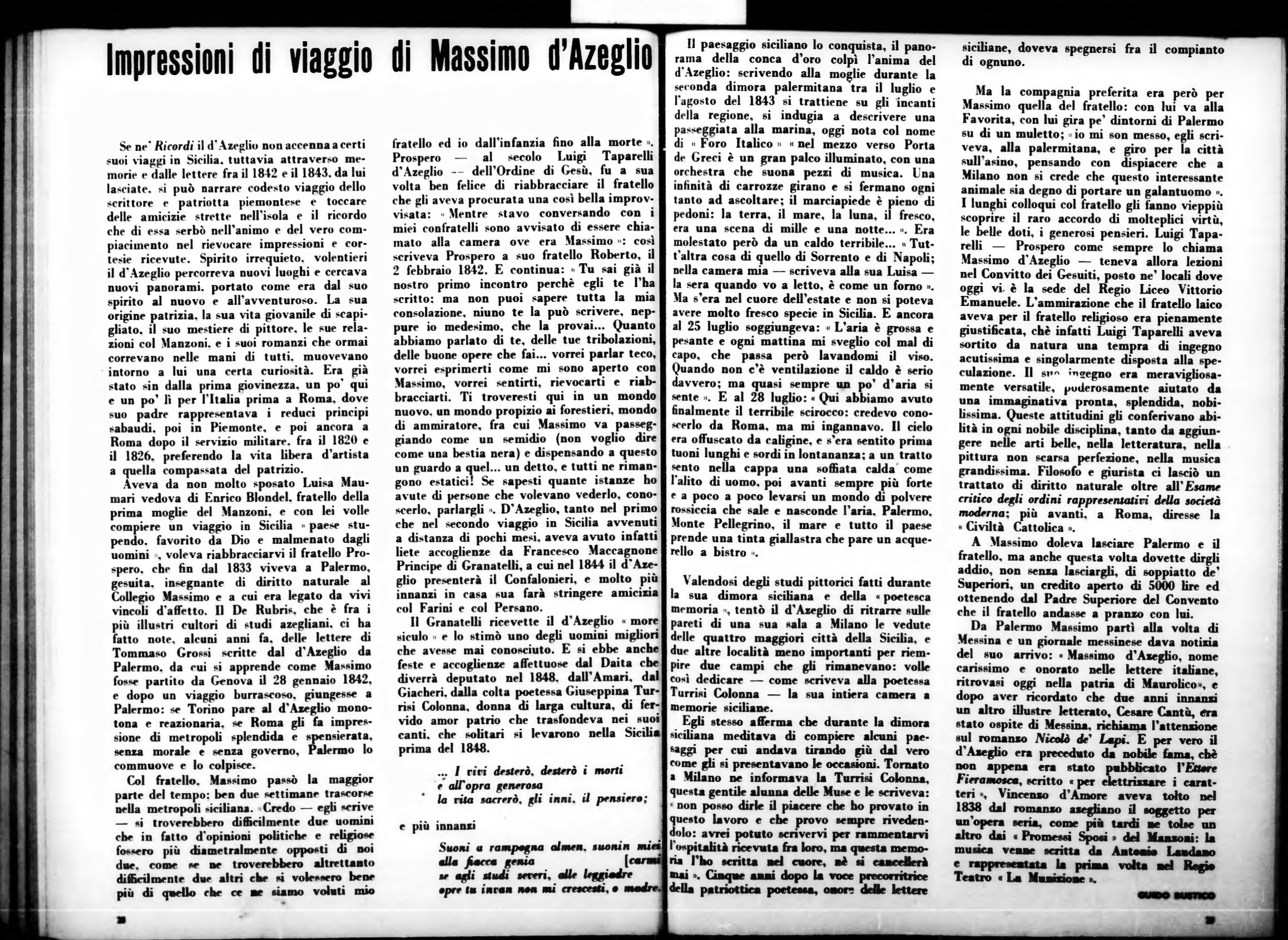
Impresioni di viaggio di Masimo d’Azeglio
Se ne'
Ricordi
ii d‘ Azeglio non accenna acerti
suoi viaggi in Sicilia, tuttavia attraverso me
morie e dalle lettere fra il 1842 e il 1843, da lui
lasciate, si può narrare codesto viaggio dello
scrittore e patriotta piemontese e toccare
delle amicizie strette nell’ isola e il ricordo
che di essa serbò nell’ animo e del vero com
piacimento nel rievocare impressioni e cor
tesie ricevute. Spirito irrequieto, volentieri
il d'Azeglio percorreva nuovi luoghi e cercava
nuovi panorami, portato come era dal suo
spirito al nuovo e all’avventuroso. La sua
origine patrizia, la sua vita giovanile di scapi
gliato. il suo mestiere di pittore, le sue rela
zioni col Manzoni, e i suoi romanzi che ormai
correvano nelle mani di tutti, muovevano
intorno a lui una certa curiosità. Era già
stato sin dalla prima giovinezza, un po' qui
e un po’ lì per l'Italia prima a Roma, dove
suo padre rappresentava i reduci principi
sabaudi, poi in Piemonte, e poi ancora a
Roma dopo il servizio militare, fra il 1820 e
il 1826. preferendo la vita libera d’artista
a quella compassata del patrizio.
Aveva da non molto sposato Luisa Mau-
mari vedova di Enrico Blondel, fratello della
prima moglie del Manzoni, e con lei volle
compiere un viaggio in Sicilia « paese stu
pendo. favorito da Dio e malmenato dagli
uomini , voleva riabbracciarvi il fratello Pro
spero. che fin dal 1833 viveva a Palermo,
gesuita, insegnante di diritto naturale al
Collegio Massimo e a cui era legato da vivi
vincoli d'affetto. Il De Rubris. che è fra i
più illustri cultori di studi azegliani, ci ha
fatto note, alcuni anni fa, delle lettere di
Tommaso Grossi scritte dal d’ Azeglio da
Palermo, da cui si apprende come Massimo
fosse partito da Genova il 28 gennaio 1842,
e dopo un viaggio burrascoso, giungesse a
Palermo: se Torino pare al d’Azeglio mono
tona e reazionaria, se Roma gli fa impres
sione di metropoli splendida e spensierata,
senza morale e senza governo, Palermo lo
commuove e lo colpisce.
Col fratello. Massimo passò la maggior
parte del tempo: ben due settimane trascorse
nella metropoli siciliana. Credo — egli scrive
— si troverebbero difficilmente due uomini
che in fatto d'opinioni politiche e religiose
fossero più diametralmente opposti di noi
due. come se ne troverebbero altrettanto
difficilmente due altri che si volessero bene
più di quello che ce
mt
siamo voluti mio
fratello ed io dall’infanzia fino alla morte ».
Prospero — al secolo Luigi Taparelli
d’ Azeglio — dell’Ordine di Gesù, fu a sua
volta ben felice di riabbracciare il fratello
che gli aveva procurata una così bella improv
visata: » Mentre stavo conversando con i
miei confratelli sono avvisato di essere chia
mato alla camera ove era Massimo »: così
scriveva Prospero a suo fratello Roberto, il
2 febbraio 1842. E continua: « Tu sai già il
nostro primo incontro perchè egli te l’ ha
scritto: ma non puoi sapere tutta la mia
consolazione, niuno te la può scrivere, nep
pure io medesimo, che la provai... Quanto
abbiamo parlato di te, delle tue tribolazioni,
delle buone opere che fai... vorrei parlar teco,
vorrei esprimerti come mi sono aperto con
Massimo, vorrei sentirti, rievocarti e riab
bracciarti. Ti troveresti qui in un mondo
nuovo, un mondo propizio ai forestieri, mondo
di ammiratore, fra cui Massimo va passeg
giando come un semidio (non voglio dire
come una bestia nera) e dispensando a questo
un guardo a quel... un detto, e tutti ne riman
gono estatici! Se sapesti quante istanze ho
avute di persone che volevano vederlo, cono
scerlo, parlargli >. D’ Azeglio, tanto nel primo
che nel secondo viaggio in Sicilia avvenuti
a distanza di pochi mesi, aveva avuto infatti
liete accoglienze da Francesco Maccagnone
Principe di Granatelli, a cui nel 1844 il d’ Aze
glio presenterà il Confalonieri, e molto più
innanzi in casa sua farà stringere amicizia
col Farini e col Persano.
Il Granatelli ricevette il d’Azeglio « more
siculo » e lo stimò uno degli uomini migliori
che avesse mai conosciuto. E si ebbe anche
feste e accoglienze affettuose dal Daita che
diverrà deputato nel 1848. dall’ Amari, dal
Giacheri. dalla colta poetessa Giuseppina Tur-
risi Colonna, donna di larga cultura, di fer
vido amor patrio che trasfondeva nei suoi
canti, che solitari si levarono nella Sicilia
prima del 1848.
... / ri ri
desterò
,
detterò i morti
>
all'opra generosa
la
r
ita sacrerò
,
gli inni, il pensiero;
e più innanzi
Suoni a rampogna almen. suonin miei
alla /iacea genia
[c«n
se agli studi severi
,
alle leggiadre
opre tu inran non mi crescesti
, •
madre
.I
Il paesaggio siciliano lo conquista, il pano
rama della conca d’oro colpì l’anima del
d'Azeglio: scrivendo alla moglie durante la
seconda dimora palermitana tra il luglio e
l'agosto del 1843 si trattiene su gli incanti
della regione, si indugia a descrivere una
passeggiata alla marina, oggi nota col nome
di « Foro Italico » •<nel mezzo verso Porta
de Greci è un gran palco illuminato, con una
orchestra che suona pezzi di musica. Una
infinità di carrozze girano e si fermano ogni
tanto ad ascoltare; il marciapiede è pieno di
pedoni: la terra, il mare, la luna, il fresco,
era una scena di mille e una notte... ». Era
molestato però da un caldo terribile... « Tut-
t'altra cosa di quello di Sorrento e di Napoli;
nella camera mia — scriveva alla sua Luisa —
la sera quando vo a letto, è come un forno ».
Ma s’era nel cuore dell’estate e non si poteva
avere molto fresco specie in Sicilia. E ancora
al 25 luglio soggiungeva: •<L ’aria è grossa e
pesante e ogni mattina mi sveglio col mal di
capo, che passa però lavandomi il viso.
Quando non c’ è ventilazione il caldo è serio
davvero; ma quasi sempre un po’ d’ aria si
sente ». E al 28 luglio: « Qui abbiamo avuto
finalmente il terribile scirocco: credevo cono
scerlo da Roma, ma mi ingannavo. Il cielo
era offuscato da caligine, e s’era sentito prima
tuoni lunghi e sordi in lontananza; a un tratto
sento nella cappa una soffiata calda come
l'alito di uomo, poi avanti sempre più forte
e a poco a poco levarsi un mondo di polvere
rossiccia che sale e nasconde l’aria, Palermo,
Monte Pellegrino, il mare e tutto il paese
prende una tinta giallastra che pare un acque
rello a bistro ».
Valendosi degli studi pittorici fatti durante
la sua dimora siciliana e della « poetesca
memoria », tentò il d’Azeglio di ritrarre sulle
pareti di una sua sala a Milano le vedute
delle quattro maggiori città della Sicilia, e
due altre località meno importanti per riem
pire due campi che gli rimanevano: volle
così dedicare — come scriveva alla poetessa
Turrisi Colonna — la sua intiera camera a
memorie siciliane.
Egli stesso afferma che durante la dimora
siciliana meditava di compiere alcuni pae-
saggi per cui andava tirando giù dal vero
come gli si presentavano le occasioni. Tornato
a Milano ne informava la Turrisi Colonna,
questa gentile alunna delle Muse e le scriveva:
» non
posso dirle il piacere che ho provato in
questo lavoro e che provo sempre riveden
dolo: avrei potuto scrivervi per rammentarvi
l'ospitalità ricevuta fra loro, ma questa memo
ria l’ho scritta nel cuore, uè si cancellerà
Bai ». Cinque anni dopo la voce precorritrice
della patriottica poetessa,
onore delle
lettere
siciliane, doveva spegnersi fra il compianto
di ognuno.
Ma la compagnia preferita era però per
Massimo quella del fratello: con lui va alla
Favorita, con lui gira pe’ dintorni di Palermo
su di un muletto; «io mi son messo, egli scri
veva, alla palermitana, e giro per la città
sull’asino, pensando con dispiacere che a
Milano non si crede che questo interessante
animale sia degno di portare un galantuomo ».
I lunghi colloqui col fratello gli fanno vieppiù
scoprire il raro accordo di molteplici virtù,
le belle doti, i generosi pensieri. Luigi Tapa
relli — Prospero come sempre lo chiama
Massimo d’Azeglio — teneva allora lezioni
nel Convitto dei Gesuiti, posto ne’ locali dove
oggi vi- è la sede del Regio Liceo Vittorio
Emanuele. L ’ammirazione che il fratello laico
aveva per il fratello religioso era pienamente
giustificata, chè infatti Luigi Taparelli aveva
sortito da natura una tempra di ingegno
acutissima e singolarmente disposta alla spe
culazione. Il si»" insegno era meravigliosa
mente versatile, poderosamente aiutato da
una immaginativa pronta, splendida, nobi
lissima. Queste attitudini gli conferivano abi
lità in ogni nobile disciplina, tanto da aggiun
gere nelle arti belle, nella letteratura, nella
pittura non scarsa perfezione, nella musica
grandissima. Filosofo e giurista ci lasciò un
trattato di diritto naturale oltre all’
Esame
critico degli ordini rappresentativi della società
moderna
: più avanti, a Roma, diresse la
« Civiltà Cattolica ».
A Massimo doleva lasciare Palermo e il
fratello, ma anche questa volta dovette dirgli
addio, non senza lasciargli, di soppiatto de’
Superiori, un credito aperto di
5000
lire ed
ottenendo dal Padre Superiore del Convento
che il fratello andasse a pranzo con lui.
Da Palermo Massimo partì alla volta di
Messina e un giornale messinese dava notizia
del suo arrivo: « Massimo d’Azeglio, nome
carissimo
e
onorato nelle lettere italiane,
ritrovasi oggi nella patria di Maurolico», e
dopo aver ricordato
che
due anni innanzi
un altro illustre letterato, Cesare Cantù, era
stato ospite di Messina, richiama l’attenzione
sul romanzo
Nicolò de
’
Lapi.
E
per vero il
d’Azeglio era preceduto da nobile fama, chè
non appena era stato pubblicato
VEttore
Fieramosca,
scritto « per elettrizzare i carat
teri «, Vincenzo d’Amore aveva tolto nel
1838 dal romanzo azegliano il soggetto per
un’opera seria,
come
più tardi
ne tolse un
altro dai • Promessi Spori »
del Manzoni: la
musica venne
scritta
da Antonio
Laudano
e rappresentata la prima volta nel Refi»
Teatro
« La
Munizione ».
BMIiBa8aaiBa=^^
..................................................................................................


















