
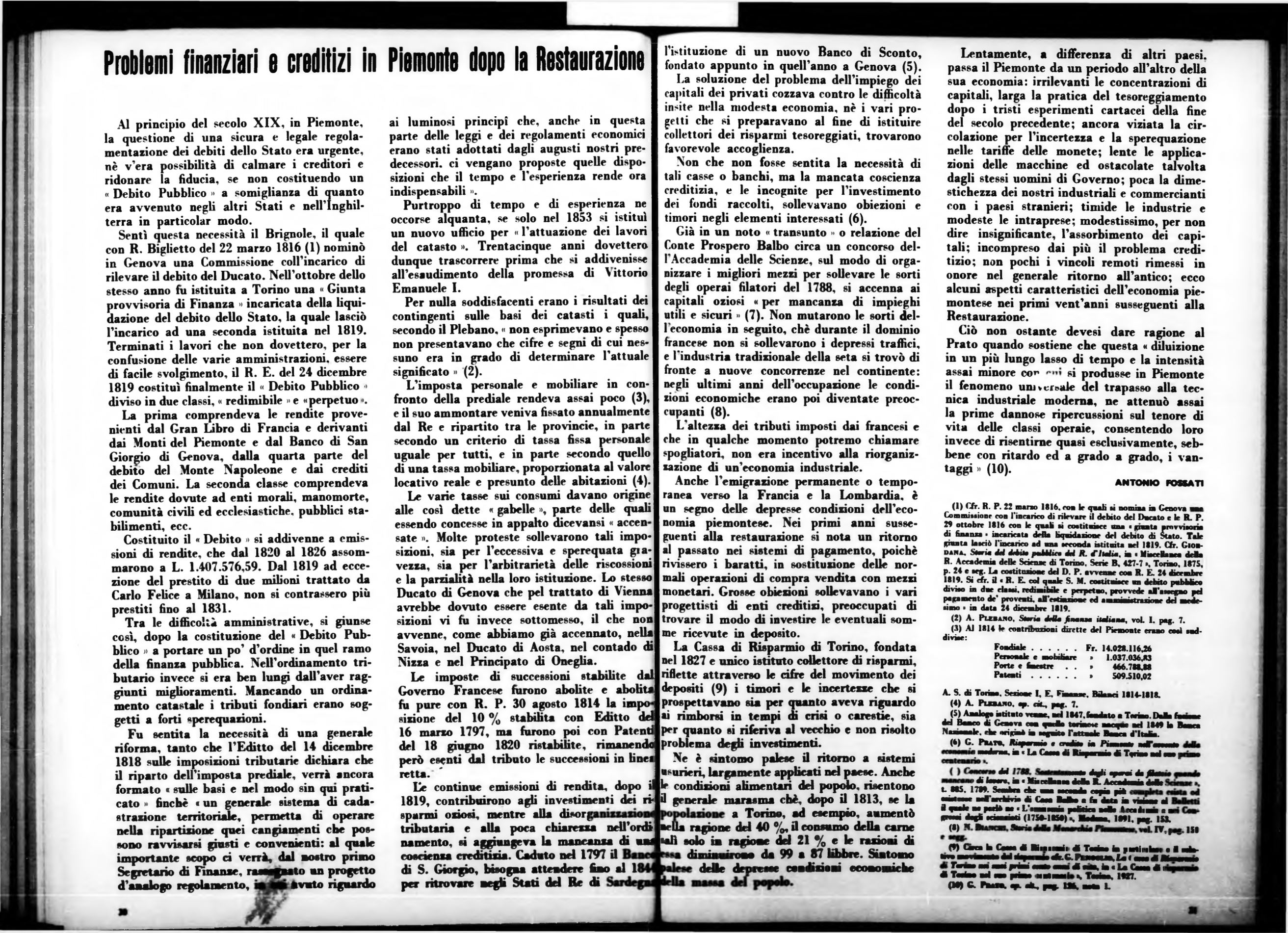
.
i
P ro b lem i f in a n z ia r i e c r e d i t iz i in P iem on te dopo la R es tau ra z ion e
a.
,
Al principio del secolo X IX , in Piemonte,
la questione di una sicura e legale regola
mentazione dei debiti dello Stato era urgente,
nè v ’era possibilità di calmare i creditori e
ridonare la fiducia, se non costituendo un
« Debito Pubblico » a somiglianza di quanto
era avvenuto negli altri Stati e nell’ Inghil
terra in particolar modo.
Sentì questa necessità il Brignole, il quale
con R. Biglietto del 22 marzo 1816 (1) nominò
in Genova una Commissione coll’ incarico di
rilevare il debito del Ducato. Nell’ottobre dello
stesso anno fu istituita a Torino una « Giunta
provvisoria di Finanza » incaricata della liqui
dazione del debito dello Stato, la quale lasciò
l’incarico ad una seconda istituita nel 1819.
Terminati i lavori che non dovettero, per la
confusione delle varie amministrazioni, essere
di facile svolgimento, il R. E. del 24 dicembre
1819 costituì finalmente il « Debito Pubblico •>
diviso in due classi, « redimibile » e «perpetuo ».
La prima comprendeva le rendite prove
nienti dal Gran Libro di Francia e derivanti
dai Monti del Piemonte e dal Banco di San
Giorgio di Genova, dalla quarta parte del
debito del Monte Napoleone e dai crediti
dei Comuni. La seconda classe comprendeva
le rendite dovute ad enti morali, manomorte,
comunità civili ed ecclesiastiche, pubblici sta
bilimenti, ecc.
Costituito il « Debito » si addivenne a emis
sioni di rendite, che dal 1820 al 1826 assom
marono a L. 1.407.576,59. Dal 1819 ad ecce
zione del prestito di due milioni trattato da
Carlo Felice a Milano, non si contrassero più
prestiti fino al 1831.
Tra le difficoltà amministrative, si giunse
così, dopo la costituzione del « Debito Pub
blico
»
a portare un po’ d’ordine in quel ramo
della finanza pubblica. NeU’ ordinamento tri
butario invece si era ben lungi dall’aver rag
giunti miglioramenti. Mancando un ordina
mento catastale i tributi fondiari erano sog
getti a forti «perequazioni.
Fu sentita la necessità di una generale
riforma, tanto che l ’ Editto del 14 dicembre
1818 sulle imposizioni tributarie dichiara che
il riparto dell’imposta prediale, verrà ancora
formato « sulle basi e nel modo sin qui prati
cato » finché « un generale sistema di cada-
strazione territoriale, permetta di operare
nella ripartizione quei cangiamenti che pos
s o n o
ravvisarsi giusti e convenienti: al quale
importante
scopo
ci verrà,
dal nostro primo
Segretario di
Finanze, rassegnato
un progetto
d’analogo regolamento,
èvuto
riguardo
ai luminosi principi che, anche in questa
parte delle leggi e dei regolamenti economici
erano stati adottati dagli augusti nostri pre
decessori. ci vengano proposte quelle dispo
sizioni che il tempo e l’esperienza rende ora
indispensabili ».
Purtroppo di tempo e di esperienza ne
occorse alquanta, se solo nel 1853 si istituì
un nuovo ufficio per « l ’attuazione dei lavori
del catasto ». Trentacinque anni dovettero
dunque trascorrere prima che si addivenisse
all’esaudimento della promessa di Vittorio
Emanuele I.
Per nulla soddisfacenti erano i risultati dei
contingenti sulle basi dei catasti i quali,
secondo il Plebano, « non esprimevano e spesso
non presentavano che cifre e segni di cui nes
suno era in grado di determinare l’ attuale
significato » (
2
).
L ’ imposta personale e mobiliare in con
fronto della prediale rendeva assai poco (3),
e il suo ammontare veniva fissato annualmente
dal Re e ripartito tra le provincie, in parte
secondo un criterio di tassa fissa personale
uguale per tutti, e in parte secondo quello
di una tassa mobiliare, proporzionata al valore
locativo reale e presunto delle abitazioni (4).
Le varie tasse sui consumi davano origine
alle così dette « gabelle », parte delle quali
essendo concesse in appalto dicevansi « accen
sate ». Molte proteste sollevarono tali impo
sizioni, sia per l’eccessiva e sperequata gia-
vezza, sia per l ’arbitrarietà delle riscossioni
e la parzialità nella loro istituzione. Lo stesso
Ducato di Genova che pel trattato di Vienna
avrebbe dovuto essere esente da tali impo
sizioni vi fu invece sottomesso, il che non
avvenne, come abbiamo già accennato, nella
Savoia, nel Ducato di Aosta, nel contado di
Nizza e nel Principato di Oneglia.
Le imposte di successioni stabilite dal
Governo Francese furono abolite e abolita
fu pure con R. P. 30 agosto 1814 la impo
sizione del 10 % stabilita con Editto del
16 marzo 1797, ma furono poi con Patenti
del 18 giugno 1820 ristabilite, rimanendo
però esenti dal tributo le successioni in linea
retta. '
jusunen, largamente applicati nel paese
Le continue emissioni di rendita, dopo i le condizioni alimentari del popolo, risentono
1819, contribuirono agli investimenti dei ri* il generale marasma chè, dopo il 1813, se la
spanni oziosi, mentre alla disor|
l’istituzione di un nuovo Banco di Sconto,
fondato appunto in quell’anno a Genova (5).
La soluzione del problema dell’ impiego dei
capitali dei privati cozzava contro le difficoltà
insite nella modesta economia, nè i vari pro
getti che si preparavano al fine di istituire
collettori dei risparmi tesoreggiati, trovarono
favorevole accoglienza.
Non che non fosse sentita la necessità di
tali casse o banchi, ma la mancata coscienza
creditizia, e le incognite per l’investimento
dei fondi raccolti, sollevavano obiezioni e
timori negli elementi interessati (
6
).
Già in un noto « transunto » o relazione del
Conte Prospero Balbo circa un concorso del-
1Accademia delle Scienze, sul modo di orga
nizzare i migliori mezzi per sollevare le sorti
degli operai filatori del 1788, si accenna ai
capitali oziosi « per mancanza di impieghi
utili e sicuri » (7). Non mutarono le sorti del
l'economia in seguito, chè durante il dominio
francese non si sollevarono i depressi traffici,
e l'industria tradizionale della seta si trovò di
fronte a nuove concorrenze nel continente:
negli ultimi anni dell’occupazione le condi
zioni economiche erano poi diventate preoc
cupanti (
8
).
L ’altezza dei tributi imposti dai francesi e
che in qualche momento potremo chiamare
spogliatoli, non era incentivo alla riorganiz
zazione di un’economia industriale.
Anche l’emigrazione permanente o tempo
ranea verso la Francia e la Lombardia, è
un segno delle depresse condizioni dell’eco
nomia piemontese. Nei primi anni susse
guenti alla restaurazione si nota un ritorno
al passato nei sistemi di pagamento, poiché
rivissero i baratti, in sostituzione delle nor
mali operazioni di compra vendita con mezzi
monetari. Grosse obiezioni sollevavano i vari
progettisti di enti creditizi, preoccupati di
trovare il modo di investire le eventuali som
me ricevute in deposito.
La Cassa di Risparmio di Torino, fondata
nel 1827 e unico istituto collettore di risparmi,
riflette attraverso le cifre del movimento dei
depositi (9) i timori e le incertezze che si
prospettavano sin per quanto aveva riguardo
si rimborsi in tempi di crisi o carestie, sia
per quanto si riferiva al vecchio e non risolto
pròblema degli investimenti.
Ne è sintomo palese il ritorno a sistemi
nsuri ri
. Anche
a Torino, ad esempio, aumentò
diminuirono da 99 a 87 libbre. Sintomo
delle depresse condizioni economiche
tributaria e alla poca chiarezza nell’ordi nella ragione del 40 %, il consumo della carne
namento, si aggiungeva la mancanza di uni «ali solo in ragione del
21 % e
le razioni di
coscienza creditizia. Caduto nel 1797 il
di S. Giorgio, bisogna attendere fino al lt
per ritrovare negli Stati del Re di
Lentamente, a differenza di altri paesi,
passa il Piemonte da un periodo all’altro della
sua economia: irrilevanti le concentrazioni di
capitali, larga la pratica del tesoreggiamento
dopo i tristi esperimenti cartacei della fine
del secolo precedente; ancora viziata la cir
colazione per l’incertezza e la sperequazione
nelle tariffe delle monete; lente le applica
zioni delle macchine ed ostacolate talvolta
dagli stessi uomini di Governo; poca la dime
stichezza dei nostri industriali e commercianti
con i paesi stranieri; timide le industrie e
modeste le intraprese; modestissimo, per non
dire insignificante, l’assorbimento dei capi
tali; incompreso dai più il problema credi
tizio; non pochi i vincoli remoti rimessi in
onore nel generale ritorno all’antico; ecco
alcuni aspetti caratteristici dell’economia pie
montese nei primi vent’anni susseguenti alla
Restaurazione.
Ciò non ostante devesi dare ragione al
Prato quando sostiene che questa « diluizione
in un più lungo lasso di tempo e la intensità
assai minore co*’
si produsse in Piemonte
il fenomeno uni versale del trapasso alla tec
nica industriale moderna, ne attenuò assai
la prime dannose ripercussioni sul tenore di
vita delle classi operaie, consentendo loro
invece di risentirne quasi esclusivamente, seb
bene con ritardo ed a grado a grado, i van
taggi » (
10
).
ANTONIO FOSSATI
(1) Lfr. R. P. 22 mano 1816. con Ir quali ti nomina in Genova ° " »
Commissione con l'incarico di rilevare il debito del Ducato e le R. P.
29 ottobre 1816 con le quali «i costituisce una • punta provvisoria
di finanza • incaricato della liquidazione del debito di Stato. Tale
giunto lasciò l'incarico ad una seconda istituita nel 1819. Cfr.
G io r
d a n a
.
Storia del debito pubblico dei R. d 'ita li
«i, in « Miscellanea della
R. Accademia delle Scienze di Torino, Serie B, 427-7 », Torino, 1875,
p. 24 e seg. La costituzione del D. P. avvenne con R. E. 24 dicembre
1819. Si cfr. il « R. E. eoi quale S. M. costituisce un debito pubblico
diviso in due classi, redimibile e perpetuo, provvede all'assegno pel
pagamento de' proventi, all'estinzione ed amministrazione del awde*
simo > in dato 24 dicembre 1819.
(2)
A.
P
lebano
,
Storia detta finanxa italiana
,
voL 1.
pag.
7.
(3) Al 1814 le contnbnzioni dirette del Piemonte erano cosi sud
divise:
Fondiate................. Fr. 14.028.116,26
Personale e mobiliare » 1.037.036,83
Porto e finestre . , >
466.788,88
P a t e n t i........................
509.510,02
A. S. di Torino, Sezione I, E, Finanze, Bilanci 1814-1818.
(4) A. Plebano.
op.
du,
pag. 7.
(5) Analogo istituto venne, nel 1847,fondato a Torino. Dalla finoae
del Banco di Genova
cm
quello tarine* nacque nel 1849 la Banca
Nazionale, ebe originò in seguito l'attuale Banca d'Italia.
(6) G. Piato,
Risparmio
« tradii» in
Piemomtr
mJTmmmrn
[moderna,
in « La Cam di Risparmio di Torino ari na |
•rata
degli operai
da
firn
i deSa IL Accademia deSe
dei
__________
>di I— rs, in • MisreSaara <______________________
t- 885, 17S9. Sembra ebe una .«cada copia p ii —
esistesse nrll'arrInvio di Gara Baks a fn data ia niaae ai
9 quale ne pari* ne ■L’sm s
mia
politica naie I w I im a
m
grami degli « i n aiati (17SS-1850)., Modena, 1891, pag. 153.
(8) * »■ »-—. «— •-
~ — |
i rr. j ^
it i
(9) Caca la Caaaa di l iiBinaii di Tariaa ia putii a h i • 2 aria-
traa a n n a t a dri Spanala
cfc.
C. t a m i a .
La t
amadi B a r n
Tanna aa aaai primi aan» aaas di naia, la • La Gaan di i
di T a t a ari n prina M inim i s Tarino. 1927.
(M ) C. P
baiw
. qp. aÉL, pag. lift, anta L


















