
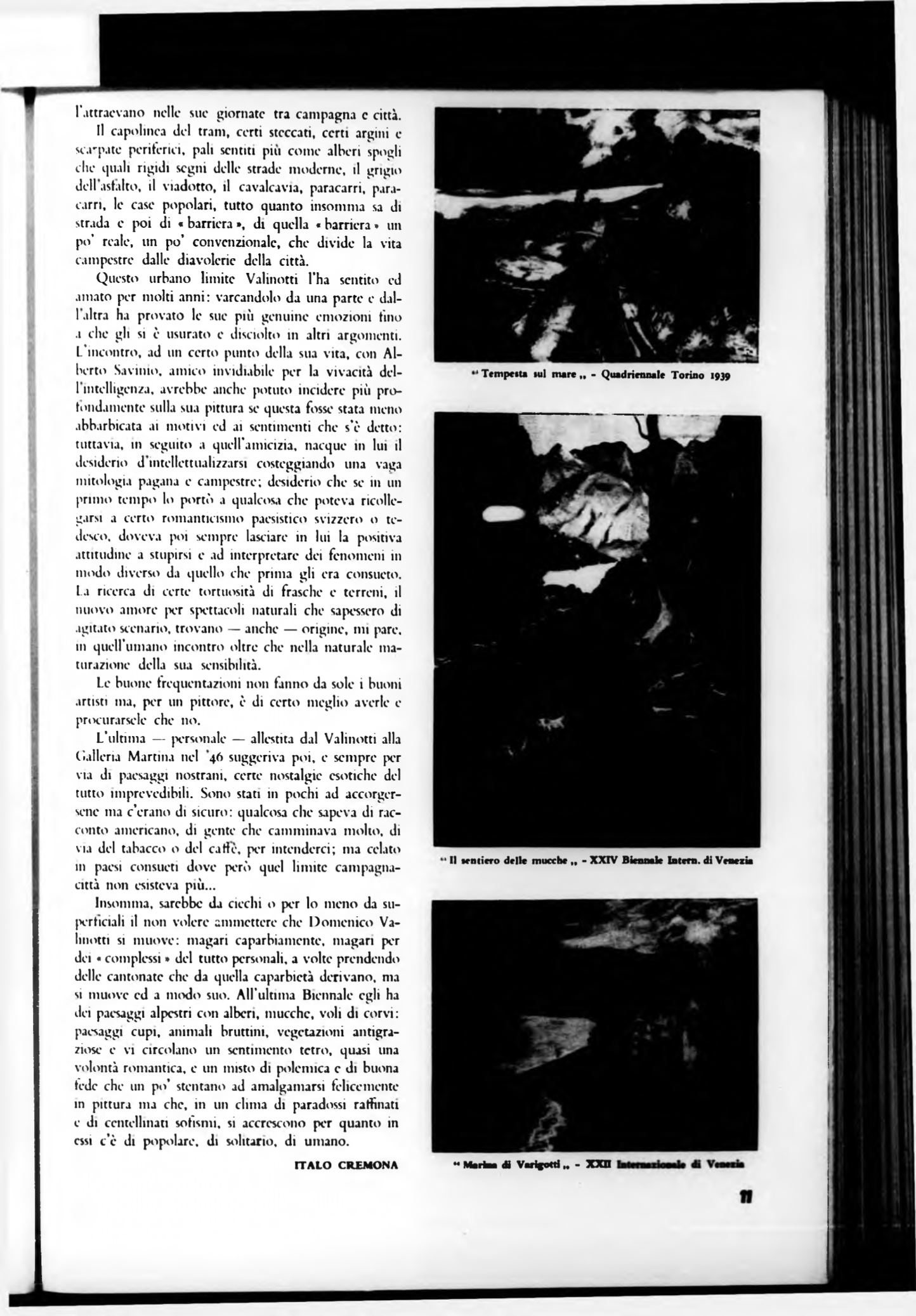
l’attraevano nelle sue giornate tra campagna e città.
Il
capolinea del tram, certi steccati, certi argini e
sca-patc periferici, pali sentiti piti come alberi spogli
d ie quali rigidi segni delle strade moderne, il grigio
dell asfalto, il viadotto, il cavalcavia, paracarri, para
carri, le case popolari, tutto quanto insomma sa di
strada e poi di « barriera », di quella « barriera » un
po’ reale, un po’ convenzionale, che divide la vita
campestre dalle diavolerie della città.
Questo urbano limite Valinotti l’ha sentito ed
amato per molti anni: varcandolo da una parte e dal-
1 altra ha provato le sue più genuine emozioni fino
•i che gli si è usurato e disciolto in altri argomenti.
L’incontro, ad un certo punto della sua vita, con Al
berto Savimo, amico invidiabile per la vivacità del-
1 intelligenza, avrebbe anche potuto incidere più pro
tondamente sulla sua pittura se questa fosse stata meno
abbarbicata ai motivi ed ai sentimenti che s’ù detto:
tuttavia, in seguito a qucU’amicizia, nacque in lui il
desiderio d intellettualizzarsi costeggiando una vaga
mitologia pagana e campestre; desiderio che se in un
primo tempo lo portò a qualcosa che poteva ricolle
garsi a certo romanticismo paesistico svizzero o te
desco. doveva poi sempre lasciare in lui la positiva
attitudine a stupirsi e ad interpretare dei fenomeni in
modo diverso da quello che prima gli era consueto.
La ricerca di certe tortuosità di frasche e terreni, il
nuovo amore per spettacoli naturali che sapessero di
agitato scenario, trovano — anche — origine, mi pare,
in qucH’umano incontro oltre che nella naturale ma
turazione della sua sensibilità.
Le buone frequentazioni 11011 fanno da sole i buoni
artisti ma, per un pittore, è di certo meglio averle e
procurarsele che 110.
L’ultima — personale — allestita dal Valinotti alla
Galleria Martina nel 46 suggeriva poi, e sempre per
via di paesaggi nostrani, certe nostalgie esotiche del
tutto imprevedibili. Sono stati in pochi ad accorger
sene ma c’erano di sicuro: qualcosa che sapeva di rac
conto americano, di gente che camminava molto, di
via del tabacco o del carte, per intenderci; ma celato
in paesi consueti dove però quel limite campagna-
città non esisteva più...
Insomma, sarebbe da cicchi o per lo meno da su
perficiali il non volere ammettere che Domenico Va-
linotti si muove: magari caparbiamente, magari per
dei «complessi » del tutto personali, a volte prendendo
delle cantonate che da quella caparbietà derivano, ma
si muove ed a modo suo. AU’ultima Biennale egli ha
dei paesaggi alpestri con alberi, mucche, voli di corvi:
paesaggi cupi, animali bruttini, vegetazioni antigra
ziose e vi circolano un sentimento tetro, quasi una
volontà romantica, e un misto di polemica e di buona
fede che 1111 po’ stentano ad amalgamarsi felicemente
in pittura ma che, in un clima di paradossi ratinati
e di centellinati sofismi, si accrescono per quanto in
essi c’è di popolare, di solitario, di umano.
1Tempeste sul mare „ - Quadriennale Torino 1939
1II sentiero delle mucche „ - XXIV Biennale Intera, di Venezia
ITALO CREMONA
“ Marina di Varigotti,. - XXII


















