
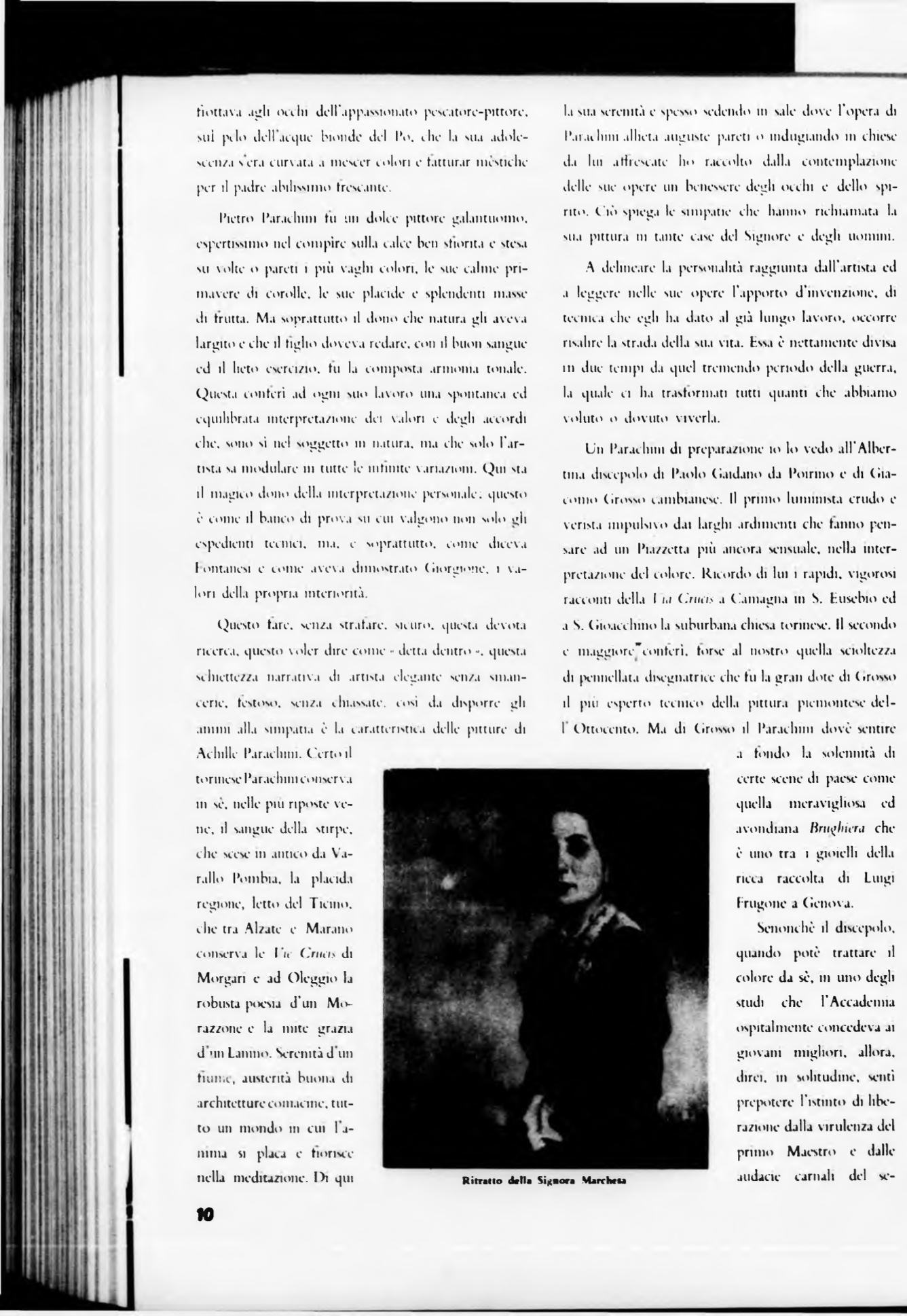
fiottava agli occhi deH’appassionato pescatore-pittore,
sui pilo ildl acque biondo del Po, elio la sua adole
scenza s era curvata a mescer colori e fatturar mestichi-
per il padre abilissimo trescante.
Pietro Paraclnm tu un dolce pittore galantuomo,
espertissimo nel compire sulla calce ben sfiorita e stesa
sii \olte o pareti i più vaghi colori, le sue calme pri
mavere di corolle, le sue placide e splendenti masse
di trutta. Ma soprattutto il dono che natura gli aveva
largito e che il tiglio doveva rodare, con il buon sangue
ed il lieto esercizio, tu la composta armonia tonale.
Questa conferì ad ogni suo lavoro una spontanea ed
equilibrata interpretazione dei valori e degli accordi
che. sono sì nel soggetto in natura, ma che solo l’ar
tista sa modulare 111 tutte le infinite variazioni. Qui sta
il magico dono della interpretazione personale; questi*
è come il banco di prova su cui valgono non solo «jli
espedienti tecnici, ma. e soprattutto, come diceva
f ontanesi e come aveva dimostrato Cìiorgione, i va
lori della propria interiorità.
Questo tare, senza strafare, sicuro, questa devota
ricerca, questo voler dire come • detta dentro -, questa
schiettezza narrativa di artista elegante senza sman
cerie, festoso, senza chiassate, cosi da disporre gli
animi alla simpatia è la caratteristica delle pitture di
Achille Paraelnni. Certo il
torinese Paraclnm conserva
in se. nelle più riposte ve
ne, il sangue della stirpe,
che scese in antico da Ya-
rallo Pombia. la placida
regione, letto del Ticino,
che tra Alzate e Marano
conserva le I ’ie
Crucis
di
Morgan e ad O leggio la
robusta poesia d’ un Mo-
razzone e la mite grazia
d un Lanino. Serenità d un
fiume, austerità buona di
architetture coniatine, tut
to un mondo m cui l a-
nima si placa e fiorisce
nella meditazione. I>i qui
IO
la sua serenità e spesso sedendo in sale dove l’opera di
Parai Inni allieta auguste pareti o indugiando in chiese
da lui affrescate ho raccolto dalla contemplazione
dello sue opero un benessere degli occhi e dello spi
rito. C iò spiega le simpatie che hanno richiamata la
sua pittura ni tante case del Signore e degli uomini.
A delineare la personalità raggiunta dall’artista ed
a leggero nelle sue opere l’apporto d ’invenzione, di
tecnica ohe egli ha dato al già lungo lavoro, occorre
risalire la strada della sua vita. Essa è nettamente divisa
in due tempi da quel tremendo periodo della guerra,
la quale ci ha trasformati tutti quanti che abbiamo
voluto o dovuto viverla.
Un Paraclnm di preparazione io lo vedo all’ Alber
tina discepolo di Paolo Caldano da Poirino e di Gia
como Grosso eambianese. Il primo luminista crudo e
verista impulsivo dai larghi ardimenti che tanno pen
sare ad un Piazzetta più ancora sensuale, nella inter
pretazione del colore. Ricordo di lui i rapidi, vigorosi
racconti della I
h i
Crucis
a Camagna in S. Eusebio ed
a S. Gioacchino la suburbana chiesa torinese. Il secondo
e m agg io rile in te ri, torse al nostro quella scioltezza
di pennellata disegnatricc che tu la gran dote di (irosso
il più esperto tecnico della pittura piemontese de 1-
I Ottocento. Ma di Grosso il Paraclnm dovè sentire
a tondo la solennità di
certe scene di paese come
quella meravigliosa ed
avondiana
Brughiera
che
è uno tra ì gioielli della
ricca raccolta di Luigi
Frugone a Genova.
Senonchò il discepolo,
quando potè trattare il
colore da sè, m uno degli
studi che
l’ Accademia
ospitalmente concedeva ai
giovani migliori, allora,
direi, in solitudine, sentì
prepotere l’istinto di libe
razione dalla virulenza del
pruno Maestro e dalle
audacie carnali del se
R itratto della Signora M a rchia


















