
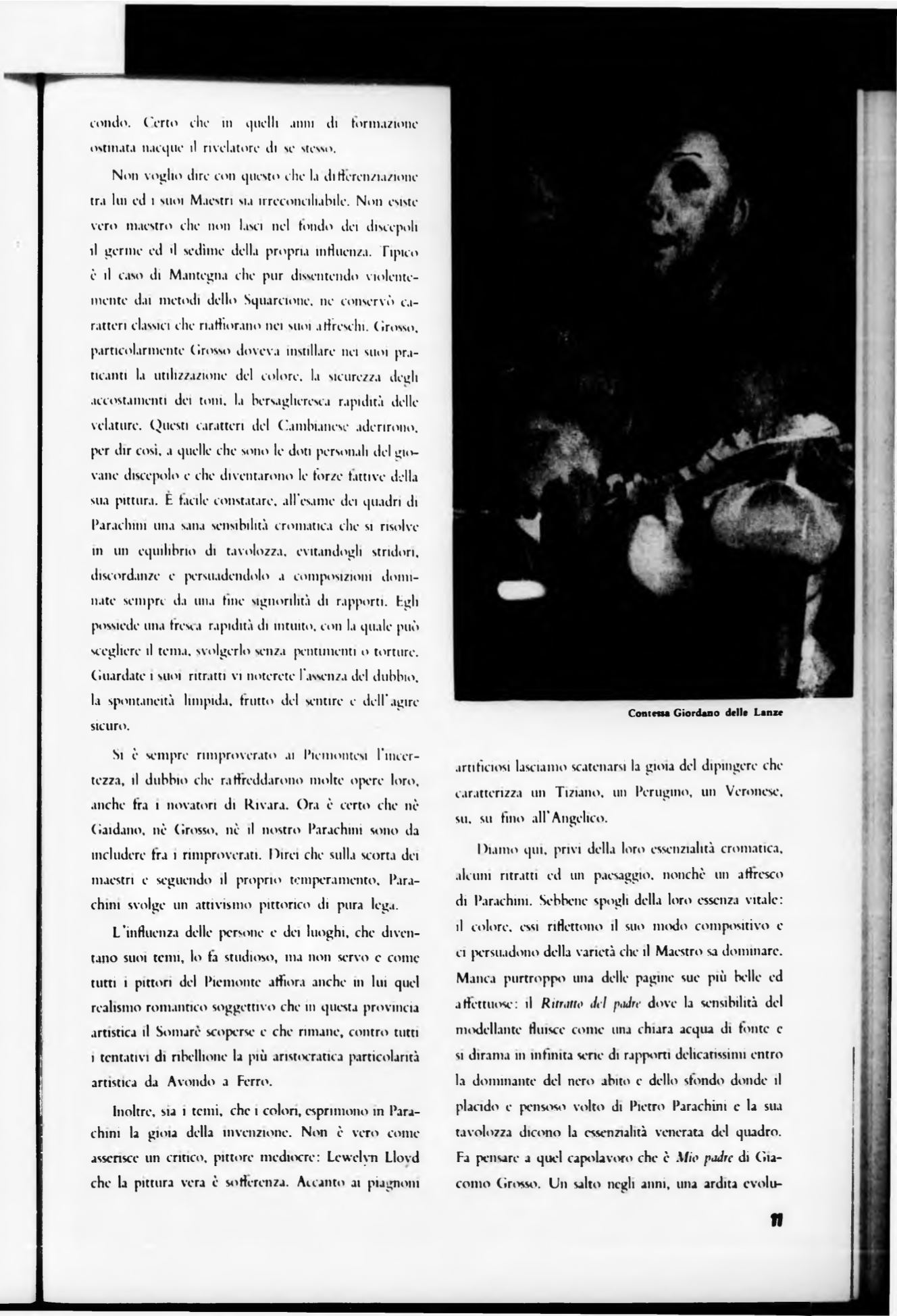
condo. (.'orto clu* in quelli anni ili formazione
ostinata nacque il rivelatore di se stesso.
Non voglio dire con questo che la differenziazione
tra lui ed 1 suoi Maestri sia irreconciliabile. Non esiste
vero maestro che non lasci nel tondo dei discepoli
il germe ed 'I sedimo della propria influenza. Tipico
è il caso di Mantegna che pur dissentendo violente
mente dai metodi dello Squarcione, ne conservò ca
ratteri classici che riaffiorano nei suoi affreschi. Grosso,
particolarmente (ìrosso doveva instillare nei suoi pra
ticanti la utilizzazione del colore, la sicurezza dotili
accostamenti dei toni, la bersaglieresca rapidità delle
velature. Questi caratteri del Cambiancse aderirono,
per dir cosi, a quelle che sono le di'ti personali ilei mo
vane discepolo e che diventarono le forze fattive della
sua pittura. E tacile constatare. aH'esame dei quadri di
Paraclum una sana sensibilità cromatica che si risolve
in un equilibrio di tavolozza, evitandogli stridori,
discordanze e persuadendolo a composizioni domi
nate sempre da una fine signorilità di rapporti. Egli
possiede una fresia rapidità di intuito, con la quale può
scegliere il tema, svolgerlo senza pentimenti o torture.
Guardate 1 suoi ritratti vi noterete l’assenza del dubbio,
la spontaneità limpida, frutto del sentire e dell’ agire
sicuro.
Si è sempre rimproverato ai Piemontesi l’incer
tezza, il dubbio che raffreddarono molte opere loro,
anche tra 1 novatori di R ivara. Ora è certo che nò
Gaidano, nè (ìrosso, nè il nostro Parachini sono da
includere tra i rimproverati. Direi che sulla scorta dei
maestri e seguendo il proprio temperamento. Para-
chini svolge un attivismo pittorico di pura lega.
L ’influenza delle persone e dei luoghi, che diven
tano suoi temi, lo ta studioso, ma non servo c come
tutti 1 pittori del Piemonte affiora anche in lui quel
realismo romantico soggettivo che in questa provincia
artistica il Somare scoperse e che rimane, contro tutti
i tentativi di ribellione la più aristocratica particolarità
artistica da Avondo a Ferro.
Inoltre, sia i temi, che 1 colon , esprimono in Para-
chini la gioia della invenzione. Non è vero come
asserisce un critico, pittore mediocre : Lcwclyn Llovd
che la pittura vera è sofferenza. Accanto ai piagnoni
Conteso Giordano delle Lanze
artificiosi lasciamo scatenarsi la gioia del dipingere che
caratterizza un Tiziano, un Perugino, un Veronese,
su. su tino all’ Angelico.
Diamo qui, privi della loro essenzialità cromatica,
alcuni ritratti ed un paesaggio, nonché un affresco
di Parachini. Sebbene spogli della loro essenza vitale:
il colore, essi riflettono il suo modo compositivo e
ci persuadono della varietà che il Maestro sa dominare.
Manca purtroppo una delle pagine sue più belle ed
affettuose: il
Ritratto Jc l ptuirc
dove la sensibilità del
modellante fluisce come una chiara acqua di tonte e
si dirama in infinita serie di rapporti delicatissimi entro
la dominante del nero abiti1* c dello sfondo donde il
placido e pensoso volto di Pietro Parachini e la sua
tavolozza dicono la essenzialità venerata del quadro.
Fa pensare a quel capolavoro che è
Mio padre
di Gia
como (ìrosso. Un salto negli anni, una ardita evolu
ii
|


















