
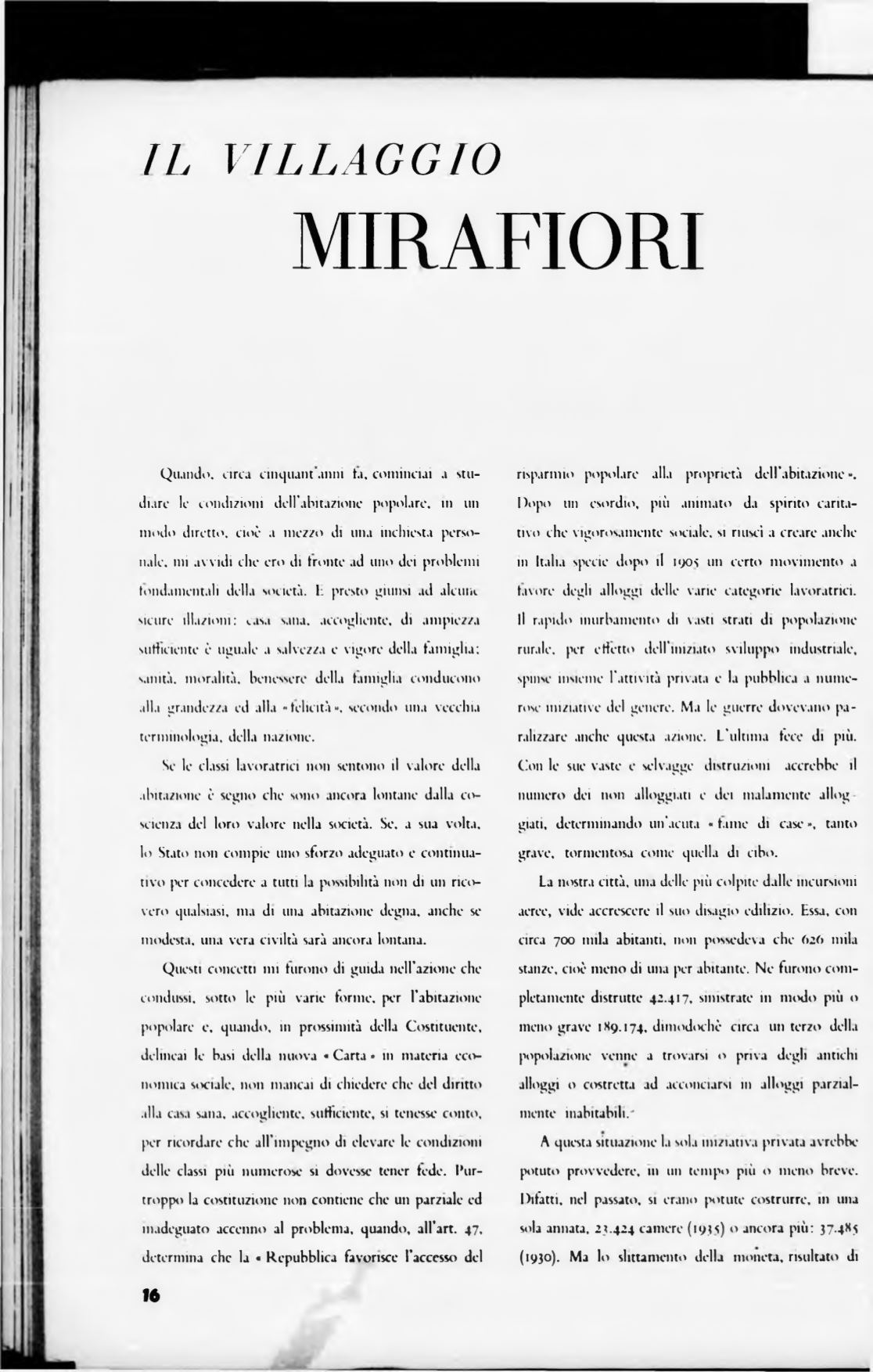
I L V I L L A G G I O
MIRAFIORI
Quando, circa cinquant anni fa, cominciai a stu
diare le condizioni dell’abitazione popolare, in un
modo diretto, cioè a mezzo di una inchiesta perso
nale. mi avvidi che ero di fronte ad uno dei problemi
fondamentali della società. E presto giunsi ad alcuni,
sicure illazioni: casa sana, accogliente, di ampiezza
sufficiente è uguale a salvezza e vigore della famiglia;
sanità, moralità, benessere della famiglia conducono
alla grandezza ed alla «felicità ». secondo una vecchia
terminologia, della nazione.
Se le classi lavoratrici non sentono il valore della
abitazione è segno che sono ancora lontane dalla civ-
scienza del loro valore nella società. Se. a sua volta,
lo Stato non compie uno sforzo adeguato e continua
tivo per concedere a tutti la possibilità non di un rico
vero qualsiasi, ma di una abitazione degna, anche se
modesta, una vera civiltà sarà ancora lontana.
Questi concetti mi furono di guida nell’azione che
condussi, sotto le più varie forme, per l’abitazione
popolare e, quando, in prossimità della Costituente,
delincai le basi della nuova « Carta • in materia eco
nomica s»>ciale, non mancai di chiedere che del diritto
alla casa sana, accogliente, sufficiente, si tenesse conto,
per ricordare che all’ impegno di elevare le condizioni
delle classi più numerose si dovesse tener fede. Pur
troppo la costituzione non contiene che un parziale ed
inadeguato accenno al problema, quando, all’art. 47,
determina che la « Repubblica favorisce l’accesso del
V6
risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione ».
Dopo un esordio, più animato da spirito carita
tivo che vigorosamente sociale, si riuscì a creare anche
111 Italia specie dopo il 190S un certo movimento .1
favore degli alloggi delle varie categorie lavoratrici.
Il rapidi' inurbamento di vasti strati di popolazione
rurale, per effetto dell'iniziato sviluppi industriale,
spinse insieme l'attività privata e la pubblica a nume
rose iniziative del genere. Ma le guerre dovevano pa
ralizzare anche questa azione. L'ultima fece di più.
Con le sue vaste e selvagge distruzioni accrebbe il
numero dei non alloggiati e dei malamente allog
giati, determinando un’acuta « fame di case », tanto
grave, tormentosa come quella di cibo.
La nostra città, una delle più colpite dalle incursioni
aeree, vide accrescere il suo disagio edilizio. Essa, con
circa 700 mila abitanti, non possedeva che 626 mila
stanze, cioè meno di una per abitante. Ne furono com
pletamente distrutte 42.417, sinistrate in modo più o
meno grave 1S9 .174, dimodoché circa un terzo della
popolazione venne a trovarsi o priva degli antichi
alloggi o costretta ad acconciarsi in alloggi parzial
mente inabitabili.'
A questa situazione la sola iniziativa privata avrebbe
potuto provvedere, 111 un tempo più o meno breve.
Difatti, nel passato, si erano potute costruire, 111 una
sola annata. 23.424 camere (193s) o ancora più: 37.4X5
(1930). Ma lo slittamento della moneta, risultato di


















