
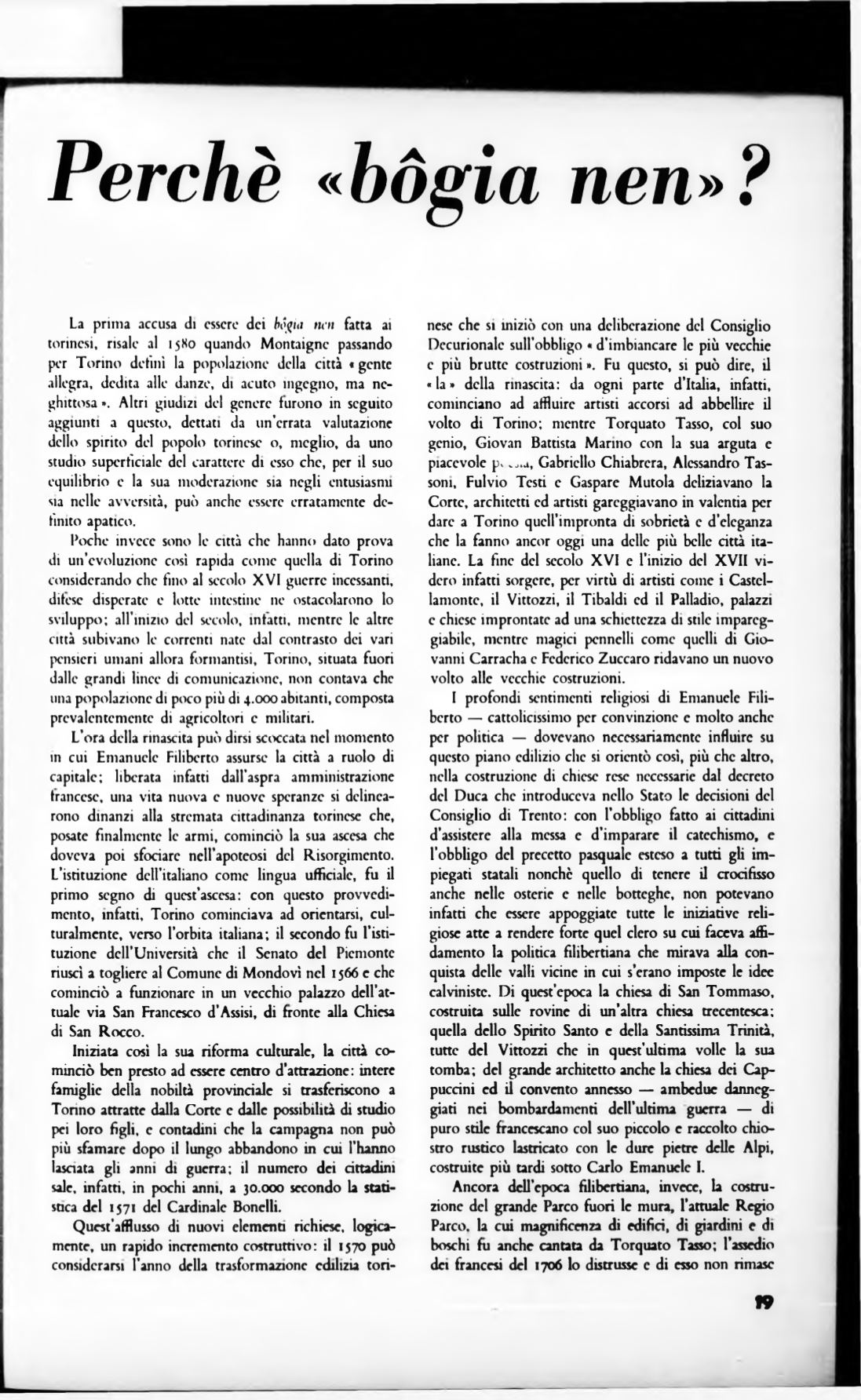
Perchè «bógia nen»?
La prima accusa di essere dei
bógia tien
fatta ai
torinesi, risale al 15S0 quando Montaigne passando
per Torino definì la popolazione della città «gente
allegra, dedita alle danze, di acuto ingegno, ma ne
ghittosa ». Altri giudizi del genere furono in seguito
aggiunti a questo, dettati da un’errata valutazione
dello spirito del popolo torinese o, meglio, da uno
studio superficiale del carattere di esso che, per il suo
equilibrio e la sua moderazione sia negli entusiasmi
sia nelle avversità, può anche essere erratamente de
finito apatico.
Poche invece sono le città che hanno dato prova
di un’evoluzione così rapida come quella di Torino
considerando che fino al secolo XV I guerre incessanti,
difese disperate e lotte intestine ne ostacolarono lo
sviluppo; all’inizio del secolo, infatti, mentre le altre
città subivano le correnti nate dal contrasto dei vari
pensieri umani allora formantisi, Torino, situata fuori
dalle grandi lince di comunicazione, non contava che
una popolazione di poco più di 4.000 abitanti, composta
prevalentemente di agricoltori e militari.
L’ora della rinascita può dirsi scoccata nel momento
in cui Emanuele Filiberto assurse la città a ruolo di
capitale; liberata infatti dall’aspra amministrazione
francese, una vita nuova e nuove speranze si delinca
rono dinanzi alla stremata cittadinanza torinese che,
posate finalmente le armi, cominciò la sua ascesa che
doveva poi sfociare nell’apoteosi del Risorgimento.
L’istituzione dell’italiano come lingua ufficiale, fu il
primo segno di quest’ascesa: con questo provvedi
mento, infatti, Torino cominciava ad orientarsi, cul
turalmente, verso l’orbita italiana; il secondo fu l’isti
tuzione dcll’Università che il Senato del Piemonte
riuscì a togliere al Comune di Mondovì nel 1566 e che
cominciò a funzionare in un vecchio palazzo dell’at
tuale via San Francesco d’Assisi, di fronte alla Chiesa
di San Rocco.
Iniziata così la sua riforma culturale, la città co
minciò ben presto ad essere centro d’attrazione: intere
famiglie della nobiltà provinciale si trasferiscono a
Torino attratte dalla Corte e dalle possibilità di studio
pei loro figli, e contadini che la campagna non può
più sfamare dopo il lungo abbandono in cui l’hanno
lasciata gli anni di guerra; il numero dei cittadini
sale, infatti, in pochi anni, a 30.000 secondo la stati-
snea del 1571 del Cardinale Bonelli.
Quest’afflusso di nuovi elementi richiese, logica
mente, un rapido incremento costruttivo: il 1570 può
considerarsi l’anno della trasformazione edilizia tori
nese che si iniziò con una deliberazione del Consiglio
Decurionalc sull’obbligo « d’imbiancare le più vecchie
e più brutte costruzioni ». Fu questo, si può dire, il
«la» della rinascita: da ogni parte d’Italia, infatti,
cominciano ad affluire artisti accorsi ad abbellire il
volto di Torino; mentre Torquato Tasso, col suo
genio, Giovan Battista Marino con la sua arguta e
piacevole pv ^.a, Gabriello Chiabrera, Alessandro Tas
soni, Fulvio Testi e Gaspare Mutola deliziavano la
Corte, architetti ed artisti gareggiavano in valentia per
dare a Torino quell’impronta di sobrietà e d’eleganza
che la fanno ancor oggi una delle più belle città ita
liane. La fine del secolo XV I e l’inizio del XV II vi
dero infatti sorgere, per virtù di artisti come i Castcl-
lamontc, il Vittozzi, il Tibaldi ed il Palladio, palazzi
e chiese improntate ad una schiettezza di stile impareg
giabile, mentre magici pennelli come quelli di Gio
vanni Carracha e Federico Zuccaro ridavano un nuovo
volto alle vecchie costruzioni.
I
profondi sentimenti religiosi di Emanuele Fili
berto — cattolicissimo per convinzione e molto anche
per politica — dovevano necessariamente influire su
questo piano edilizio clic si orientò così, più che altro,
nella costruzione di chiese rese necessarie dal decreto
del Duca che introduceva nello Stato le decisioni del
Consiglio di Trento: con l’obbligo fatto ai cittadini
d’assistere alla messa e d’imparare il catechismo, e
l’obbligo del precetto pasquale esteso a tutti gli im
piegati statali nonché quello di tenere il crocifisso
anche nelle osterie e nelle botteghe, non potevano
infatti che essere appoggiate tutte le iniziative reli
giose atte a rendere forte quel clero su cui faceva affi
damento la politica filibertiana che mirava alla con
quista delle valli vicine in cui s’erano imposte le idee
calvinistc. Di quest’epoca la chiesa di San Tommaso,
costruita sulle rovine di un’altra chiesa trecentesca;
quella dello Spirito Santo e della Santissima Trinità,
tutte del Vittozzi che in quest’ultima volle la sua
tomba; del grande architetto anche la chiesa dei Cap
puccini ed il convento annesso — ambedue danneg
giati nei bombardamenti dell’ultima guerra — di
puro stile francescano col suo piccolo e raccolto chio
stro rustico lastricato con le dure pietre delle Alpi,
costruite più tardi sotto Carlo Emanuele I.
Ancora dell’epoca filibertiana, invece, la costru
zione del grande Parco fuori le mura, l’attuale Regio
Parco, la cui magnificenza di edifìci, di giardini e di
boschi fu anche cantata da Torquato Tasso; l’assedio
dei francesi del 1706 lo distrusse e di esso non rimase
•9


















