
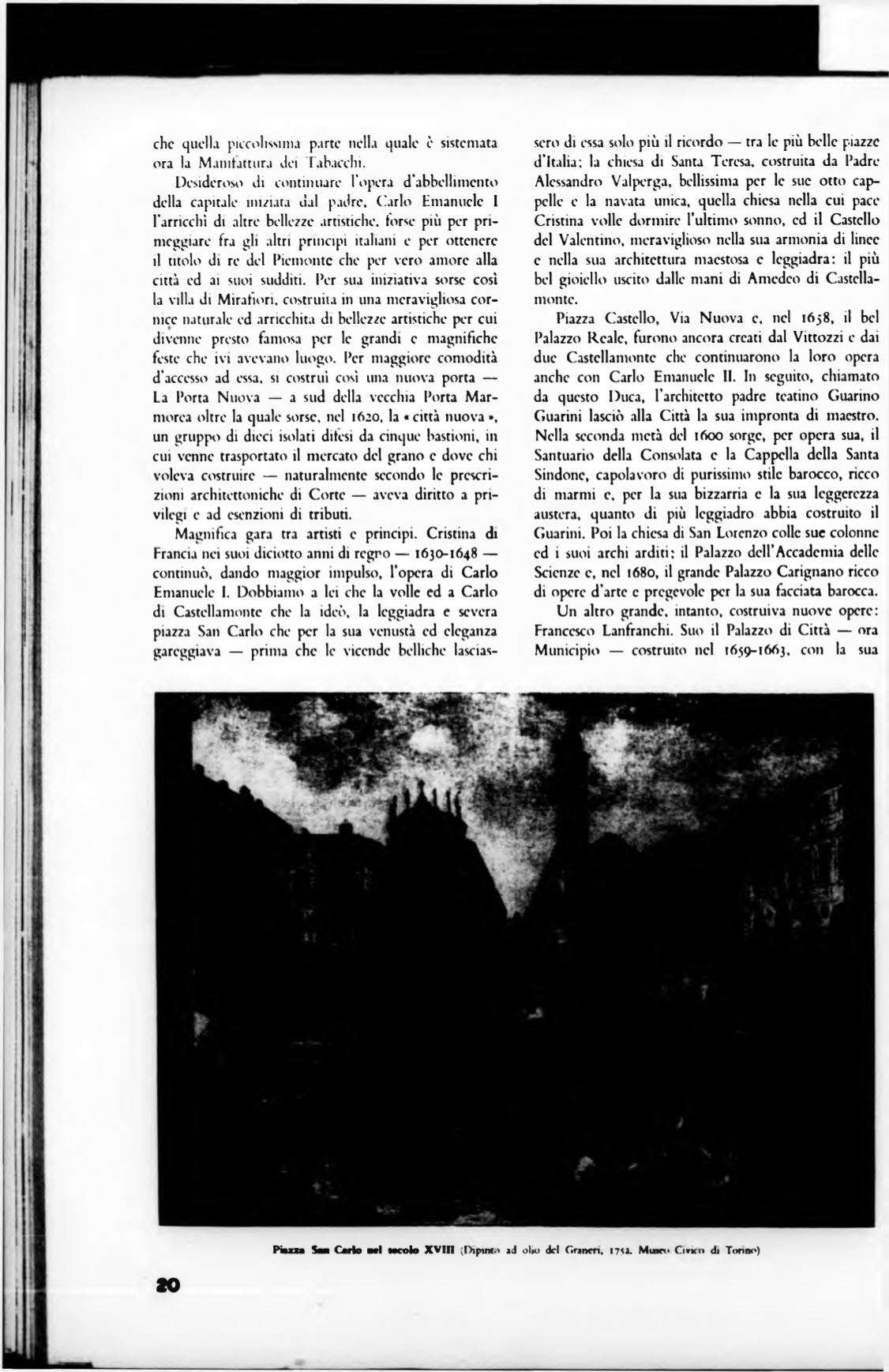
che quella piccolissima parte nella quale è sistemata
ora la Manifattura dei Tabacchi.
Desideroso di continuare l’opera d’abbellimento
della capitale iniziata dal padre, Carlo Emanuele
1
l’arricchi di altre bellezze artistiche, forse più per pri
meggiare fra gli altri principi italiani e per ottenere
il titolo di re del Piemonte che per vero amore alla
città ed ai suoi sudditi. Per sua iniziativa sorse così
la villa di Mirafiori, costruita in una meravigliosa cor
nice naturale ed arricchita di bellezze artistiche per cui
divenne presto famosa per le grandi e magnifiche
feste che ivi avevano luogo. Per maggiore comodità
d’accesso ad essa, si costruì così una nuova porta —
La Porta Nuova — a sud della vecchia Porta Mar
morea oltre la quale sorse, nel 1620, la « città nuova »,
un gruppo di dieci isolati ditesi da cinque bastioni, in
cui venne trasportato il mercato del grano e dove chi
voleva costruire — naturalmente secondo le prescri
zioni architettoniche di Corte — aveva diritto a pri
vilegi e ad esenzioni di tributi.
Magnifica gara tra artisti e principi. Cristina di
Francia nei suoi diciotto anni di regno — 1630-1648 —
continuò, dando maggior impulso, l’opera di Carlo
Emanuele I. Dobbiamo a lei che la volle ed a Carlo
di Castellamonte che la ideò, la leggiadra e severa
piazza San Carlo che per la sua venustà ed eleganza
gareggiava — prima che le vicende belliche lascias
sero di essa stilo più il ricordo — tra le più belle piazze
d’ Italia; la chiesa di Santa Teresa, costruita da Padre
Alessandro Valperga, bellissima per le sue otto cap
pelle e la navata unica, quella chiesa nella cui pace
Cristina volle dormire l’ ultimo sonno, ed il Castello
del Valentino, meraviglioso nella sua armonia di linee
e nella sua architettura maestosa e leggiadra: il più
bel gioiello uscito dalle mani di Amedeo di Castclla-
montc.
Piazza Castello, Via Nuova e, nel 1658, il bel
Palazzo Reale, furono ancora creati dal Vittozzi e dai
due Castellamonte che continuarono la loro opera
anche con Carlo Emanuele II. In seguito, chiamato
da questo Duca, l’ architetto padre teatino Guarino
Guarini lasciò alla Città la sua impronta di maestro.
Nella seconda metà del 1600 sorge, per opera sua, il
Santuario della Consolata e la Cappella della Santa
Sindone, capolavoro di purissimo stile barocco, ricco
di marmi e, per la sua bizzarria e la sua leggerezza
austera, quanto di più leggiadro abbia costruito il
Guarini. Poi la chiesa di San Lorenzo colle sue colonne
ed i suoi archi arditi: il Palazzo dell’ Accademia delle
Scienze e, nel 1680, il grande Palazzo Carignano ricco
di opere d ’arte e pregevole per la sua facciata barocca.
Un altro grande, intanto, costruiva nuove opere:
Francesco Lanfranchi. Suo il Palazzo di Città — ora
Municipio — costruito nel 1659-1663, con la sua
20
Piazza San Carlo n*l Meolo XVIII
(Dipinto j J olio del O inm , 1751.
Mino>
Civho di Tonni')


















