
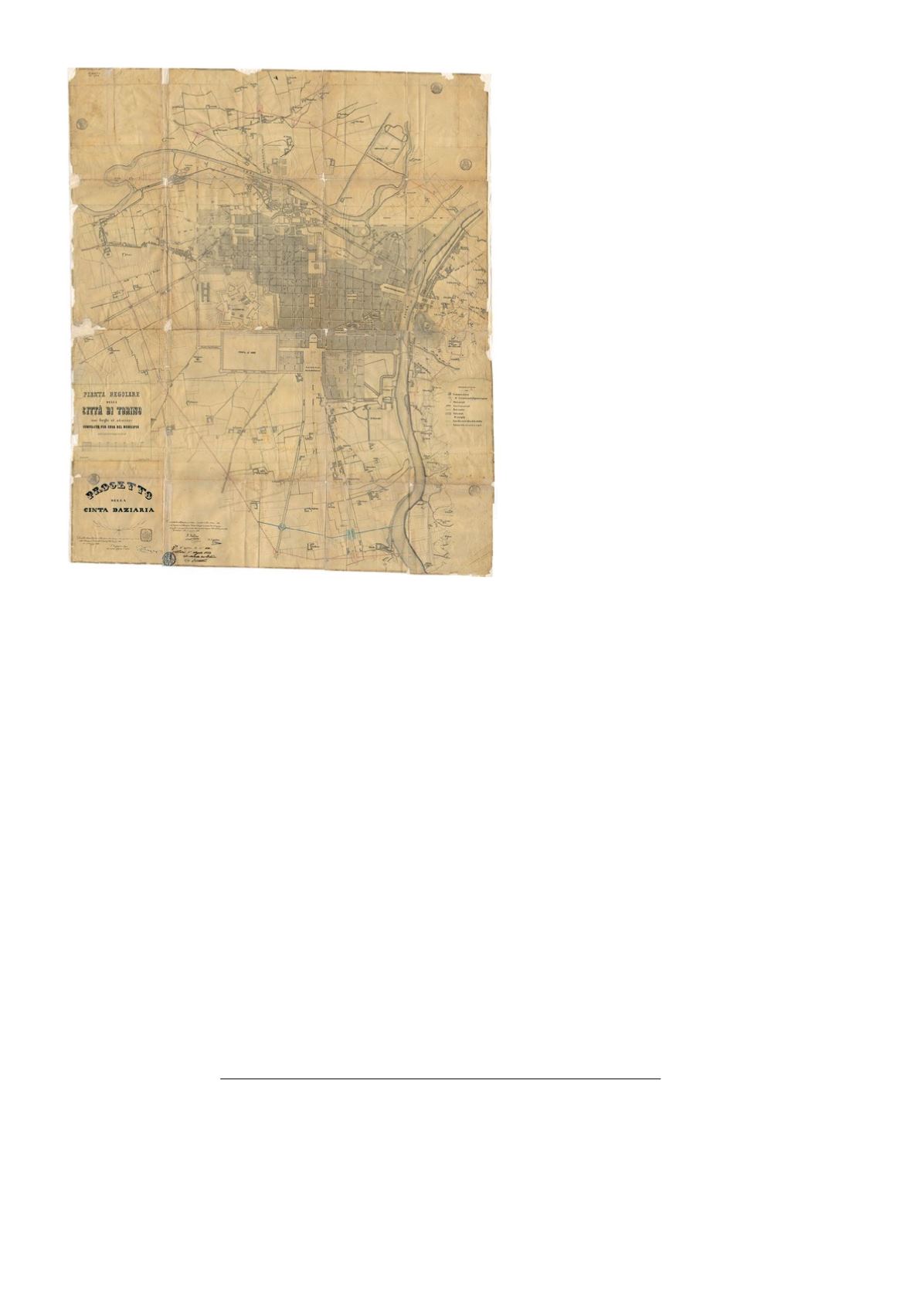
30
questo e dal
Regolamento per la Riscossione
del Dazio di Consumo della Città di Torino
29
si
evincono sia i motivi della scelta di erigere la
cinta, sia il suo andamento, fondamentale per
le vicende dei borghi e delle borgate torinesi
30
.
Le implicazioni delle scelte del tracciato
sono state discusse con dovizia di argomenti
in sede specifica, ma alcune annotazioni sono
fondamentali: innanzitutto la scelta di lascia-
re – volutamente e insistitamente – il cimitero
monumentale fuori dalla cinta, a questo tan-
gente, poi la scelta di includere quella che è
stata definita come «la zona delle frodi» [ossia
del contrabbando] di San Salvario invece all’in-
terno della cinta e non da meno la scelta di
contenere entro il perimetro soggetto al dazio
nuclei che avrebbero potuto garantire un con-
sistente gettito quali la Crocetta, il Martinetto,
San Donato e borgo Dora e di includervi simil-
mente le aree connesse alla servitù militare
della Cittadella
31
.
Il perimetro della cinta, con la sua elimi-
nazione e l’entrata in funzione di una secon-
da linea daziaria, nel 1912, lascerà un anello
di circonvallazione attorno alla città, formato
dai corsi Bramante, Lepanto, Pascoli – fino ad
anni recenti, prima dell’abbassamento della linea del ferro con interruzione in corrispon-
denza del raccordo ferroviario tra Porta Nuova e Porta Susa, presso corso Mediterraneo –
Mediterraneo, Ferrucci, Tassoni, Svizzera, Mortara, Vigevano, Novara, Tortona. Sempre la
presenza della cinta, era evidenziato già nell’imponente lavoro di analisi dei
Beni Culturali
Ambientali nel Comune di Torino
, dava origine a quelli che erano individuati come «tessuti
minori e lottizzazioni esterni alla Cinta Daziaria del 1853»
32
.
La nuova definizione della città e del suo contado, nonché il perimetro della cinta da-
ziaria e le nuove linee ferroviarie adatte al ruolo di capitale nazionale appaiono in una
revisione cartografica denominata
Carta Topografica dei Contorni di Torino
, del 1855
33
,
sempre del geometra Rabbini, di fatto revisione della precedente
Topografia della Città e
Territorio di Torino
di cui si è detto.
A integrazione delle scelte dettate dal tracciamento della prima cinta daziaria si inseri-
sce il
Regolamento per l’Ornato e la Polizia Edilizia della Città di Torino
, approvato nel 1862
ed entrato in vigore l’anno successivo, al quale si collega la notevole
Pianta della Città e
Borghi di Torino colle sue adiacenze
34
.
A Unità d’Italia compiuta e a perdita del ruolo di capitale ormai avvenuta si colloca il
completamento della imponente opera rappresentata dal catasto Rabbini, sempre del ge-
ometra Antonio, attuato con un’imponente schiera di misuratori e vera fonte capitale per
lo studio della struttura storica della città, dei suoi borghi e delle sue borgate. Anche qui si
rimanda alla specifica scheda di approfondimento, ricordando solo che ovviamente i fogli
29
Regolamento e Tariffa del Dazio di Consumo della Città di Torino
, Tip. Eredi Botta, Torino 1854, ancora in
Ibid
., p. 35 sg.
30
Art. 3 del Regolamento.
31
Ancora Lupo, Paschetto, 2005, p. 39.
32
Viglino Davico, 1986, p. 67.
33
Geom. Antonio Rabbini,
Carta Topografica dei Contorni di Torino
, 1855. ASCT,
Tipi e disegni
, 64-8-5.
34
Città di Torino, l’Ingegnere Capo della Città, Pecco,
Pianta della Città e Borghi di Torino colle sue adia-
cenze
, 1862. ASCT, Serie 1K,
Decreti Reali
, 1848-1863, n.11, tav. 295. Riferimenti bibliografici fondamentali:
Comoli Mandracci, 1984; Lupo, 1989; Lupo, 2001; Lupo, Paschetto, 2005, pp. 60-62.
9. Edoardo Pecco,
Pianta
Regolare della Città di To-
rino suoi Borghi ed adia-
cenze compilata per cura
del Municipio sulla scala
della mappa territoriale.
Progetto della Cinta Dazia-
ria
, 1853. ASCT, Serie 1K,
Decreti Reali
, 1849-1863,
n. 11, f. 106.


















