
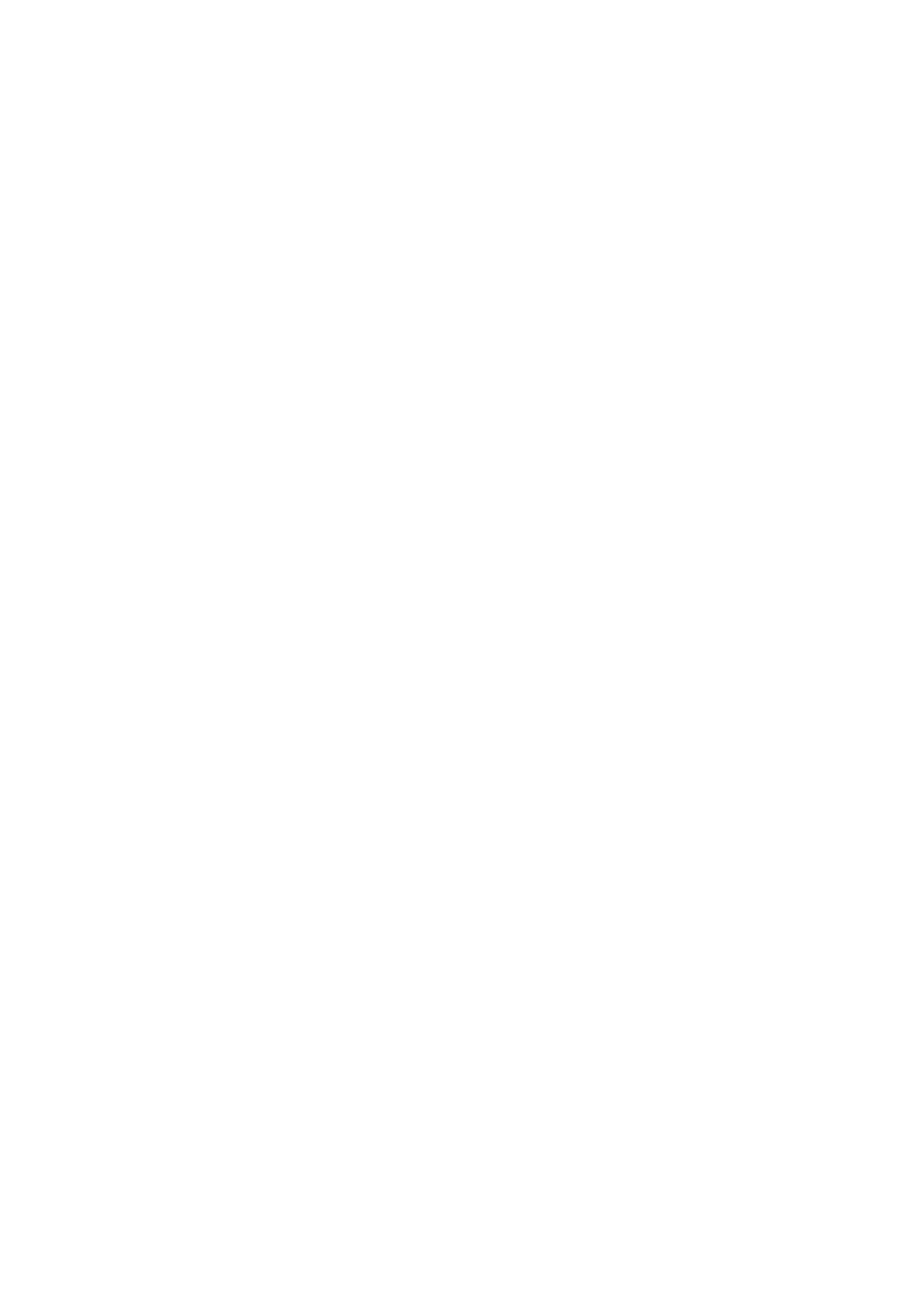
108
Parte prima Declino economico ed equilibrio istituzionale (1280-1418)
va ed erano quasi tutti capifamiglia quelli che presentavano al comune
la dichiarazione dei propri beni per la redazione dell’estimo
23
. Come
normalmente avveniva in Piemonte nella compilazione dei catasti, es-
si non erano tuttavia obbligati a dichiarare il numero delle bocche a
proprio carico e ciò impedisce di ragionare in termini statistici sulla
consistenza numerica dei singoli nuclei familiari. Si sa tuttavia che le
famiglie dei cittadini agiati, nobili o popolari, potevano allargarsi fino
a comprendere, non soltanto una numerosa prole, ma fratelli, sorelle,
nuore, bovari, scudieri, magazzinieri, fantesche, nutrici e servitori. Per
gli statuti torinesi del 1360 costituivano infatti una famiglia tutti colo-
ro che vivevano sotto lo stesso tetto: «appellatione familie uxor nurus
continentur et filii et bubulci et scutifferi, canevarii, pedissequa, baiu-
la et alii mercenarii et sorores et fratres»
24
.
Pur non indicando il numero delle bocche a carico dei singoli contri-
buenti, gli estimi torinesi offrono indizi certi di sensibili trasformazioni
delle strutture familiari nell’ultimo medioevo. I volumi più antichi della
serie menzionano infatti un numero abbastanza alto di dichiarazioni fi-
scali femminili, che nel 1349-50 raggiungono la proporzione del 12,9 per
cento degli iscritti a catasto e nel 1363 del 17,8 per cento. Esse sono sta-
te per lo più presentate da vedove, talora espressamente menzionate ac-
canto ai loro figli, ma anche da orfani di padre, ancora sotto tutela. An-
che se tutte le dichiarazioni non corrispondono a veri e propri fuochi o
nuclei familiari, non c’è dubbio che la proporzione complessiva delle nu-
bili e delle vedove non rimaritate è sensibilmente più forte di quanto non
risulti più tardi, dagli estimi di fine Trecento o dei primi decenni del
Quattrocento (cfr. tab. 1). Che a tale proporzione corrisponda una per-
centuale altrettanto elevata di uomini soli, celibi o vedovi, è dimostrato
da un conto delle bocche di Moncalieri del 1374. Su 838 nuclei familia-
ri censiti, 90 (il 10,7 per cento) sono retti da donne, 39 delle quali vivo-
no sole, proprio come risulta dal conto per 35 uomini. Ne viene così con-
fermata l’ipotesi neomalthusiana secondo cui le strutture demografiche
evidenziate da queste fonti e caratterizzate da un numero relativamente
alto di vedovi e di eterni celibi, si sono definite, nei loro tratti fonda-
mentali, prima della peste nera con lo scopo di frenare l’incremento del-
la popolazione
25
.
23
Sulle modalità di formazione degli estimi torinesi:
pascale
,
Fisionomia territoriale
cit.,
pp. 200 sgg.
24
d. bizzarri
(a cura di),
Gli statuti del comune di Torino del 1360
, Torino 1933 (BSSS, 138/1),
p. 100, cap. 223.
25
r. comba
,
«Apetitus libidinis coherceatur». Strutture demografiche, reati sessuali e disciplina dei
comportamenti nel Piemonte tardomedievale
, in «Studi Storici»,
xxvii
(1986), pp. 529-76 (soprat-
tutto pp. 556-57).


















