
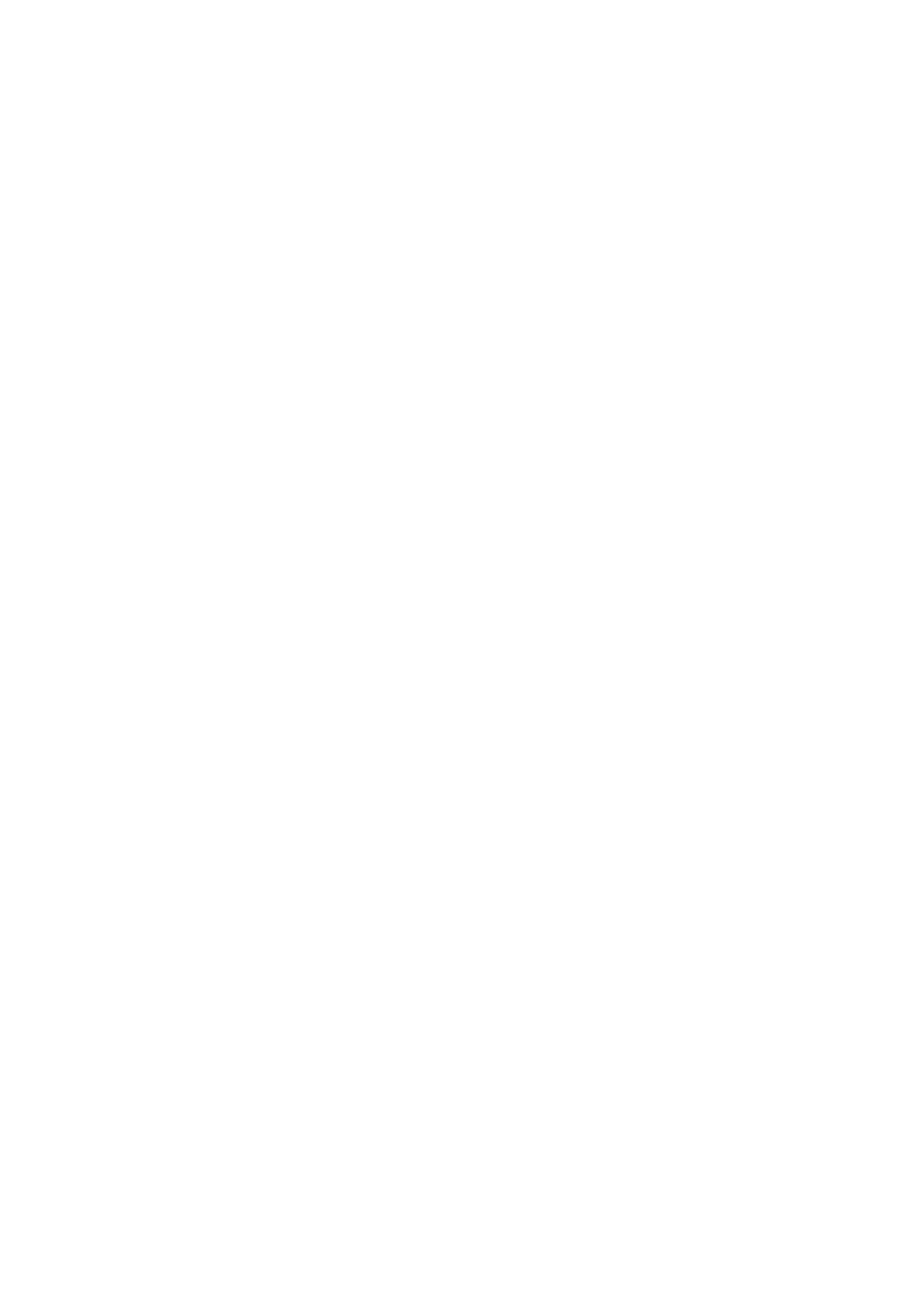
qualcuno disposto a pagar loro la giornata. Non che un maniscalco o un
bettoliere fossero sempre al sicuro dalla miseria: negli anni terribili di
fine Trecento, Oddone della Cornaglia, figlio di Michele taverniere, e
nipote di quell’Oddone della Cornaglia che prima della peste del 1348
era stato addirittura membro del consiglio di credenza, è cassato dal re-
gistro catastale, perché «mendicator est et bona sua disperssit»
16
. Assai
più rilevante è però la presenza in città di un proletariato industriale,
composto appunto di tessitori e filatrici, di cui è difficile accertare il pe-
so quantitativo, ma che senza dubbio comprendeva molti dei cittadini
più poveri iscritti a catasto. La frequente menzione di questi lavoratori
nelle fonti trecentesche conferma l’importanza che la produzione tessi-
le, pur non raggiungendo mai né in quantità né in qualità il livello di
Chieri o Pinerolo, rivestiva tuttavia nella vita della città.
Che si trattasse di una manodopera prevalentemente femminile, è
dimostrato dalla frequenza con cui disposizioni statutarie e interventi
legislativi, ma anche documenti privati, menzionano le lavoratrici, an-
ziché genericamente i lavoratori, dell’industria tessile; un dato tanto più
impressionante in quanto a quest’epoca le donne, escluse di fatto dalla
vita economica, rappresentavano di solito una componente assai poco
visibile della società. Così, gli statuti precisano che il giudice era tenu-
to a nominare ogni anno due mercanti, in rappresentanza di tutti gli im-
prenditori che avevano investito il loro denaro nell’industria tessile, col
compito di visitare almeno una volta al mese le case di tutti coloro che
partecipavano alla lavorazione «et eciam per domos mulierum que fila-
verint tramam», verificando la correttezza della procedura seguita. Lo
stesso accadeva nell’industria del cotone e del lino, sicché ad esempio il
notaio Giuliano di Cavaglià, che dichiara nel 1402 l’intenzione di im-
pegnarsi nella produzione di fustagni, quando parla dei suoi lavoranti li
chiama dapprima «persone qui filabunt cotonum», ma poi senz’altro «fi-
latrices ad filandum cotonum». Pochi anni prima il consiglio di creden-
za, intervenendo per fissare il salario dei tessitori, si era impegnato ad
ascoltare l’opinione dei «testoribus et testricibus», con una formula-
zione che ancora una volta testimonia l’importanza decisiva assunta dal-
la manodopera femminile
17
.
Quel provvedimento, preso nel 1393, riguardava l’industria della
tela, le cui maestranze si dimostravano particolarmente agguerrite. In
quell’occasione, i lavoranti del lino si rivolsero al consiglio di credenza
Gruppi e rapporti sociali
173
16
Cfr. ASCT, Dor. 1349, f. 33
v
; Dor. 1363, f. 19
v
; Dor. 1369, f. 11
r
; Dor. 1391, f. 39
r
, e
Coll. V, n. 1133.
17
BSSS, 138/1, pp. 143 sg.; ASCT,
Ordinati
, 34, f. 60
r
; 43, f. 103
r
.


















