
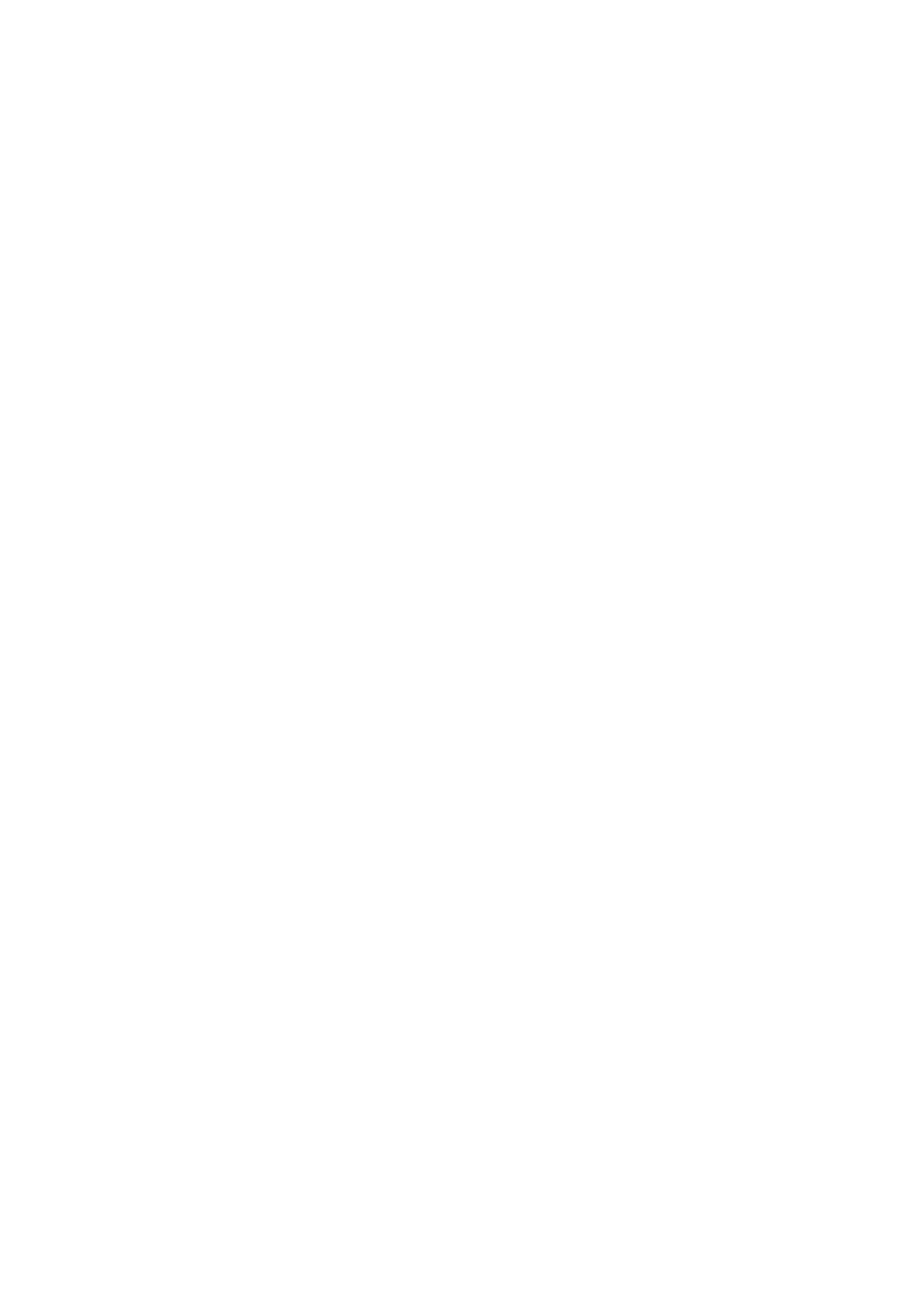
residenti nella città ma non soggetti alla sua giurisdizione, e percepiti
proprio per questo come una minaccia per la pacifica convivenza dei
cives
all’interno delle mura cittadine. Il metodo suggerito «pro refre-
nanda clericorum malitia et culpa» era assai pragmatico, nello stile del-
la Società, e sdegnoso di sottigliezze giuridiche: osservando che la pre-
senza dei chierici era una costante fonte di lagnanze, «quod experien-
tia docuit, quod in hac civitate Taurini multa mala prosilierunt ex culpis
et excessibus clericorum», e ben sapendo che la loro tracotanza era in-
coraggiata dalla certezza dell’impunità, gli statuti stabilivano la so-
spensione unilaterale dei privilegi ecclesiastici, disponendo che i chie-
rici colpevoli di offese, percosse, ferite o uccisioni dovessero incorre-
re nella medesima vendetta «quam incurreret laycus non existens de
Societate», compresa l’adunata dei soci sotto la casa dell’offensore e
la sua demolizione a colpi di piccone. Gli statuti precisavano bensì,
non senza ottimismo, che il principe avrebbe dovuto convincere la
Chiesa torinese ad avallare tali misure, procurando lettere di confer-
ma col sigillo episcopale; ma tutto lascia pensare che lo scrupolo lega-
litario fosse puramente formale, e che non si sarebbe certo atteso il
consenso del vescovo per mettere in vigore, in caso di necessità, le mi-
sure previste
41
.
La larghissima autonomia di cui la Società disponeva, sia pure sotto
il controllo del vicario e del giudice, per mantenere l’ordine, con i me-
todi più sbrigativi, nella città e nel suo territorio sembra insomma con-
figurare per l’organizzazione il ruolo di un vero e proprio braccio arma-
to della comunità, dalle funzioni insostituibili anche in una città come
la Torino del secondo Trecento, in cui il tasso di violenza all’interno del-
le mura si era forse attenuato rispetto alla turbolenza dei primi decenni
del Trecento; non per nulla Ludovico d’Acaia, confermando per l’ulti-
ma volta, nel 1417, gli statuti della Società, dichiarò di aver voluto in-
coraggiare quei cittadini che non solo con la buona volontà, ma coi fat-
ti si proponevano di difendere la pace nei suoi domini e in particolare a
Torino, assicurando coi loro sforzi il «tranquillum statum totius comu-
nitatis eiusdem loci». Al tempo stesso non si può escludere che proprio
per la sua capacità di organizzare militarmente i cittadini in caso di ne-
cessità, tramite una procedura su cui i rappresentanti del principe eser-
citavano un controllo puramente formale, l’associazione abbia suscita-
Gruppi e rapporti sociali
189
41
BSSS, 138/2, p. 40. Il ricordo della congiura del 1334, promossa dal prevosto del capitolo
Giovanni Zucca e in cui diversi canonici avevano avuto un ruolo di primo piano, non fu probabil-
mente estraneo all’introduzione di queste norme, che tuttavia assumono nel quotidiano contesto
della vita cittadina un carattere ben più generale.


















