
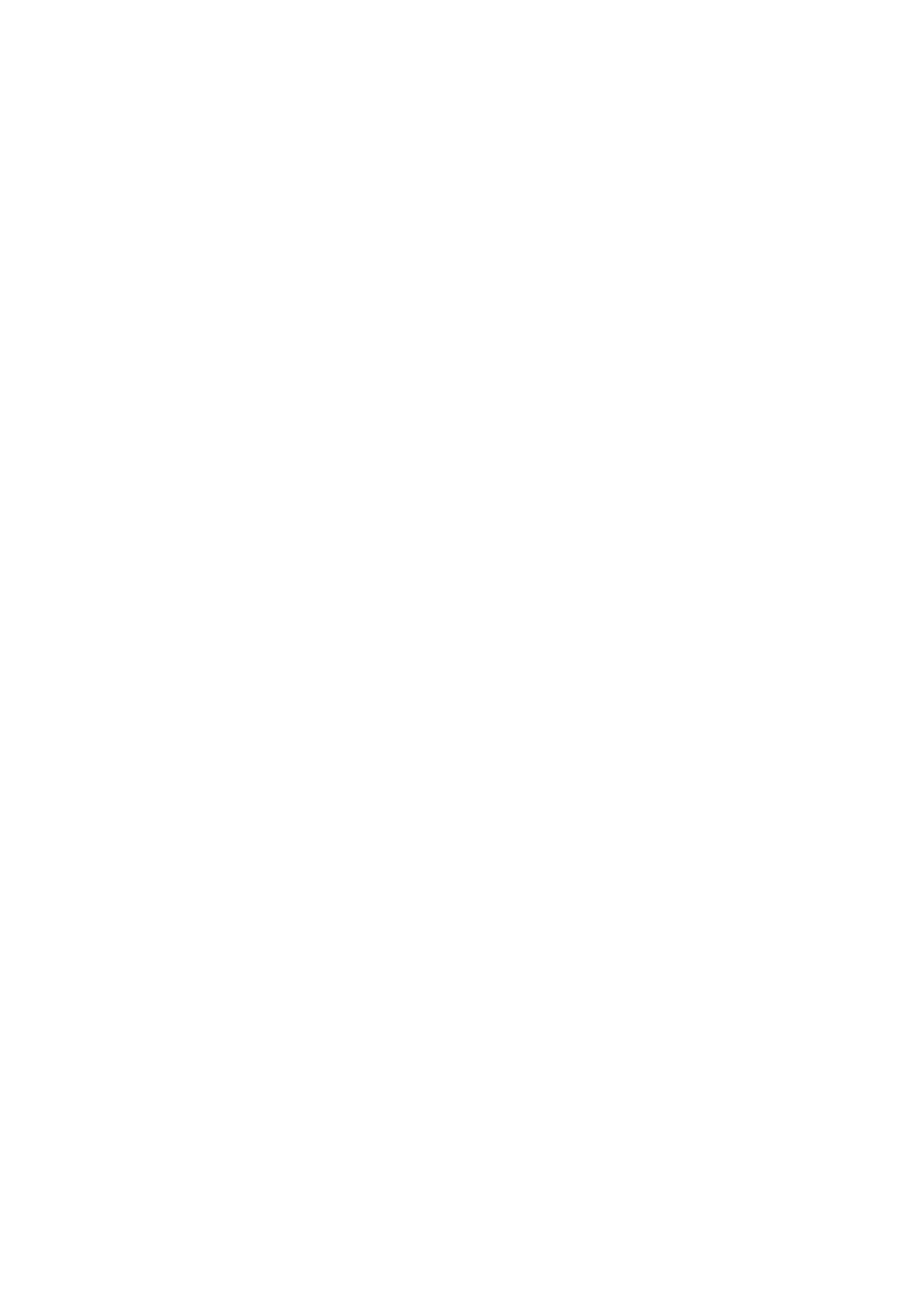
248
Parte prima Declino economico ed equilibrio istituzionale (1280-1418)
petenze, dei limiti e delle responsabilità degli amministratori comuna-
li e dei notai
77
. Si tratta di settori di grande rilievo sia per la colletti-
vità che per i singoli, a cui si aggiungono numerose altre norme a di-
sciplinare aspetti specifici della vita locale: il cittadino torinese trova
nella disposizione scritta dello statuto un punto di certezza per i suoi
comportamenti ed un freno alla discrezionalità di funzionari signorili
e comunali
78
.
Lo statuto rappresenta la garanzia dell’autonomia del comune: per
questo il primo capitolo del
liber statutorum
del 1360 impone – signifi-
cativamente – al vicario sabaudo ed al suo giudice di giurare che regge-
ranno la città «secondo il diritto, gli statuti, i capitoli e le disposizioni
seguenti, e conserveranno e rispetteranno gli stessi capitoli e statuti suc-
cessivi come sono», ribadendo tale impegno nei capitoli immediatamente
successivi ed al termine della raccolta
79
. La nuova dominazione di Ame-
deo VI riconosce al comune un’autonomia statutaria simile a quella di
altre città piemontesi soggette ai Savoia nel secolo
xiv
80
, cancellando
espressamente le pesanti restrizioni al
ius statuendi
torinese imposte da
Tommaso III nel 1280: il comune ritorna a potersi dare autonomamen-
te statuti, anche se necessita del consenso sabaudo, ma esclude in ma-
teria una competenza signorile diretta
81
. Il vicario ed il giudice, inviati
dal conte a governare ed amministrare la giustizia in città, si sovrap-
pongono all’ordinamento comunale, ma giurano di applicarne la disci-
plina attraverso il rispetto degli statuti, senza cercare di evitarne l’ap-
plicazione
82
.
77
Nel trattano, ad esempio, i capp.
iii
,
xxix
,
xxxiii
-
xxxiv
,
lxv
,
cccx
-
cccxii
,
cccxxiii
,
cccxxvii
.
78
In proposito sono significativi i capitoli iniziali e finali della raccolta, i primi probabilmen-
te dedotti dal
liber
precedente modificato secondo le necessità del momento, gli ultimi ritrovati
qua e là fra gli statuti precedenti ed inseriti al termine della raccolta anche se spesso ripetitivi dei
primi. Naturalmente, queste garanzie scritte sulla carta dovevano essere poi rispettate nella realtà…
e si sa che non sempre ciò avviene o è avvenuto. D’altronde, all’epoca si era ben lontani da quello
che sarà poi propagandato come lo «Stato di diritto», aspirazione tendenziale alla cui realizzazio-
ne per lo più non si riesce a giungere…
79
BSSS, 138/1, pp. 18-19, 145-46 (capp.
i-ii
,
iv-vi
,
cccxxvi
). È probabile che il cap.
i
derivi
dalla precedente raccolta del 1280 (
ibid.
, pp.
lxxix-lxxx
); gli altri potrebbero essere tratti da quel-
le anteriori. È noto, d’altronde, che le compilazioni statutarie erano per lo più redatte trascriven-
do i diversi
capitula
come si trovavano, senza fonderli fra loro: questo può essere un esempio, ti-
pico di una ripetitività di affermazioni, che si preferirebbero coordinate in un solo capitolo.
80
Si possono ad esempio ricordare Aosta, Ivrea, Chieri, Biella, Cuneo.
81
BSSS, 138/1, pp.
xiv-xvi
,
xxii-xxiii
,
xxxvi-xxxix
.
82
Significativo il giuramento al rispetto degli statuti «sicut iacent», per la preoccupazione
dell’ambiente comunale che attraverso l’interpretazione i giuristi (ed in specie i giudici) ne elu-
dessero l’applicazione (
m. sbriccoli
,
L’interpretazione dello statuto
, Milano 1969, pp. 401-22;
m. a. benedetto
,
Statuti [diritto intermedio]
, in
Novissimo Digesto Italiano
, XVIII, Torino 1971,
pp. 392-93).


















