
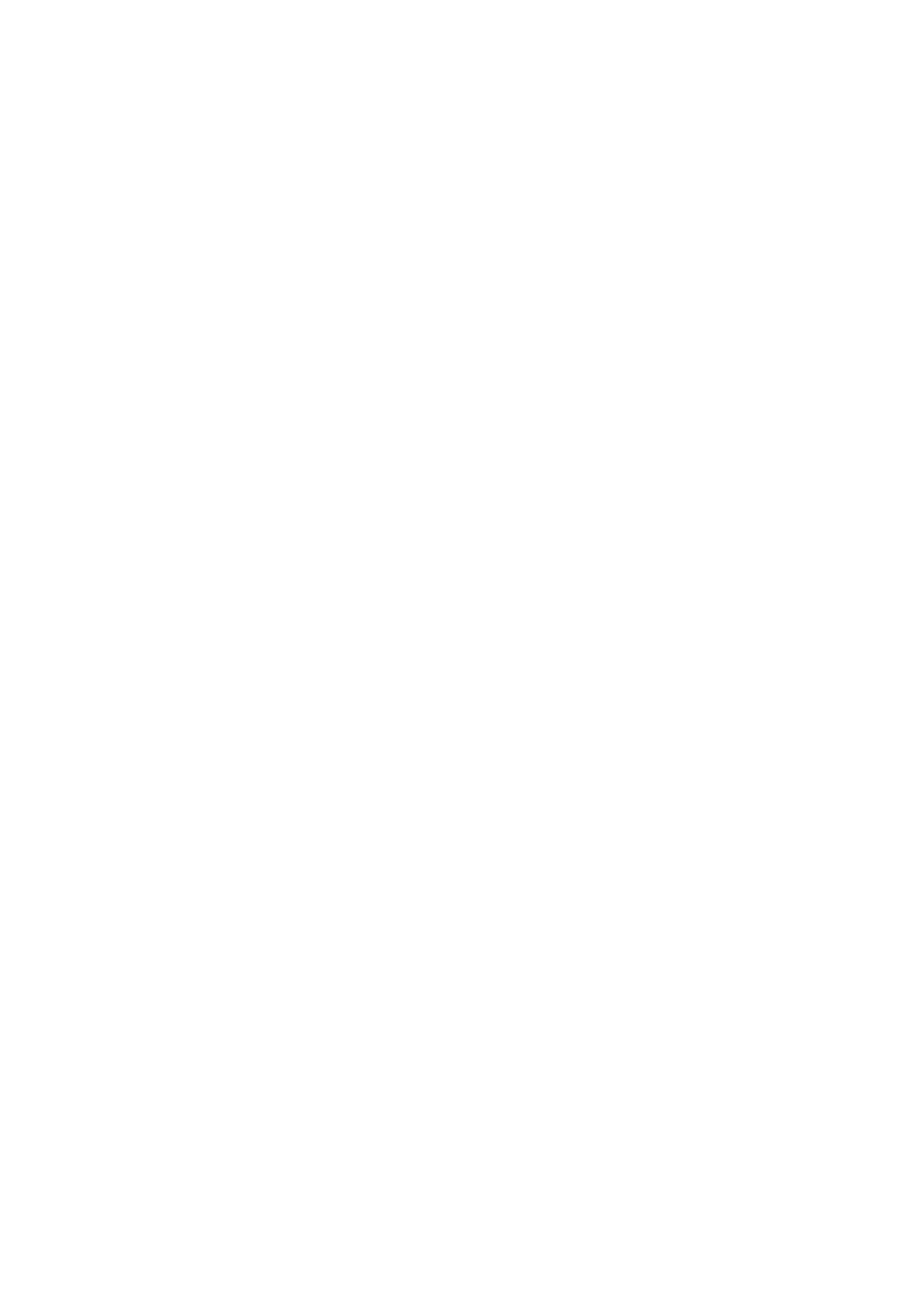
contrano ancora iniziative in questa direzione, come il tentativo di ac-
cordarsi con gli abitanti di Chieri, nel 1328, per assicurare di comune
accordo la custodia della strada fra le due città, resa impraticabile dalla
guerra
32
; ma in seguito gli interventi di questa natura si diradano fino a
cessare. Il comune continua bensì ad essere responsabile della rete via-
ria all’interno del suo territorio, e in quest’ambito s’incontrano inizia-
tive anche importanti, come la costruzione di una strada dalla città
fino al nuovo ponte sulla Dora, deliberata nel 1352, con conseguente
esproprio dei terreni necessari e avvio dei lavori a spese del comune
33
;
per non parlare degli innumerevoli interventi di riattamento o ripara-
zione delle strade vicinali, deliberati dalla credenza e addossati, di soli-
to, ai proprietari interessati; ma al di fuori di quest’ambito ristretto il
comune aveva perduto qualsiasi capacità d’azione. La sicurezza delle
strade di grande comunicazione, ormai, dipendeva dal principe d’Acaia,
né alle comunità assoggettate si richiedeva altro, se non di assicurarne
la transitabilità nell’area limitata di loro competenza.
Senonché il principe d’Acaia era così spesso in guerra col marchese
di Saluzzo, col marchese di Monferrato, addirittura con suo cugino il
conte di Savoia, e costoro tenevano fortezze e guarnigioni, fedeltà di ru-
stici e di signori rurali a così poca distanza dalle mura di Torino, che la
sicurezza delle strade era di fatto assai frequentemente minacciata. Uo-
mini d’arme intenti a condurre la guerra così come si faceva allora, bru-
ciando case, mulini e ponti, imprigionando uomini e razziando bestiame;
nobili della campagna, che l’abitudine a quel genere di guerra rendeva
fin troppo inclini a proseguirla per il proprio vantaggio privato anche in
tempo di pace; e anche, s’intende, briganti di strada, disposti a rischia-
re la forca per spogliare mercanti e pellegrini, minacciavano chiunque si
avventurasse oltre le porte della città senza una buona scorta.
La scarsa o nulla capacità d’intervento delle autorità torinesi, e non
solo, s’intende, del consiglio comunale, ma anche del vicario e del giudi-
ce, al di fuori del territorio cittadino, rendeva assai problematica la dife-
sa dei cittadini e dei loro possedimenti contro questo genere di minacce.
Nel 1377 uno dei più ricchi beccai torinesi, detto il Rana, si rivolse alla
giustizia contro i signori di Settimo, che gli avevano sequestrato un greg-
ge di oltre cento montoni, bastonando per soprammercato i suoi pastori.
Il vicario di Torino mandò una citazione a quei nobili, che non erano,
però, sudditi sabaudi; essi risposero tranquillamente di aver trovato le be-
stie sul territorio di San Mauro, che apparteneva al marchese di Mon-
La classe dirigente e i problemi di una città in difficoltà
279
32
ASCT,
Ordinati
, 3, f. 137
r
.
33
ASCT,
Ordinati
, 13, f. 5
r
.


















