
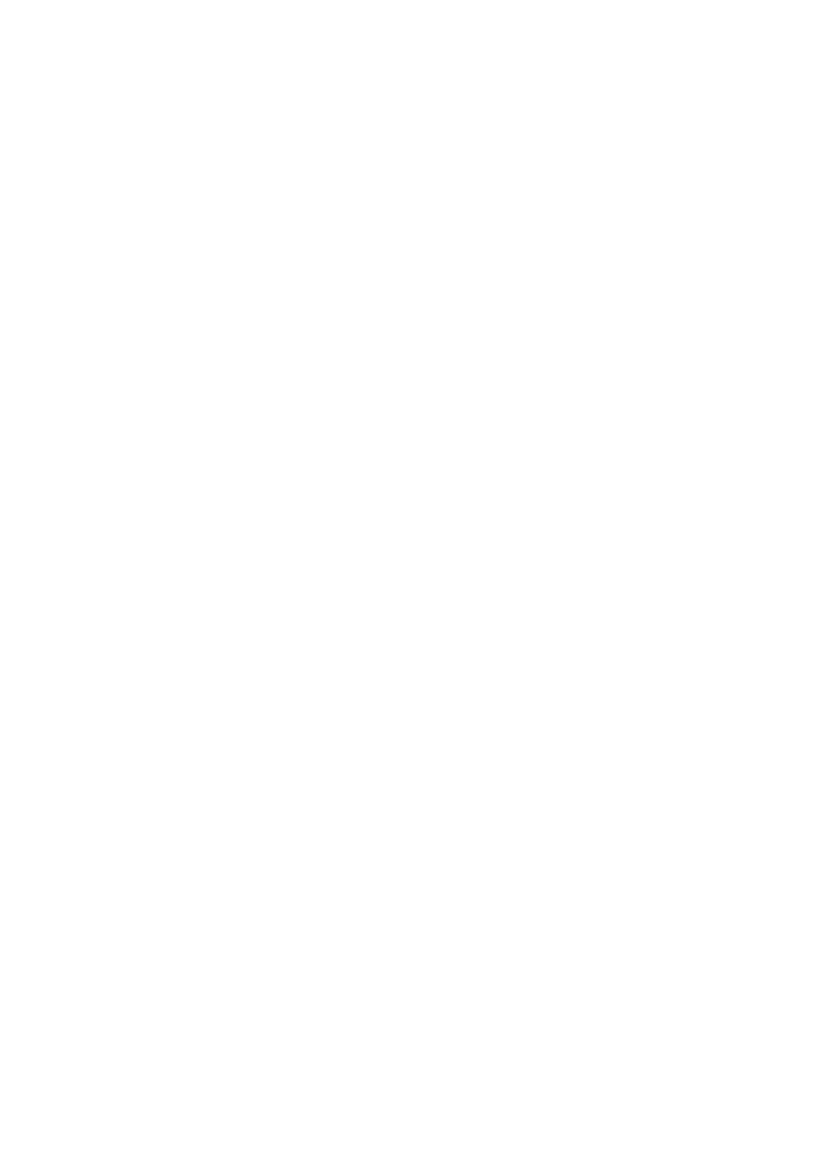
il buono stato delle fortificazioni. Per lo stesso motivo non si potevano
recidere i cespugli spinosi e fare legna nei fossati; addirittura la pena di
morte era comminata a chi avesse fortificato per scopi privati una por-
ta o una torre delle mura.
Per quanto riguarda le proprietà private alcune disposizioni tratta-
vano delle demarcazioni di confine. Le recinzioni erano obbligatorie, in
siepe viva o in muratura o in assi, per evitare liti quando le proprietà
erano contigue e intercomunicanti, si trattasse di edifici o di cortili.
L’erezione di nuovi muri o l’impianto di siepi lungo le vie pubbliche sia
in città sia nei borghi extraurbani richiedeva l’approvazione del massa-
ro, che doveva garantire la salvaguardia del suolo pubblico, coadiuvato
da alcuni vicini.
Il rapporto di vicinato trovava negli statuti un riconoscimento uffi-
ciale; ad esso erano demandate funzioni precise oltre a quella di media-
zione nel caso del controllo edilizio. I vicini infatti erano chiamati a col-
laborare con la giustizia, dando l’allarme e inseguendo i malfattori o no-
tificando la condanna a un debitore; avevano inoltre in prima persona
poteri di controllo sociale in quanto, su richiesta della vicinia o di dieci
persone di essa, il vicario e il giudice erano tenuti a espellerne le prosti-
tute e chi teneva una condotta pubblicamente impudica.
Le norme statutarie lasciano intravedere alcuni aspetti del modo in
cui era vissuta la città dai suoi abitanti. Lo spazio comune era inteso co-
me luogo di comunicazione sociale: la voce dei banditori divulgava le
informazioni in piazza e agli angoli delle vie, la campana del comune
chiamava a raccolta i credendari. I provvedimenti giudiziari in alcuni
casi prevedevano una pena pubblica nell’esposizione alla berlina o nel-
la fustigazione lungo le vie cittadine per chi non fosse in grado di pa-
gare le multe, ad esempio nel caso di persone che avessero estirpato
piante verdi, distrutto e asportato le clausure, raccolto uva non in tem-
po di vendemmia, rubato grano o farina, giocato ai dadi. Sulla piazza
del mercato il giudice doveva bruciare pubblicamente i panni contraf-
fatti in cui alla lana fossero state aggiunte altre fibre, come peli di bo-
vini, capre, asini.
Altre disposizioni miravano a guidare il comportamento collettivo:
si poteva oziare davanti alla propria casa senza illuminazione dopo l’ul-
tima campana serale, ma non ci si poteva trattenere a bere nelle taverne.
Poiché il senso comunitario si esprimeva anche nella devozione reli-
giosa, il comune si faceva carico dei debiti delle confraternite e dei ce-
ri portati in processione per la festa di San Giovanni. Una rubrica isti-
tuiva una visita solenne al monastero suburbano dei Santi Solutore, Av-
ventore e Ottavio, alla quale partecipavano vicario, giudice, consiglieri,
La città e il suo territorio
19


















