
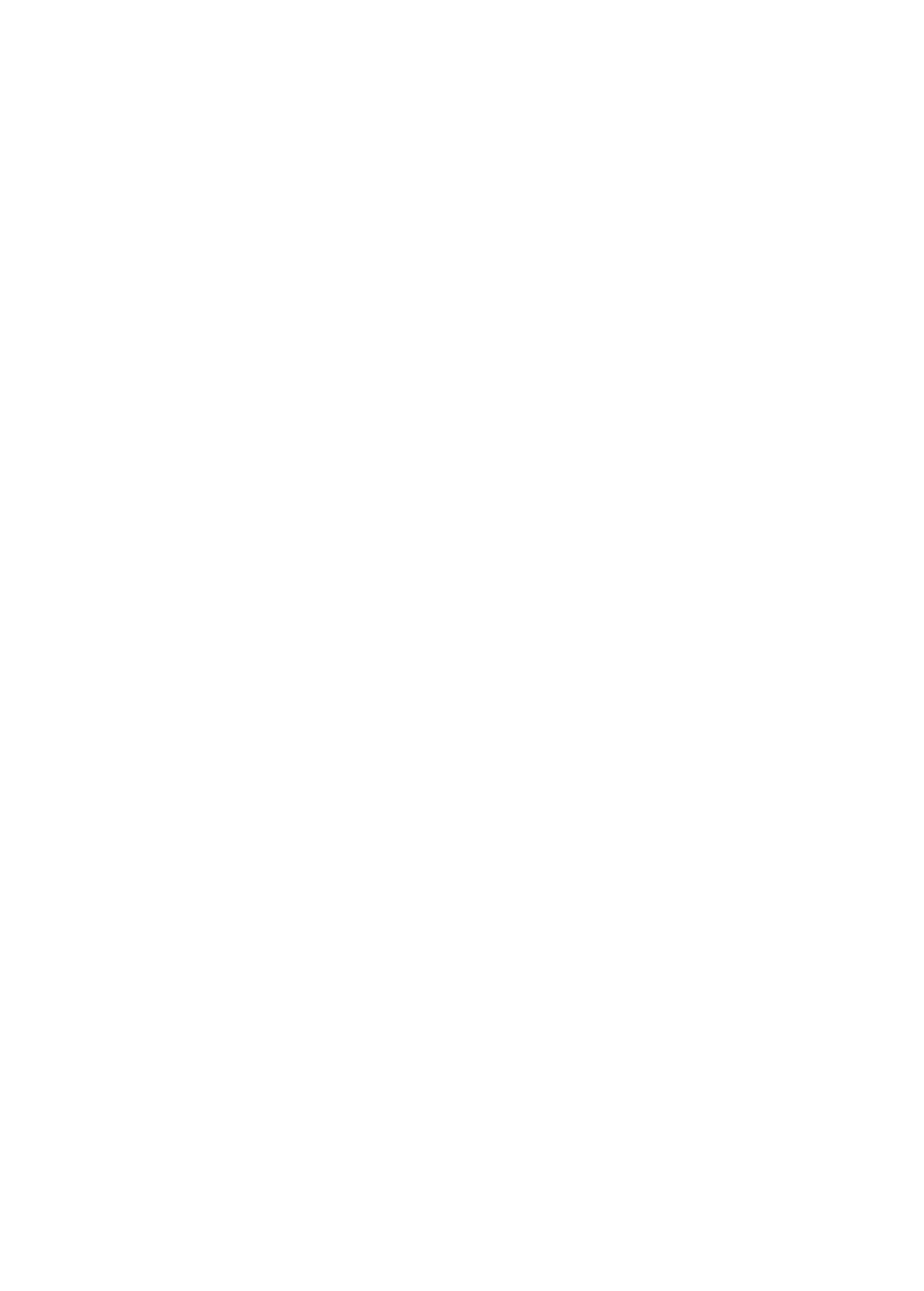
non serve qui per indicare un recinto murato nel quale possono coabi-
tare molte persone, bensì un edificio turrito omogeneo, a modo di pa-
lazzo fortificato; la sede del potere installata sulle mura urbane appare
inoltre come rara anticipazione di una pratica che, nell’Italia centro-set-
tentrionale, si generalizza soltanto molto più tardi: la presenza di castelli
ai margini di una città assume sempre connotazioni ambigue, ma è so-
prattutto nell’età delle signorie che l’intento di dominare prevale deci-
samente su quello di proteggere, per quanto i nuovi padroni delle città
abbiano talora l’accortezza di presentare come necessità di difesa col-
lettiva ciò che serve alla loro volontà di sopraffazione.
Più tardi, in un’epoca in cui le libertà cittadine in Italia erano ormai
solo più un ricordo, Leon Battista Alberti non teme di rendere esplici-
ta una tale funzione: le difese di una città – egli consiglia – è bene sia-
no organizzate in ragione del potere cui essa è soggetta: se colui che go-
verna «è spinto dal desiderio di beneficiare i cittadini non meno che dal
suo tornaconto personale», le fortificazioni saranno semplicemente ri-
volte contro i nemici esterni; se si tratta invece di personaggio cui gli
abitanti della città «debbono obbedire anche contro voglia», costui do-
vrà fortificarsi considerando «i concittadini suoi nemici allo stesso mo-
do degli stranieri»
35
.
Ecco quindi i castelli eretti in città dai signori dislocarsi di norma in
posizione periferica, a cavallo delle mura, nella direzione più opportu-
na per chi se ne deve servire, in modo da controllare la cerchia, resiste-
re contro una popolazione potenzialmente ostile e riservarsi, all’occor-
renza, una comoda via di fuga. Una funzione simile poteva appunto aver
esercitato a Torino, già fra
x
e
xi
secolo, la residenza marchionale di
Porta Segusina, che sorgeva infatti a dominio dell’uscita verso Susa, l’al-
tro polo importante del potere arduinico
36
.
Il dominio sulla città coincideva dunque tradizionalmente a Torino
con il controllo esercitato sulle mura e sulle porte, e anche dopo l’età ar-
duinica Federico I aveva riconosciuto al vescovo Carlo i diritti su «do-
mos publicas murumque ipsius civitatis», cioè sulla cerchia murata ve-
ra e propria e sui complessi fortificati che su di essa si trovavano, defi-
niti «case pubbliche» in quanto edifici residenziali. Nella seconda metà
del
xiii
secolo, quando la città viene più volte concessa e riconfermata
ai Savoia, anche quando ci si limita a parlare di «civitas Taurini» si in-
tende pertanto comprendere la cerchia murata con le sue porte, pur sen-
La città e il suo territorio
23
35
l. b. alberti
,
L’architettura (De re aedificatoria)
, a cura di G. Orlandi, Milano 1966, p. 33.
36
settia
,
Proteggere e dominare
cit., p. 20;
id
.,
Fisionomia urbanistica
cit
.
, p. 794 (testo corri-
spondente alla nota 26).


















