
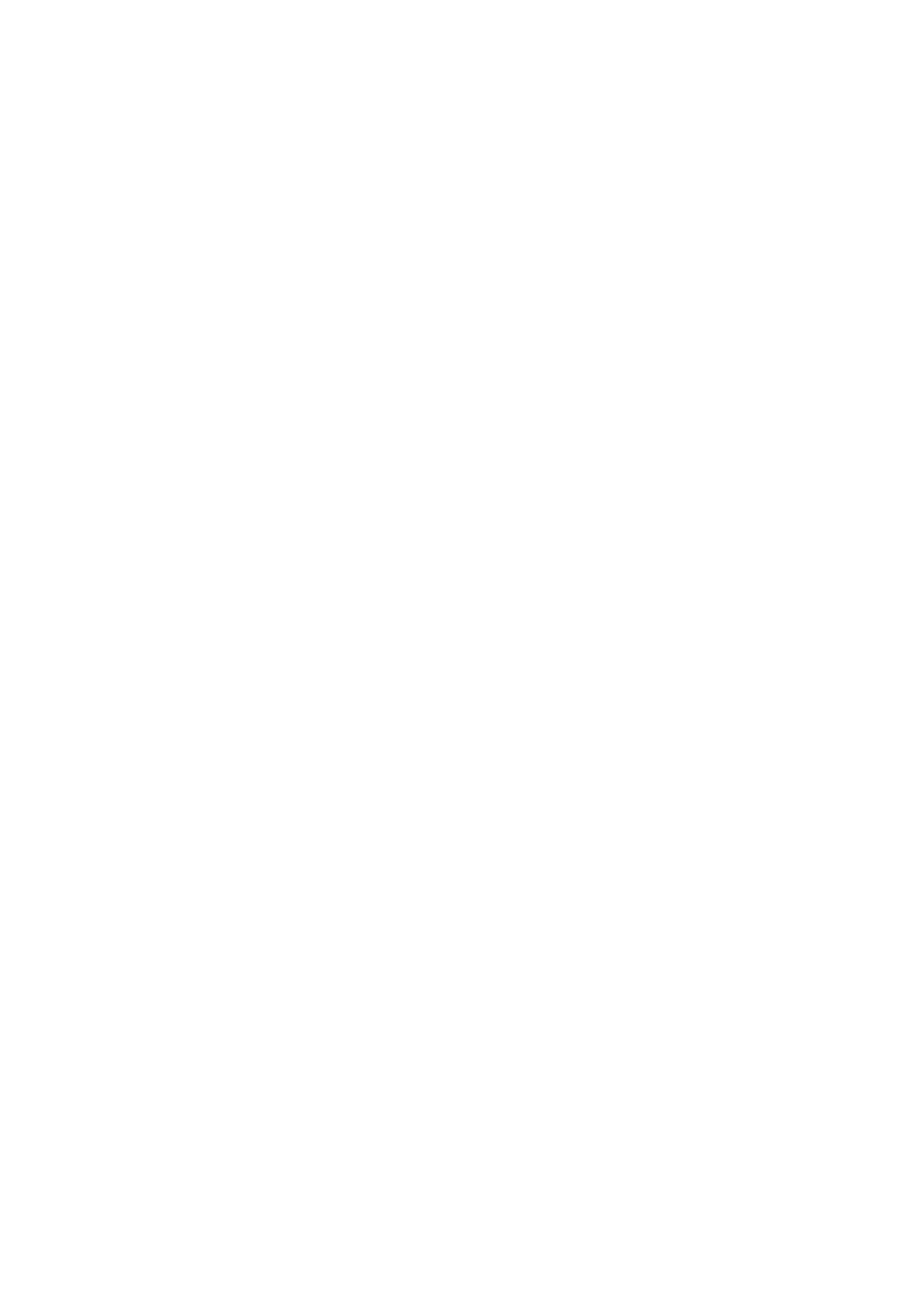
380
Parte seconda La preminenza sulle comunità del Piemonte (1418-1536)
se diritto al primo per anzianità, veniva il territorio che al tempo degli
Acaia era rimasto soggetto al ramo primogenito della dinastia, la «terra
vetus cismontana». Sebbene alcune fra le comunità della «terra vetus»
pagassero nominalmente sussidi assai elevati – è il caso in primo luogo
di Avigliana, e in minor misura di Susa, Rivoli e Lanzo – le loro quote
erano in realtà comprensive di tutto il territorio dipendente dai loro ca-
stellani; in quanto centri urbani, esse non erano in grado di far seria-
mente concorrenza alle città del principato.
Una terza categoria era costituita da quelle comunità, a sud del Po,
che si erano aggregate in tempi più recenti ai domini sabaudi: le più im-
portanti di queste «lance spezzate», come Chieri, Mondovì e Cuneo,
pur riconoscendo la supremazia del duca conservavano un proprio ter-
ritorio amministrato autonomamente, assai più ampio di quello, ridot-
to di solito a una o due comunità subalterne, su cui potevano contare le
città di più antica sottomissione – nonché un grado di autonomia, so-
prattutto sul piano fiscale, sconosciuto a queste ultime. Analoghe con-
siderazioni valgono per le «terre ultra Duriam», per quelle comunità
cioè la cui sottomissione era stata completata soltanto con l’acquisto di
Vercelli nel 1427: anche in questo caso le città più importanti, come
Ivrea, Biella, Santhià e la stessa Vercelli, conservavano un territorio di
dimensioni sufficienti a farne dei contribuenti di primissimo piano, ma
la sola Vercelli, fra loro, era realmente in grado di misurarsi con le altre
città piemontesi quanto a popolazione e ricchezza.
Questa quadripartizione dei domini cismontani, dettata a un tempo
dalla geografia e dai tempi e modi dell’affermazione sabauda, non rap-
presentava soltanto una suddivisione amministrativa utilizzata dal po-
tere centrale, ma era fortemente presente nella coscienza dei sudditi e
ne condizionava l’operare politico. Così, quando, nel giugno 1450, le
comunità piemontesi elessero i loro rappresentanti per trattare la pere-
quazione del sussidio, la rappresentanza risultò così ripartita: quattro
deputati, rispettivamente di Torino, Pinerolo, Savigliano e Moncalieri,
«pro dictis .IIII. terris», a riconoscimento dello status privilegiato del-
le quattro città all’interno dei domini già degli Acaia, e altri due, ri-
spettivamente di Fossano e Vigone, «pro ceteris aliis terris principatus»;
tre, rispettivamente di Susa, Rivoli e Avigliana, «pro ceteris de terra ve-
teri cismontana»; altri tre per le terre oltre la Dora, qui dette addirit-
tura «terre inferiores Lombardie patrie ducalis», a conferma del carat-
tere periferico che veniva loro riconosciuto rispetto all’insieme della «pa-
tria Pedemontana». Vennero poi eletti alcuni deputati per le comunità
che non rientravano in nessuna di queste ripartizioni, «pro terris et vil-
lis spezatis sic appellatis», e infine si stabilì di accettare un deputato cia-


















