
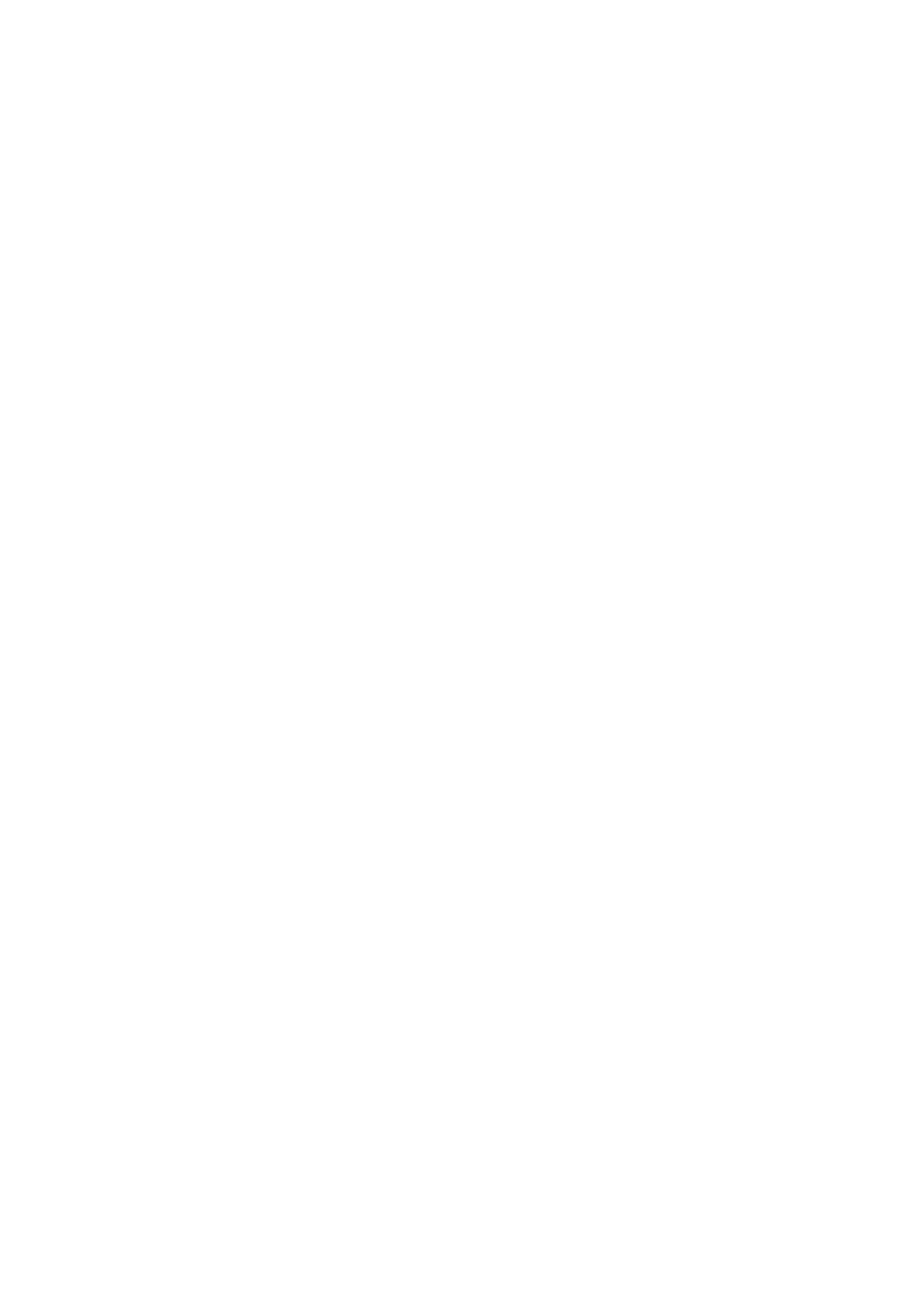
402
Parte seconda La preminenza sulle comunità del Piemonte (1418-1536)
giorno più popolosa e più trafficata; la peste che da sola poteva annul-
lare di colpo, anche se momentaneamente, la stessa centralità politica
della città, come nell’estate del 1479, quando il Consiglio cismontano
riparava a Rivoli e là convocava i Tre Stati «propter pestem regnan-
tem in Thaurino», o nel 1483, quando il Consiglio per sfuggire all’epi-
demia abbandonava la città per buona parte dell’anno, o, ancora, nel
1484, quando il duca stesso si rifugiava a Moncalieri «causante peste
qua undique ipsa patria et nos obsessi sumus». Non c’è quindi da sor-
prendersi se nel febbraio 1485 la comunità torinese era costretta a chie-
dere una dilazione nel pagamento del sussidio appena concesso al du-
ca, «causantibus caristiis et pestilenciis que res comunitatis civiumque
et incolarum in particulari et generali absorbuerunt», avvertendo che
da tale dilazione dipendeva la residua prosperità della città: «alias au-
tem pro maiori parte cives et incole et precipue plebei cogentur co-
munitatem ipsam absentare, constante extrema necessitate et pauper-
tate»
24
.
Torino pagava insomma un prezzo per il nuovo ruolo in cui la poli-
tica della dinastia e l’ambizione della sua oligarchia l’avevano proietta-
ta in tempi relativamente brevi; appunto per questo, tuttavia, non bi-
sogna dimenticare che la città era pur sempre, in modo ormai indiscus-
so, il centro politico e amministrativo del Piemonte sabaudo, e che
nessun’altra comunità era in grado di approfittare delle sue difficoltà
per contestarle, come un tempo, il primato. Di questa ormai definitiva
centralità torinese è facile riportare gli esempi, tanto nella quotidianità
del gioco politico e diplomatico quanto sul non meno importante piano
simbolico. Proprio allora si comincia a riscontrare nell’operato dei du-
chi una sollecitudine precedentemente sconosciuta per il decoro della
città, che prefigura anche se in dimensioni assai più modeste le cure de-
dicate dai loro successori cinque e seicenteschi all’assetto urbanistico
della capitale: ne offre un esempio la bolla papale impetrata nel 1464 dal
duca Ludovico, in cui si invitavano gli enti ecclesiastici torinesi a inco-
raggiare l’insediamento sui loro possessi suburbani delle «habitationes
rusticorum et stabula iumentorum» fino allora localizzate entro le mu-
ra, per non guastare il decoro di una città «in qua universale Studium
viget et ipsius ducis Consilium citra montes residet»; o, ancora, le di-
sposizioni prese da Bianca nel 1490 per la pulizia delle strade di Tori-
no, «in qua residentiam facere peroptamus»
25
.
24
tallone
,
Parlamento sabaudo
cit., V, pp. 269, 341, 349;
f. gabotto
,
Lo stato sabaudo da
Amedeo VIII ad Emanuele Filiberto
, Torino-Roma 1893, p. 303.
25
ASCT, Carte Sciolte, n. 3878;
cibrario
,
Storia di Torino
cit., p. 290.


















