
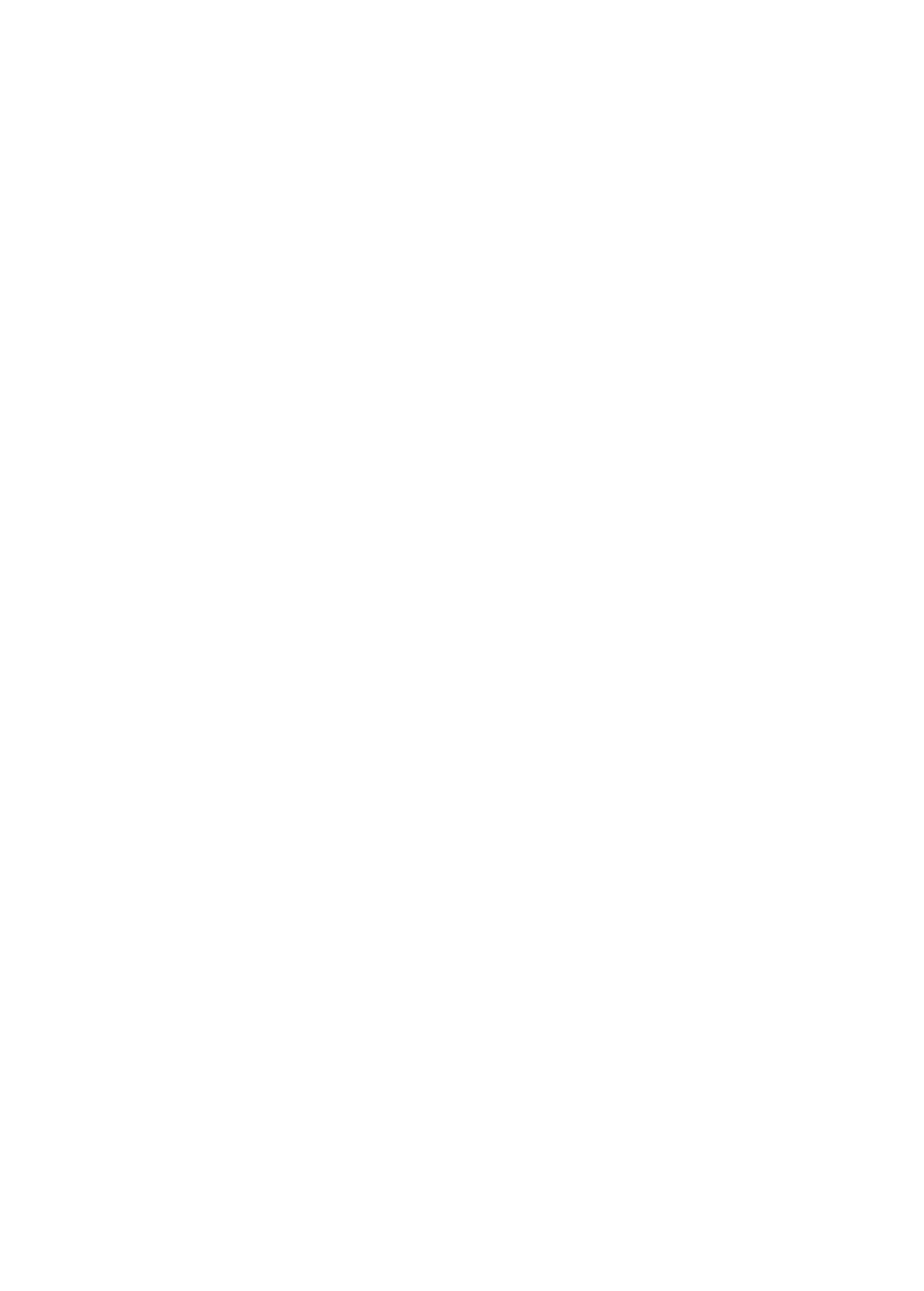
486
Parte seconda La preminenza sulle comunità del Piemonte (1418-1536)
Nuova per quanto riguarda il settore di attività che si intendeva svi-
luppare, tale scelta si inquadrava perfettamente nella politica popola-
zionistica tendente al reclutamento di manodopera specializzata che il
gruppo dirigente torinese aveva autonomamente condotto nel secolo pre-
cedente e ottenne certamente il risultato di radicare il Binago e la mo-
glie in città. L’introduzione della lavorazione della seta a Torino non
era tuttavia argomento di cui il potere centrale, ben cosciente, sin dagli
anni Venti del secolo, della situazione drammatica in cui versava in Pie-
monte il settore tessile, potesse disinteressarsi; a Milano, del resto, era
stata proprio un’iniziativa ducale di chiaro orientamento protezionisti-
co a porre, cinque anni prima, basi relativamente solide per lo sviluppo
dell’arte.
Fu così che, meno di due anni dopo, sull’argomento si verificò spon-
taneamente una convergenza di intenti fra il duca e il consiglio comu-
nale: il 4 novembre 1449 Ludovico di Savoia, nonostante che sollecita-
zioni in tal senso gli fossero giunte da più parti, concesse infatti, che, se
il comune di Torino fosse stato d’accordo, potesse immigrarvi e svol-
gervi per un decennio la propria attività nella confezione di tessuti di
seta mastro Giovanni da Serravalle. In meno di un mese questi fu accol-
to come
habitator
e, come prevedevano gli accordi fra la comunità e il
principe, ottenne una casa idonea allo svolgimento del proprio lavoro
168
.
Paolo Grillo ha chiarito recentemente il contesto politico-economi-
co in cui tale migrazione avvenne. Essa va collocata nella situazione di
grave crisi che colpì la manifattura serica a Milano a partire dal 1447
a causa della guerra contro Venezia, della scomparsa di Filippo Maria
Visconti e della conseguente fine della sua dinastia, che significava fra
l’altro la perdita di un «importantissimo committente». Probabilmen-
168
ASM, Fondo notarile, Giacomo Brenna, cart. 1413, 14 febbraio 1454: patti di apprendi-
stato fra Andrino da Binago fu Antonio, cittadino milanese ma «moram trahens in civitate Turi-
ni ducatus Sabaudie, magister faber» e Girardo fu Girardo della val Vigezzo con il figlio Antonio,
che si impegna a lavorare per dieci anni «de arte fabrorum seu fabricerie […] in dicta civitate Tu-
rini»: Antonio sarà mantenuto gratuitamente e riceverà entro dieci anni 25 fiorini da 32 soldi, da
cui detrarre le spese fatte «in vestimentis et calciamentis»; ASM, Fondo notarile, Giacomo Bren-
na, cart. 1413, 10 maggio 1454: patti quinquennali dello stesso tenore fra Andrino e Leonardo «de
Sqassis» fu Daniele di Milano. Devo le segnalazioni alla cortesia di Paolo Grillo, che ringrazio. An-
drino da Binago risulta residente a Torino ancora agli inizi degli anni Sessanta del Quattrocento
(AST, Camerale, inv. 48, f. 13, mazzo unico, n. 4, dal 3 luglio 1462 all’11 dicembre 1464, f. 5
r
),
dove possiede una casa «de qua facit stallam», nella parrocchia di San Simone (ASCT, Marm.
1464, f. 36
r
). Nel 1478, dopo la sua morte, vi è menzionato il figlio Francesco
aurifaber
, che pos-
siede tre case, di cui due con botteghe sulla piazza del mercato, e 2
g.tedi alteno (ASCT, Dor.
1478, f. 53
v
). Questi è ancora a Torino trent’anni dopo (Dor. 1488, f. 32
r
, stessi beni del 1478;
Marm. 1510, f. 88
r
, solo casa). Ringrazio Stefano Benedetto per le due ultime segnalazioni. G. da
Serravalle:
comba,
Dal velluto
cit., p. 22.


















