
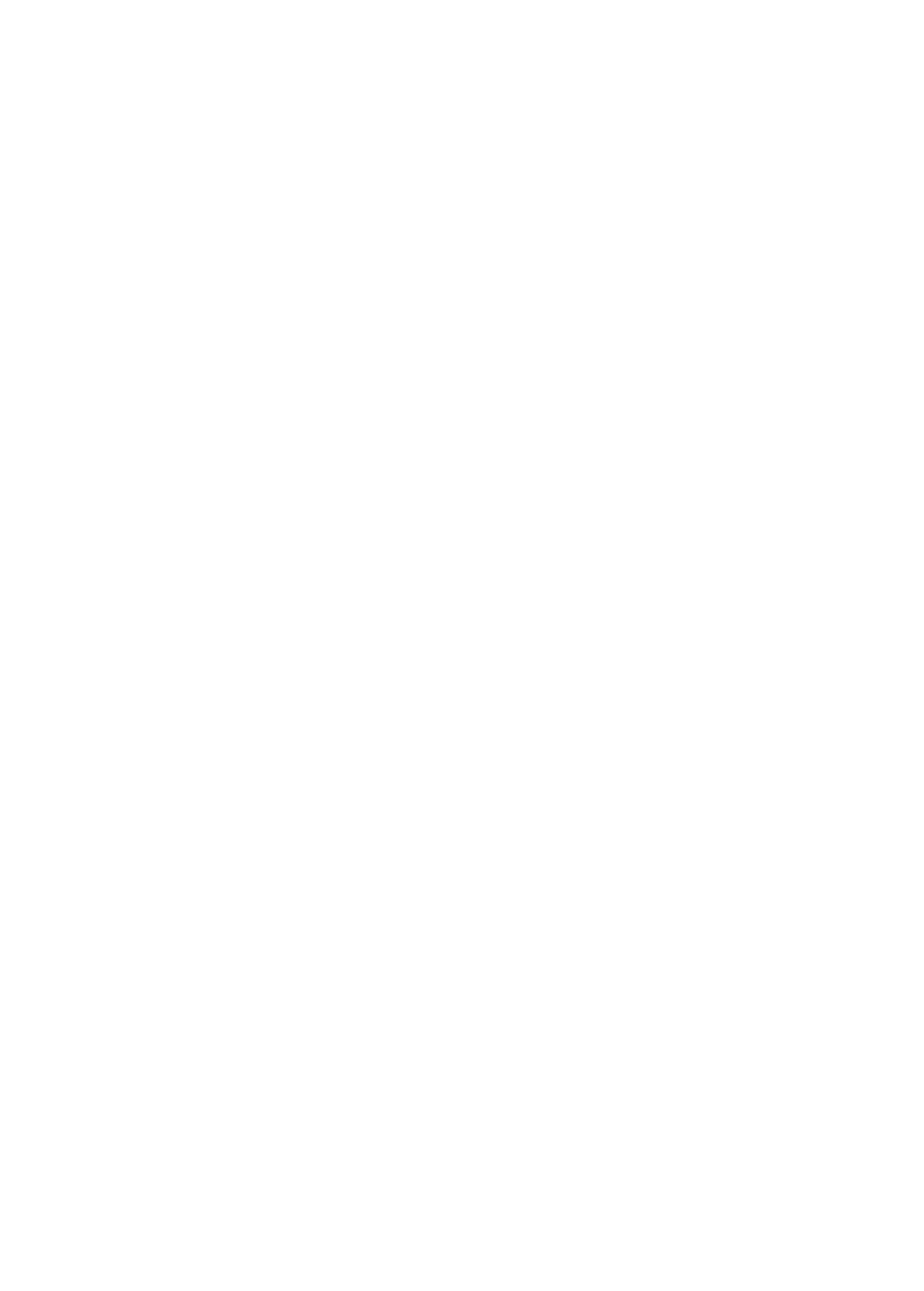
602
Parte seconda La preminenza sulle comunità del Piemonte (1418-1536)
le, che riversava ogni anno nelle casse dello Studio ben 2000 fiorini: for-
ti pressioni da parte di gruppi di potere di ambiente mercantile, che con-
sideravano quel tributo un intralcio per le attività commerciali in terri-
torio piemontese, indussero infatti il duca ad accettare la proposta di so-
stituirlo con un versamento
una tantum
della somma ragguardevole di
50 000 fiorini da parte dei tre Stati (clero, nobili, popolo)
35
.
L’ organ i zzaz i one deg l i s tud i .
Il problema del debito pubblico, che non sempre consentiva una re-
golare copertura degli stanziamenti programmati, rappresentava natu-
ralmente un forte elemento di debolezza dell’istituzione.
Immancabili opposizioni di gruppi di pressione cittadini potevano
inoltre condizionare in modo più o meno esplicito le scelte delle magi-
strature comunali riguardo alle questioni dello Studio, costellando così
di una serie di ostacoli il cammino della realizzazione dei progetti sa-
baudi. Tuttavia intorno alla metà del
xv
secolo l’istituzione universita-
ria si presentava con una struttura ormai ben consolidata. La sua fisio-
nomia appariva delineata in modo abbastanza chiaro e anche il suo or-
dinamento risultava sufficientemente definito: vi erano istituiti i corsi
di arti e medicina, diritto civile e canonico, mentre l’insegnamento di
teologia era sempre gestito dai frati Minori e dai Predicatori, limitan-
dosi l’università a rilasciare ufficialmente i gradi accademici. L’ordina-
mento universitario del tempo prevedeva – come è noto – che il
curri-
culum
degli studi si concludesse con il conseguimento di titoli legalmente
riconosciuti. Secondo le disposizioni papali e imperiali, anche a Torino
la licenza di insegnare e il dottorato venivano concessi dal vescovo, nel-
la sua veste di cancelliere dello Studio, oppure da un suo rappresentan-
te durante una cerimonia solenne che si svolgeva nella cattedrale appo-
sitamente allestita per l’occasione a spese della comunità.
Per il secondo Quattrocento e oltre, le testimonianze documentarie
conservate negli archivi torinesi (archivio di Stato, archivio storico del-
la città, archivio dell’arcivescovado) attestano una regolare attività del-
lo Studio: sono documentati – fra l’altro – pagamenti più o meno con-
tinui non solo al personale docente e non docente da parte del tesorie-
re dell’università, ma anche al campanaro che suonava l’ora delle lezioni
e di altri appuntamenti accademici, oltre a frequenti e impegnativi in-
terventi per attrezzature e opere edilizie a carico della città. D’altra par-
35
Il documento è edito in
vallauri
,
Storia delle Università degli Studi del Piemonte
cit.,
pp. 308-13, doc.
xxii
.


















