
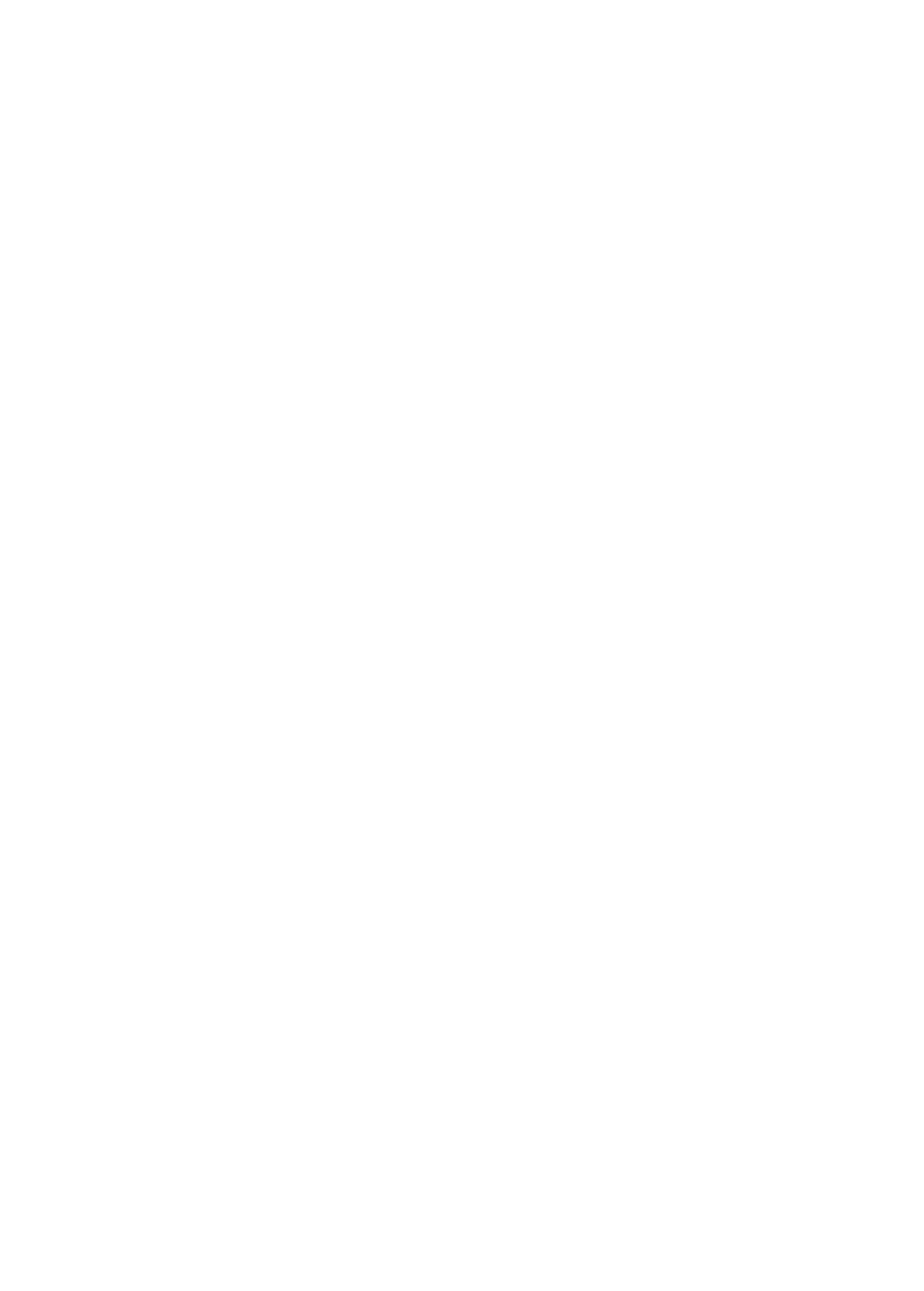
re i titoli a Torino fossero in generale più contenute che altrove; non va
comunque dimenticato che alcune tra le università più importanti nel
frattempo avevano istituito il numero chiuso delle lauree in teologia
42
.
Gli stessi professori, dei quali resta peraltro da studiare in modo ca-
pillare l’area di reclutamento, erano forse prevalentemente di prove-
nienza locale o al più regionale. Quantunque nelle disposizioni ducali del
1436 si dichiarasse l’intento di voler garantire la presenza di
doctores fa-
mosi
, i docenti dello Studio torinese non sembrano in genere di alto pro-
filo culturale, tanto che solo di rado riuscivano ad emergere nel panora-
ma intellettuale del tempo. Tuttavia alcuni di loro ottennero un certo
successo professionale e qualche riscontro scientifico, anche al di fuori
dell’ambito sabaudo-piemontese: basterà ricordare i giuristi Ambrogio
Vignate e Pietro Cara o i medici Pantaleone da Confienza e Pietro
de
Monte
da Bairo, autori di opere che ebbero una discreta circolazione. Del
resto, se in linea di principio l’assegnazione delle cattedre avrebbe do-
vuto dipendere in primo luogo dalla buona reputazione dei docenti, ta-
lora le nomine – di fatto controllate dal duca – erano oggetto di mano-
vre di varia natura: la scelta era spesso condizionata da ragioni di carat-
tere extrascientifico, in primo luogo dalle relazioni con l’ambiente di
corte. Nondimeno, a partire dal primo Cinquecento, incominciano ad
apparire chiari indizi di una politica di reclutamento del corpo docente
più attenta e meno provinciale, con missioni che potevano portare rap-
presentanti dello Studio in varie parti d’Italia per stabilire contatti con
qualche eminente studioso cui affidare una cattedra universitaria
43
.
Inoltre l’insegnamento torinese non si caratterizzava in alcun modo
né per l’impostazione didattica né per l’impegno scientifico: infatti l’or-
dinamento del nostro Studio, sin dalla sua istituzione, si era ispirato agli
statuti di quello pavese, che a loro volta – come i regolamenti di gran par-
te delle università italiane – erano impostati sul cosiddetto modello bo-
lognese, mentre la facoltà di teologia si ispirava chiaramente al modello
parigino. Lo stesso Ludovico d’Acaia nella sua prima «riforma» aveva
evocato l’esempio di altri
Studia
, non solo italiani. Neppure in seguito la
sede subalpina sarebbe riuscita ad imporsi nel panorama universitario,
non tanto per le difficoltà di ordine pratico legate alla carenza di strut-
ture (problema del resto comune da sempre alla maggior parte dei centri
La vita e le istituzioni culturali
605
42
bellone
,
Il primo secolo di vita
cit., p. 183.
43
Numerose notizie sull’attività dello Studio si trovano negli
Ordinati
, in cui sono raccolte le
delibere del consiglio di credenza. La serie, abbastanza completa, è conservata presso l’ASCT. Una
testimonianza relativa al finanziamento di un viaggio finalizzato a reperire un buon docente di di-
ritto si trova in ASCT,
Ordinati
, 97, f. 12
v
(verbale del 15 giugno 1518).


















