
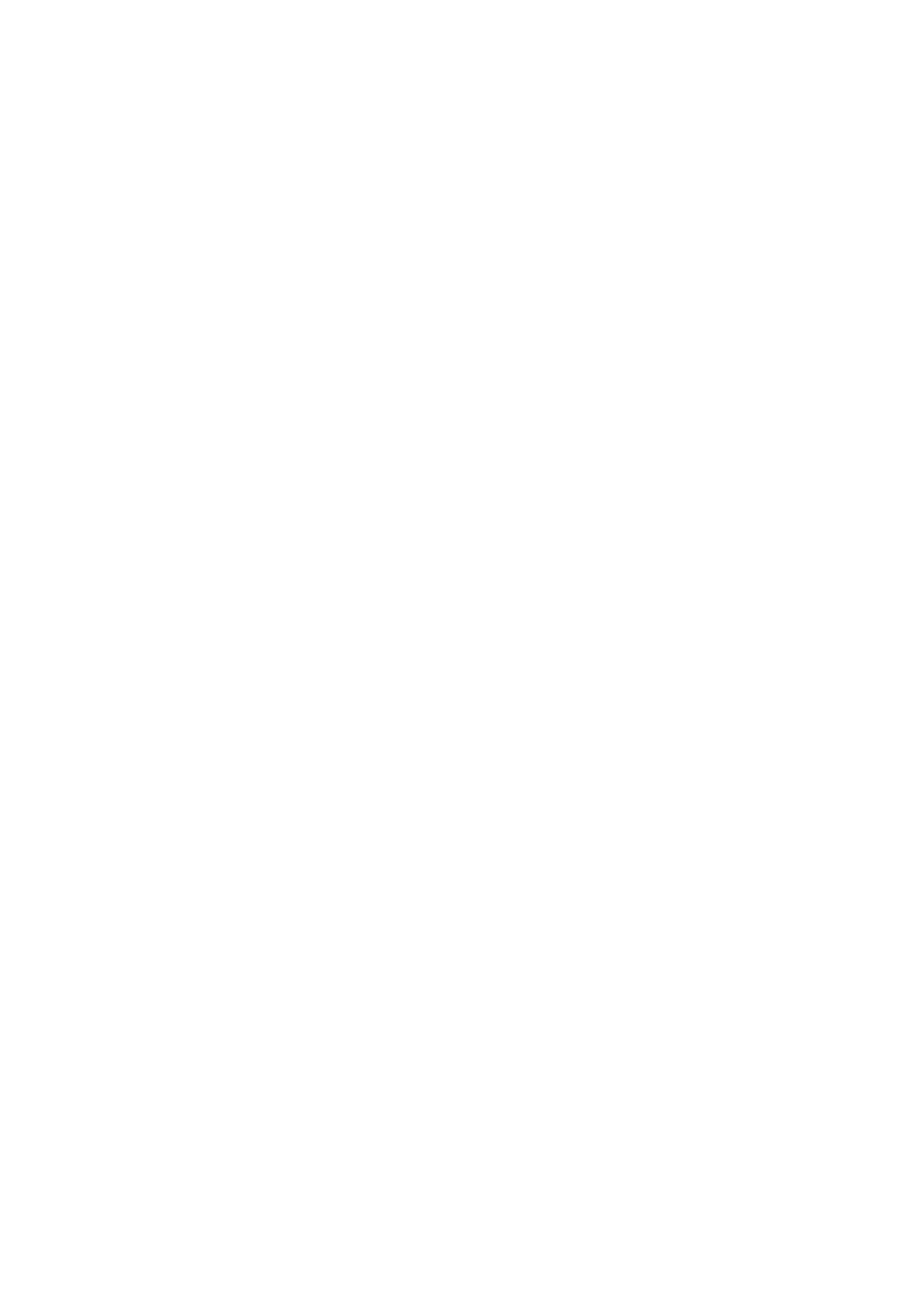
te se nel primo periodo le lezioni si tenevano in locali diversi presi in af-
fitto, fin dagli anni Quaranta si era ormai raggiunta una soluzione che
garantiva un miglior funzionamento dei corsi: le attività dello Studio fu-
rono concentrate in una sede unica, all’interno di un edifico apposita-
mente acquisito a spese dell’amministrazione comunale; lo stabile, che
ospitava a livello strada alcune botteghe, era ubicato nel centro della
città, non lontano dal palazzo del comune, precisamente nel quartiere
di Porta Nuova, che – secondo la ripartizione topografica tardomedie-
vale – corrispondeva alla zona urbana sud-occidentale.
Intorno alla metà dello stesso secolo si erano andati organizzando an-
che i collegi dei dottori, cui aderivano i laureati, di solito residenti in
città, che – pur senza svolgere necessariamente la funzione docente –
avevano comunque un legame ufficiale con lo Studio e precise attribu-
zioni accademiche, in quanto partecipavano di diritto alle commissioni
per l’assegnazione della licenza e del dottorato. Il radicamento dell’isti-
tuzione universitaria nella società urbana si esprimeva dunque, anche a
Torino come in altre situazioni, attraverso il sistema di reclutamento nei
collegi dottorali, che tendevano a chiudersi ai forestieri in difesa degli
interessi delle famiglie cittadine
36
. Il collegio dei teologi fu il primo ad
essere ufficialmente riconosciuto, forse già nel 1436, ottenendo l’ap-
provazione di una propria normativa statutaria
37
; seguì nel 1448 quello
di arti e medicina e infine nel 1452 fu la volta dei giuristi. Gli statuti
dei collegi torinesi costituiscono di fatto i regolamenti dell’insegnamento
universitario, validi almeno sino all’età di Emanuele Filiberto; essi in-
fatti regolamentano l’organizzazione degli studi e soprattutto l’attività
didattica (durata dei corsi,
curricula
, numero e incarichi dei docenti ai
vari livelli, testi), stabilendo anche le modalità per il conferimento dei
gradi accademici
38
.
Un altro elemento che dimostra la vitalità dello Studio a partire dai
decenni centrali del
xv
secolo è una certa concentrazione di «attestati
La vita e le istituzioni culturali
603
36
Cfr.
c. frova
,
Le istituzioni scolastiche
, in
s. gensini
(a cura di),
Le Italie del tardo medioe-
vo
, Pisa 1990, specialmente pp. 282-83.
37
Sull’aggregazione degli
Studia
conventuali alle università come facoltà teologiche, a partire
dal
xiv
secolo, cfr.
g. petti balbi
,
Le università medievali
, in
m. firpo
e
n. tranfaglia
(a cura di),
La storia. I grandi problemi dal Medioevo all’Età Contemporanea
, I.
Il Medioevo
,
i
.
I quadri generali
,
Torino 1988, pp. 591, 597; cfr. anche
j. verger
,
«Studia» et universités
, in
Le scuole degli ordini
mendicanti
cit., pp. 173-203.
38
Per una più ampia informazione sui collegi dei dottori nel Piemonte tardomedievale cfr.
i.
naso
,
Il collegio dei medici di Novara negli ultimi anni del Quattrocento. Contributo allo studio dei
gruppi professionali al termine del medioevo
, in
Studi di storia medioevale e diplomatica
, Milano 1979,
pp. 265-361;
ead
.,
Medici e strutture sanitarie nella società tardo-medievale. Il Piemonte dei secoli
xiv
e
xv
, Milano 1982, in particolare pp. 87-88 e la bibliografia citata alle note corrispondenti.


















