
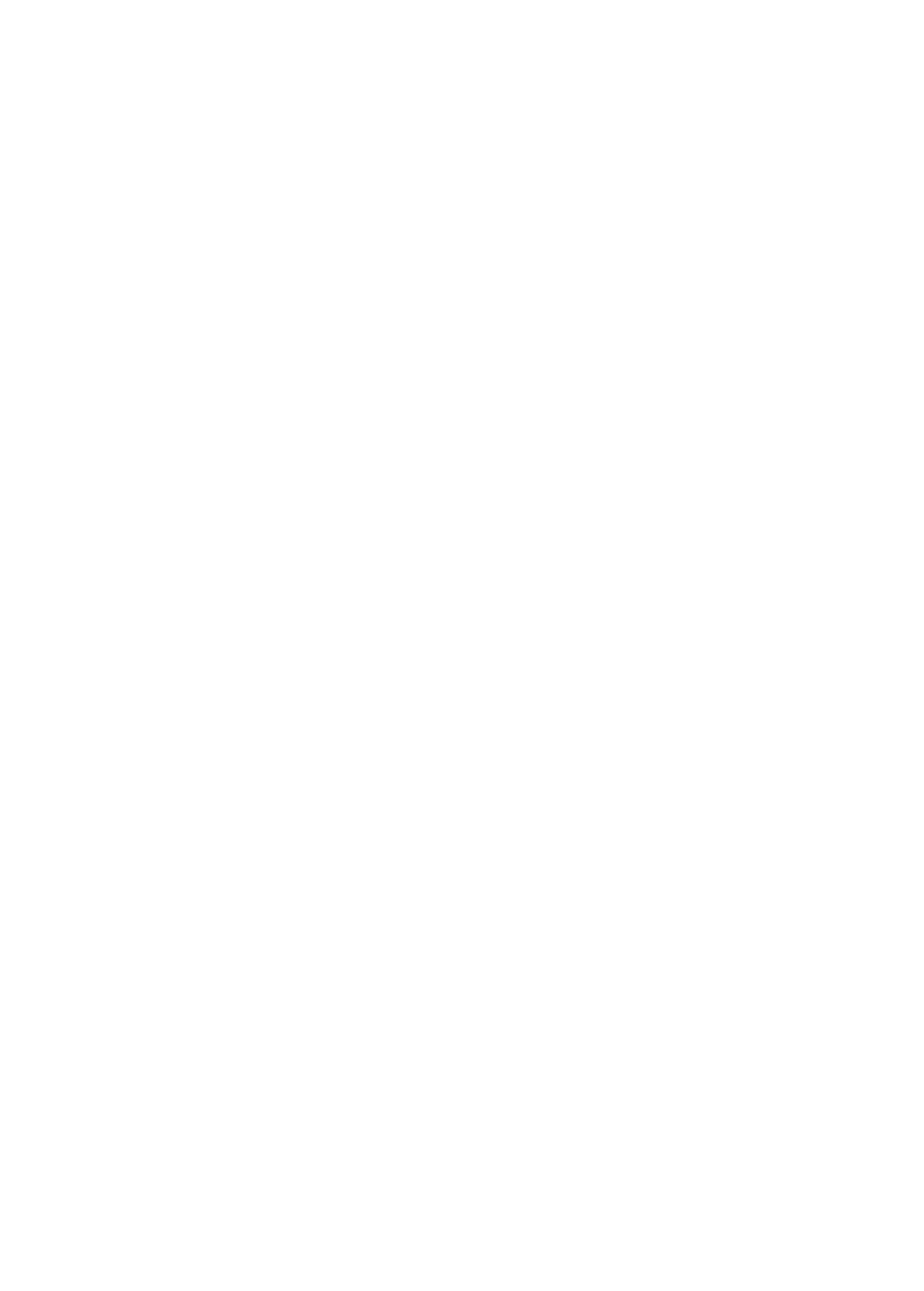
630
Parte seconda La preminenza sulle comunità del Piemonte (1418-1536)
presenza di studenti-giuristi di provenienza pedemontana), a fornire l’im-
pianto teorico e la spinta politica, non certo in termini di banale giu-
stificazione e «legittimazione»
ex post
, alle nascenti istanze centraliz-
zatrici e per così dire «assolutistiche» (in parallelo, o di riflesso, a quan-
to avveniva contemporaneamente nella monarchia di Francia, dove il
fenomeno del «nazionalismo giuridico» accompagna e sorregge la crea-
zione dello Stato)
131
.
Si dovrà infine sollevare lo sguardo a quanto accade nel panorama
universitario europeo in quel travagliato torno di anni, vale a dire nel
mezzo della grande crisi dello Scisma d’Occidente e nella temperie cul-
turale che precede i grandi concili di Costanza e Basilea. Come non ri-
cordare la politica universitaria del papato avignonese? Essa influenzò
anche i potentati secolari e si tradusse in un atteggiamento nuovo di
fronte al fenomeno universitario, manifestando decisamente la tenden-
za ad una sempre più frequente concessione del privilegio per l’erezio-
ne di nuovi
studia generalia
. Ciò fu il frutto di una irripetibile conver-
genza tra sviluppo intellettuale, desiderio di città e principi di accrescere
il proprio prestigio attraverso la creazione di un centro universitario, in-
teresse della Chiesa e dei poteri civili alla formazione di un personale
qualificato intellettualmente
132
. Tale politica, che naturalmente tende-
va a sviluppare in primo luogo le facoltà di diritto, favorì ovviamente le
città della Francia meridionale e la stessa Avignone, ma si estese presto
all’Italia centro-settentrionale e all’Europa centrale, dove il mondo ger-
manico era rimasto sostanzialmente estraneo al grande rinnovamento
intellettuale dei secoli
xiii
e
xiv
. Dopo tutto lo Studio torinese ha le sue
origini proprio nella concessione fatta da Carlo IV di Lussemburgo-Boe-
mia ad Amedeo VI per l’istituzione di una università a Ginevra (2 giu-
gno 1365), «che doveva essere il centro del suo Stato alpino»
133
. Si può
dire che l’istituzione dell’università di Torino partecipi di questi moti-
vi, proprio sull’inizio del secolo di maggior travaglio delle cose d’Italia
e nel bel mezzo del conflitto interno alla Chiesa e alla cristianità, che di
131
Per la Francia quattro-cinquecentesca si veda il profilo tracciato da
v. piano mortari
,
Di-
ritto romano e diritto nazionale in Francia nel secolo
xvi
, Milano 1962; per Baldo degli Ubaldi (1327-
1400), il giurista perugino allievo di Bartolo e docente a Pavia, esponente massimo di una dottri-
na degli statuti svincolata dalla più tradizionale teoria della
permissio
, si veda
d. quaglioni
, «
Civi-
lis sapientia». Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra Medioevo ed Età moderna
, Rimini 1989, pp.
39-40 e
passim
; cfr. ora in proposito
id
.,
La legislazione del principe e gli statuti urbani nell’Italia del
Quattrocento
, in
gensini
(a cura di),
Principi e città alla fine del Medioevo
cit.
132
Rinvio a quanto osservato intorno alle università dell’età avignonese in
d. quaglioni
,
La
cultura
, in
id.
(a cura di),
La crisi del Trecento e il papato avignonese (1274-1378)
, Cinisello Balsa-
mo 1994 (Storia della Chiesa iniziata da A. Fliche e V. Martin, XI), pp. 367-74.
133
cognasso
,
Vita e cultura in Piemonte
cit., p. 651.


















