
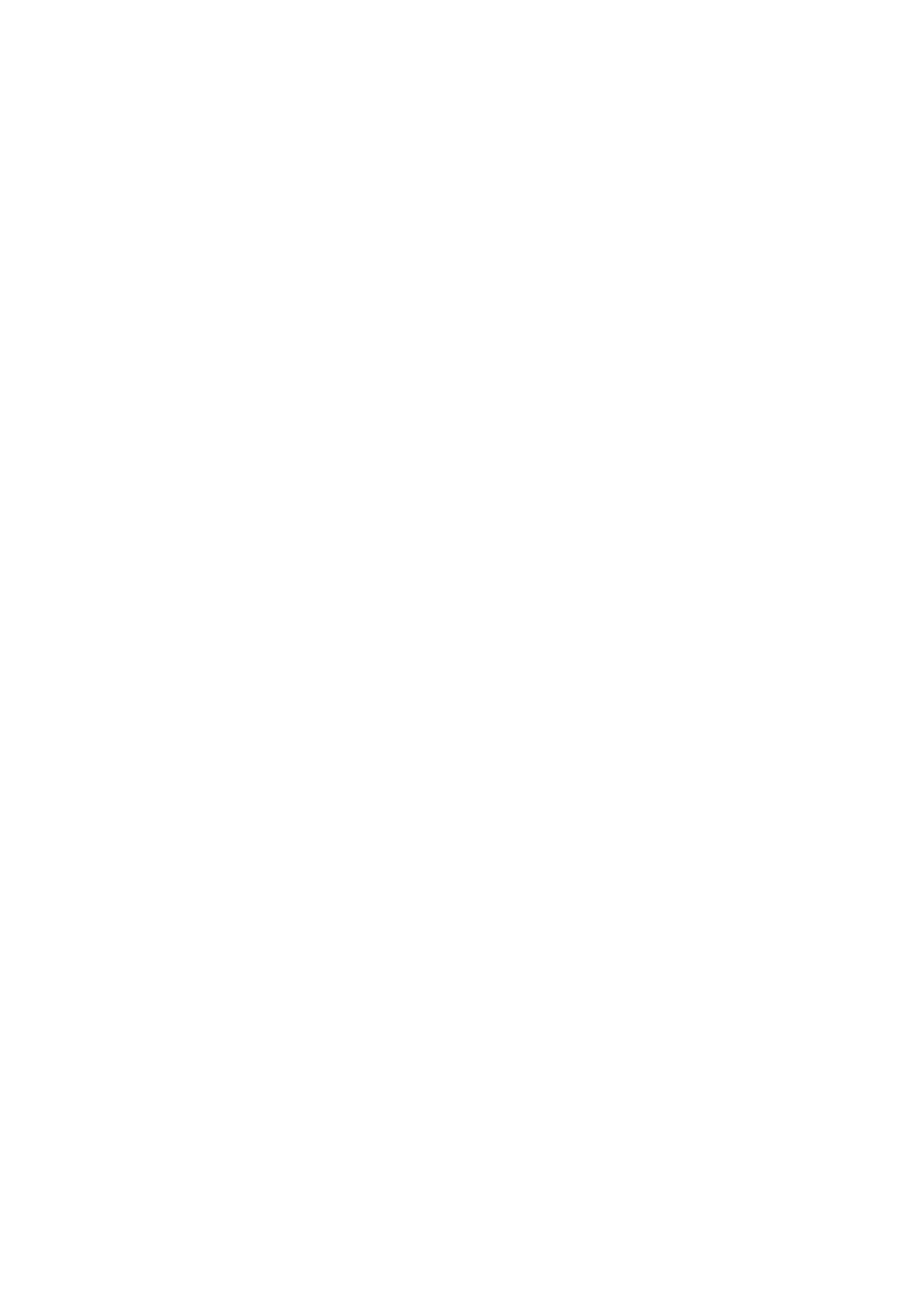
656
Parte seconda La preminenza sulle comunità del Piemonte (1418-1536)
bio di modelli e, nel rimestare continuo del trinomio «tradizione-scuola-
testimonianza» si sintetizza l’identità stessa d’una regione che, pur così
centrale nei passaggi, resta tanto statica nelle innovazioni tematiche.
Così la corte marchionale di Saluzzo è ravvivata dalla figura di An-
tonio Astesano (metà del Quattrocento), poeta di nessuna poesia, Uma-
nista di grande erudizione, formatosi nelle scuole di Pavia, grande let-
tore di Lucano e Terenzio. In contatto con Piccolomini, Guarino, Maf-
feo Vegio, il maestro Antonio si forma una sua scuola di cui fanno parte
Giovanni Antonio Vimercato, Maffeo Muzano, Cristoforo Vellate. Ma
Antonio gioca a fare il poeta, come il Panormita e il Vegio: i suoi versi
commentano le
Metamorfosi
d’Ovidio e narrano storie d’amore vissute
«sine coniuge […] inter iocos et amores»; l’amata si noma Florida e qui
giù una tirata di fanciulle antiche inventate su Tibullo, Catullo, Pro-
perzio; ma gli elegiaci non bastano per ricordare la bella vita, e allora
anche Marziale e i
Carmi
per Cinthia di Enea Silvio Piccolomini amico
e modello. Il clima faunesco e ludico della vita universitaria pavese fa di
Antonio un cantore d’amore… Poi, il trascorrere del tempo acqueta la
febbre, le mutate situazioni politiche del tempo lo portano lontano da
quelle atmosfere e si trasferisce a Chieri, dove insegna nelle scuole. Poe-
ta d’occasione, versificatore umanistico d’ambito universitario e poeta
cortigiano: questi ruoli non gli danno la gloria, bensì mutevoli venti di
vita; con il
De origine et vario regimine civitatis Mediolani libellus ex di-
versis cronicis extractus
, sua unica opera in prosa composta fra il 13 ago-
sto 1447 e il 31 dicembre 1448, Antonio, sulla scorta delle fonti del
Flamma, di Giacomo d’Acqui documentarie ed orali, fabbrica un testo
che gli dà qualche certezza di futuro al seguito del suo signore, il duca
Carlo, di cui diventa segretario. Lo segue a Parigi, in Francia ammira-
no la sua cultura umanistica. Egli ripensa la propria esistenza, riaffiora-
no le inclinazioni poetiche e nasce il
De eius vita et fortune varietate car-
men
, un vago andamento poetico settimelliano di un autobiografismo in
cui trovano posto memorie astigiane in modo prevalente, al punto da di-
ventare un
chronicon
in versi.
Guglielmo Ventura, Secondino Ventura, Ogerio Alfieri e Giovan
Giorgio Alione non arricchiscono il panorama dell’Umanesimo astigiano:
Antonio Astesano ne risulta l’indiscusso protagonista, un protagonista
senza seguaci e, alla somma, senza pubblico che non fosse quello dei suoi
rapporti sociali. Da questi Antonio trae motivazioni etiche che sembra-
no sincere; forse è poco, ma può bastare a farne un personaggio. Qualche
decennio prima della vicenda di Antonio, Bartolomeo Pascali, rettore del-
le scuole di Saluzzo dal 1464 al 1483, s’impone all’attenzione con un
Ex-
tractum grammatice
che nasce dall’intento d’un confronto fra l’autore e i


















