
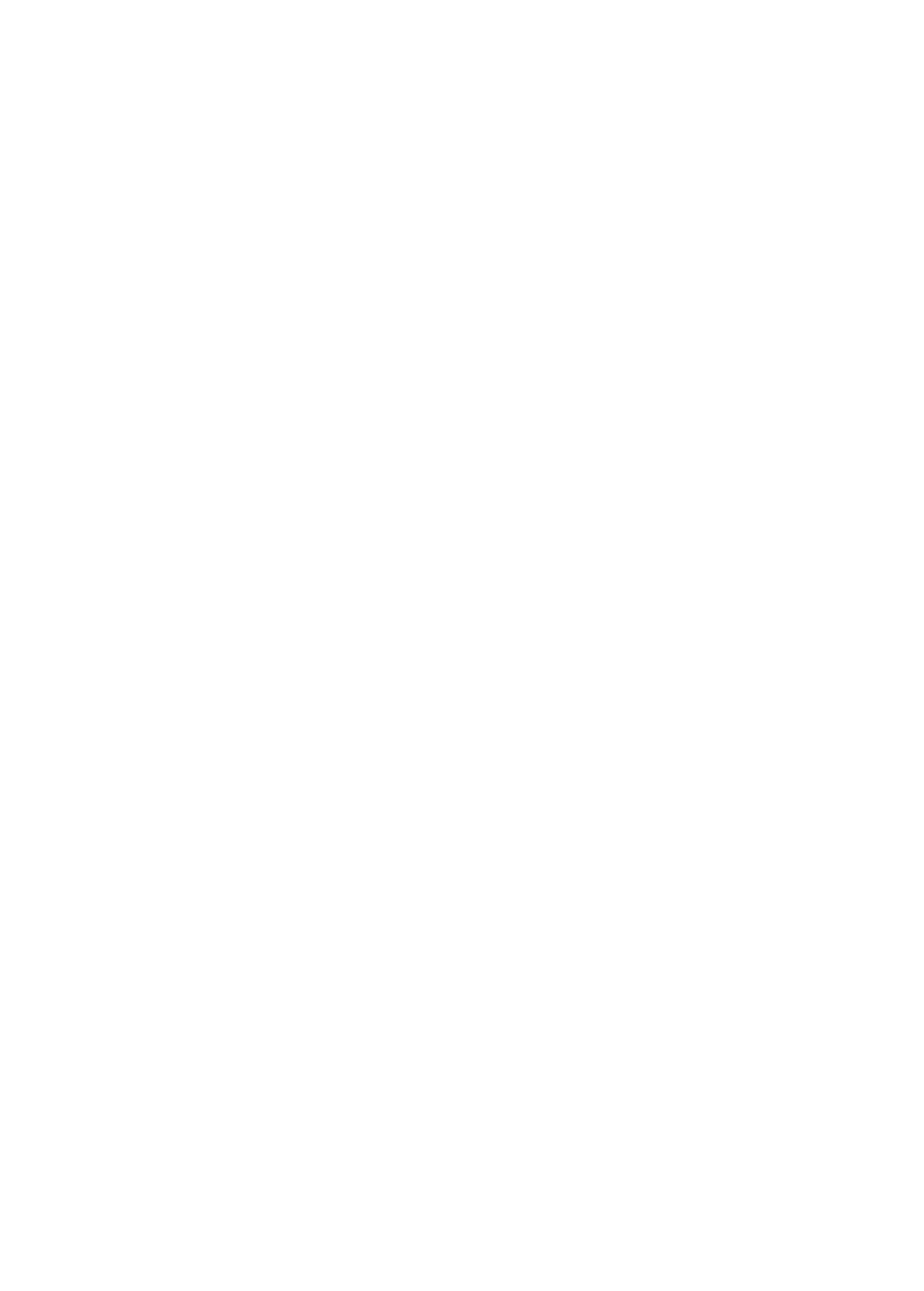
706
Parte seconda La preminenza sulle comunità del Piemonte (1418-1536)
que rasi di broccato violaceo per ricavarne un pallio per l’altare mag-
giore
282
, ma nel contempo dovette giudicare inadeguate al suo prestigio
di prelato curiale le tre antiche chiese. In quell’occasione potrebbe aver
pensato all’offerta della Madonna, copia dell’immagine veneratissima
di Santa Maria del Popolo al Santuario della Consolata
283
. Dopo quel
viaggio, governò la diocesi tramite vicari, fino a che poté affidarla co-
me coadiutore al nipote Giovanni Ludovico (1497), poi suo successore,
tranne un suo breve viaggio a Torino tra il 1496 e il 1498 su cui esiste
qualche incertezza
284
.
Il duomo iniziato e concluso rapidamente (1491-98), in particolare
per quanto concerne il suo prospetto marmoreo, si può immaginare do-
282
f. rondolino
,
Il Duomo di Torino illustrato
, Torino 1898, pp. 53, 221;
alessio
,
Per la bio-
grafia
cit., p. 185. Sui paramentali legati alla munificenza dei della Rovere di Savona e di Dome-
nico della Rovere cfr.
e. parma armani
,
Appunti sulla committenza dei Della Rovere a Genova fra
Quattro e Cinquecento
, in
s. bottaro
,
a. dagnino
e
g. rotondi terminiello
(a cura di),
Sisto IV e
Giulio II mecenati e promotori di cultura
(Atti del Convegno Internazionale di Studi, Savona 1985),
Savona 1989, pp. 319-22;
g. romano
,
Sugli altari del Duomo nuovo
, in
id
., (a cura di),
Domenico
della Rovere e il Duomo
cit., pp. 274-77.
283
Sulle tre chiese preesistenti
rondolino
,
Il Duomo
cit., pp. 9-47;
p. toesca
,
Vicende di un’an-
tica chiesa di Torino. Scavi e scoperte
, in «Bollettino d’Arte»,
xiii
(1910), n. 1, pp. 1-16;
e. olive-
ro
,
Frammenti di sculture romane e preromaniche nel Castelvecchio di Testona
, in «BSBS»,
xv
(1937),
1, pp. 6-31;
id
.,
Architettura religiosa preromanica e romanica nell’archidiocesi di Torino
, Torino
1941;
s. casartelli novelli
,
Le fabbriche della cattedrale di Torino dall’età paleocristiana all’alto
medioevo
, in «Studi Medievali»,
xi
(1970), pp. 617-58;
ead
.,
Corpus della scultura altomedievale
,
VI.
La diocesi di Torino
, Spoleto 1974, pp. 7-54, 165-228;
r. arena
,
c. piglione
e
g. romano
,
I
cantieri della scultura
, in
g. romano
(a cura di),
Piemonte romanico
, edizione fuori commercio per
la Banca CRT, Torino 1994, pp. 144-45;
m. t. bonardi
,
Le chiese urbane
, in
comba
e
roccia
(a
cura di),
Torino fra Medioevo e Rinascimento
cit., pp. 139-41. Sull’immagine della Consolata, do-
po il restauro del 1979 si è scoperta la scritta che ne dichiara la derivazione da quella di Santa Ma-
ria del Popolo del
xiii
secolo: l’aspetto quattrocentesco del dipinto torinese suscitò una felice in-
tuizione di A. Griseri, la quale la collegò al mecenatismo di Domenico della Rovere e alla produ-
zione dell’ambiente di Antoniazzo Romano e di Pinturicchio:
a. griseri
,
Tradizione e realtà storica:
una nuova ipotesi per l’immagine della Consolata
, in
f. bolgiani
(a cura di),
Gli ex voto della Conso-
lata. Storie di grazie e devozione nel santuario torinese
(catalogo della mostra), Torino 1982, pp. 23-
26. Tale ipotesi da me immediatamente condivisa (cfr.
quazza
e
pettenati
,
La biblioteca del car-
dinal
cit., p. 690), è ripresa da
r. comba
,
Lo spazio vissuto: atteggiamenti mentali e «costruzione» del
paesaggio urbano
, in
comba
e
roccia
(a cura di),
Torino fra Medioevo e Rinascimento
cit., pp. 30-
32. Con maggior ampiezza la Griseri è tornata sull’argomento, ripercorrendo la fortuna dell’icona
nelle «libere riprese di Antoniazzo e dei suoi «lavoranti»»:
a. griseri
,
La Consolata e il suo qua-
dro. Una conferma per la nuova attribuzione: Antoniazzo romano negli anni del cardinal della Rovere
,
in «Studi Piemontesi»,
xxv
(1996), 1, pp. 5-12, aggiungendo una bella versione inedita di colle-
zione privata torinese. È rievocato il ruolo culturale di Domenico della Rovere, sulla base della ri-
valutazione acquisita negli studi degli ultimi venticinque anni.
284
rondolino
,
Il Duomo
cit., p. 83;
id
.,
Il Cardinale Domenico Della Rovere
, in «Il Duomo di
Torino»,
i
(1927), 4, pp. 1-5. Domenico della Rovere era a Roma per il concistoro del 19 febbraio
1496, e prima nella seconda metà del 1495, perché è compagno di Alessandro VI nella fuga ad Or-
vieto (27 maggio 1495), mentre Carlo VIII alloggia per due giorni (1-2 giugno 1495) nel suo pa-
lazzo di Borgo e il 24 dicembre scrive la lettera di risposta a Pietro Cara che gli aveva chiesto di
poter avere una cappella nel nuovo duomo; cfr.
alessio
,
Per la biografia
cit., pp. 184, 190;
uginet
,
«Della Rovere, Domenico» cit., p. 336.


















