
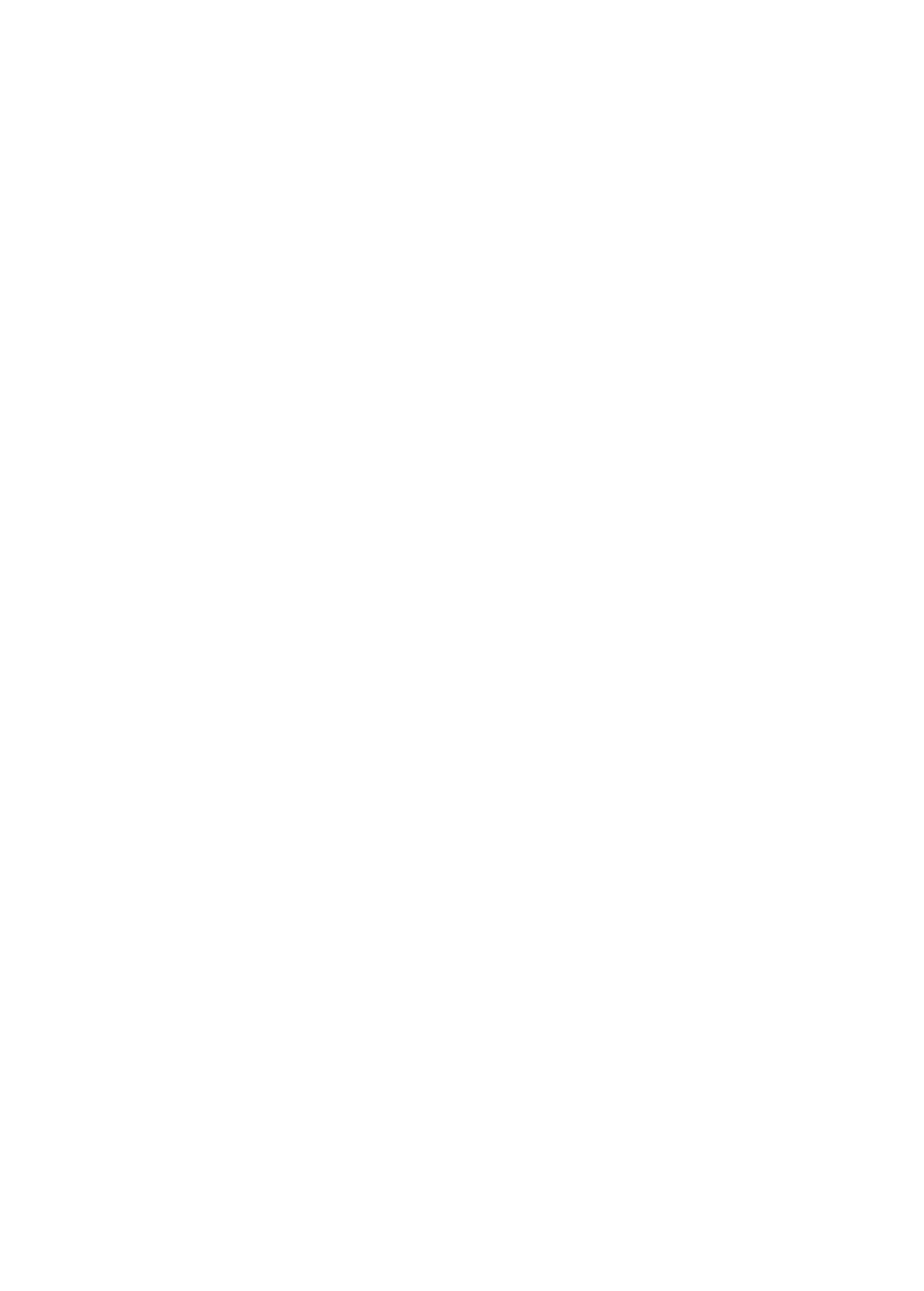
790
Parte seconda La preminenza sulle comunità del Piemonte (1418-1536)
la loro totalità agli ordini religiosi «mendicanti»: tra i maestri, i laurea-
ti e gli studenti degli anni 1411-89 non si ritrova un solo chierico seco-
lare
67
. Soprattutto ai frati Predicatori e Minori spettava il compito del-
la riflessione teologica e della predicazione: anzi il Quattrocento è pro-
prio l’epoca in cui raggiungono grande fama predicatori di quegli ordini
68
.
Anche in Torino nel corso del
xv
secolo predicarono personaggi presti-
giosi: per esempio, nel 1402 il domenicano Vicent Ferrer
69
, nel 1446 e
nel 1458 gli agostiniani Giovanni Marchisio e Giacomo
70
, nel 1459 il
francescano osservante Angelo Carletti
71
. Le proposte religiose dei mo-
naci della tradizione benedettina sembrano definitivamente tramonta-
te. Si badi: il cardinale Domenico della Rovere, nel suo testamento del
1501, chiederà le preghiere non delle comunità monastiche, bensì delle
comunità conventuali di Torino, cioè i conventi di San Domenico e di
San Francesco che si trovano «intra muros civitatis», e i conventi di
Sant’Agostino e di Santa Maria degli Angeli «extra muros»
72
.
Gli è che, nel corso del Quattrocento, l’inquadramento religioso del-
le popolazioni sembra subire una lentissima evoluzione non incoerente
con i più generali sviluppi della società. La base forte e perdurante è co-
stituita dalla distribuzione capillare nel territorio di chiese con cura d’ani-
me che garantisce l’elementare servizio sacrale e sacramentale – siano le
chiese servite dal titolare del beneficio o da un suo vicario. Le gerarchie
di Chiesa si preoccupano soltanto che tale servizio avvenga nel rispetto
di norme non meno elementari, ma consolidate da una prassi secolare.
C’è poi un livello che si sovrappone e che è rappresentato dal fatto
che ogni chiesa è dotata di un beneficio: e ogni beneficio è una possibi-
lità economica di vita. Ecco allora che il problema della cosiddetta prov-
vista dei benefici – per il Piemonte non se ne sa praticamente nulla – si
fa politico, oltre che ecclesiastico, perché il controllo delle assegnazioni
beneficiarie coinvolge i vertici della società, locale e non, intervenendo
67
Cfr.
bellone
,
Il primo secolo di vita
cit., pp. 132-41.
68
Cfr. le precise analisi contenute in
Predicazione francescana e società veneta nel Quattrocento:
committenza, ascolto, ricezione
(Atti del II Convegno internazionale di studi francescani, Padova
26-28 marzo 1987), Vicenza-Padova 1989; interessanti sono anche i contributi di
r. rusconi
,
Dal
pulpito alla confessione. Modelli di comportamento religioso in Italia tra 1470 circa e 1520 circa
, in
prodi
e
johanek
(a cura di),
Strutture ecclesiastiche
cit., pp. 259-315;
f. bisogni
,
Iconografia dei pre-
dicatori dell’Osservanza nella pittura dell’Italia del Nord fino agli inizi del Cinquecento
, in
Il rinnova-
mento del francescanesimo. L’Osservanza
(Atti dell’XI Convegno internazionale di Assisi, 20-22 ot-
tobre 1983), Assisi 1985, pp. 229-55.
69
Cfr.
f. monetti
e
a. cifani
,
Percorsi periferici. Studi e ricerche di storia dell’arte in Piemonte
(secc.
xv-xviii
)
, Torino 1985, pp. 35-43.
70
l. cibrario
,
Storia di Torino
, I, Torino 1846, pp. 377 sg.
71
Cfr.
m. bessone
,
Il beato Angelo Carletti da Chivasso
, Cuneo 1950.
72
tenivelli
,
Biografia piemontese
cit., pp. 184 sg.


















