
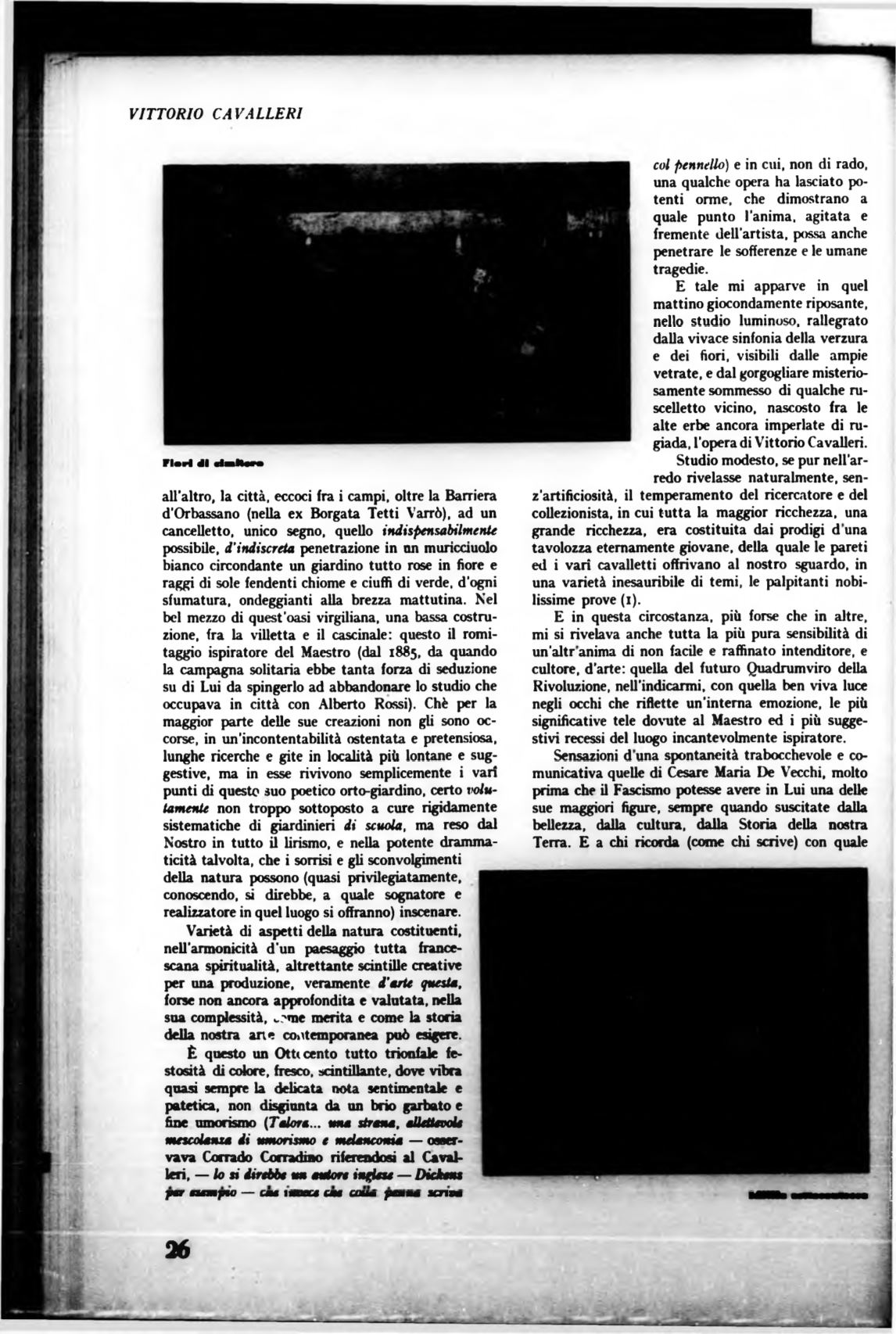
,*
5
* v
VITTORIO CAVALLERl
Fiori 41 «I
m
IU
n
all’altro, la città, eccoci fra i campi, oltre la Barriera
d’Orbassano (nella ex Borgata Tetti Varrò), ad un
cancelletto, unico segno, quello
indispensabilmente
possibile,
d'indiscreta
penetrazione in nn muricciuolo
bianco circondante un giardino tutto rose in fiore e
raggi di sole fendenti chiome e ciuffi di verde, d’ogni
sfumatura, ondeggianti alla brezza mattutina. Nel
bel mezzo di quest’oasi virgiliana, una bassa costru
zione, fra la villetta e il cascinale: questo il romi
taggio ispiratore del Maestro (dal 1885, da quando
la campagna solitaria ebbe tanta forza di seduzione
su di Lui da spingerlo ad abbandonare lo studio che
occupava in città con Alberto Rossi). Chè per la
maggior parte delle sue creazioni non gli sono oc
corse, in un’incontentabilità ostentata e pretensiosa,
lunghe ricerche e gite in località più lontane e sug
gestive, ma in esse rivivono semplicemente i vari
punti di questo suo poetico orto-giardino, certo
volu
tamente
non troppo sottoposto a cure rigidamente
sistematiche di giardinieri
di scuola,
ma reso dal
Nostro in tutto il lirismo, e nella potente dramma
ticità talvolta, che i sorrisi e gli sconvolgimenti
della natura possono (quasi privilegiatamente,
conoscendo, si direbbe, a quale sognatore e
realizzatore in quel luogo si offranno) inscenare.
Varietà di aspetti della natura costituenti,
neil’armonicità d’un paesaggio tutta france
scana spiritualità, altrettante scintille creative
per una produzione, veramente
d’arte questa,
forse non ancora approfondita e valutata, nella
sua complessità, ^me merita e come la storia
della nostra arie contemporanea può esigere.
È questo un Otti cento tutto trionfale fe
stosità di colore, fresco, scintillante, dove vibra
quasi sempre la delicata nota sentimentale e
patetica, non disgiunta da un brìo garbato e
fine umorismo (!
Talora... una stratta, allettevole
mescolanza di umorismo e melanconia
— osser
vava Corrado Corradino riferendosi al Caval
ieri, —
lo si direbbe un autore inglese
—
Dick***
per esempio
—
cne invece cmc coum pennm
scriva
36
col pennello)
e in cui, non di rado,
una qualche opera ha lasciato po
tenti orme, che dimostrano a
quale punto l’anima, agitata e
fremente dell’artista, possa anche
penetrare le sofferenze e le umane
tragedie.
E tale mi apparve in quel
mattino giocondamente riposante,
nello studio luminoso, rallegrato
dalla vivace sinfonia della verzura
e dei fiori, visibili dalle ampie
vetrate, e dal gorgogliare misterio
samente sommesso di qualche ru
scelletto vicino, nascosto fra le
alte erbe ancora imperlate di ru
giada, l’operadi Vittorio Cavalieri.
Studio modesto, se pur nell’ar
redo rivelasse naturalmente, sen
z’artificiosità, il temperamento del ricercatore e del
collezionista, in cui tutta la maggior ricchezza, una
grande ricchezza, era costituita dai prodigi duna
tavolozza eternamente giovane, della quale le pareti
ed i vari cavalletti offrivano al nostro sguardo, in
una varietà inesauribile di temi, le palpitanti nobi
lissime prove (1).
E in questa circostanza, più forse che in altre,
mi si rivelava anche tutta la più pura sensibilità di
un'altr anima di non facile e raffinato intenditore, e
cultore, d’arte: quella del futuro Quadrumviro della
Rivoluzione, neU’indicarmi, con quella ben viva luce
negli occhi che riflette un’interna emozione, le più
significative tele dovute al Maestro ed i più sugge
stivi recessi del luogo incantevolmente ispiratore.
Sensazioni duna spontaneità trabocchevole e co
municativa quelle di Cesare Maria De Vecchi, molto
prima che il Fascismo potesse avere in Lui una delle
sue maggiori figure, sempre quando suscitate dalla
bellezza, dalla cultura, dalla Storia della nostra
Terra. E a chi ricorda (come chi scrive) con quale


















