
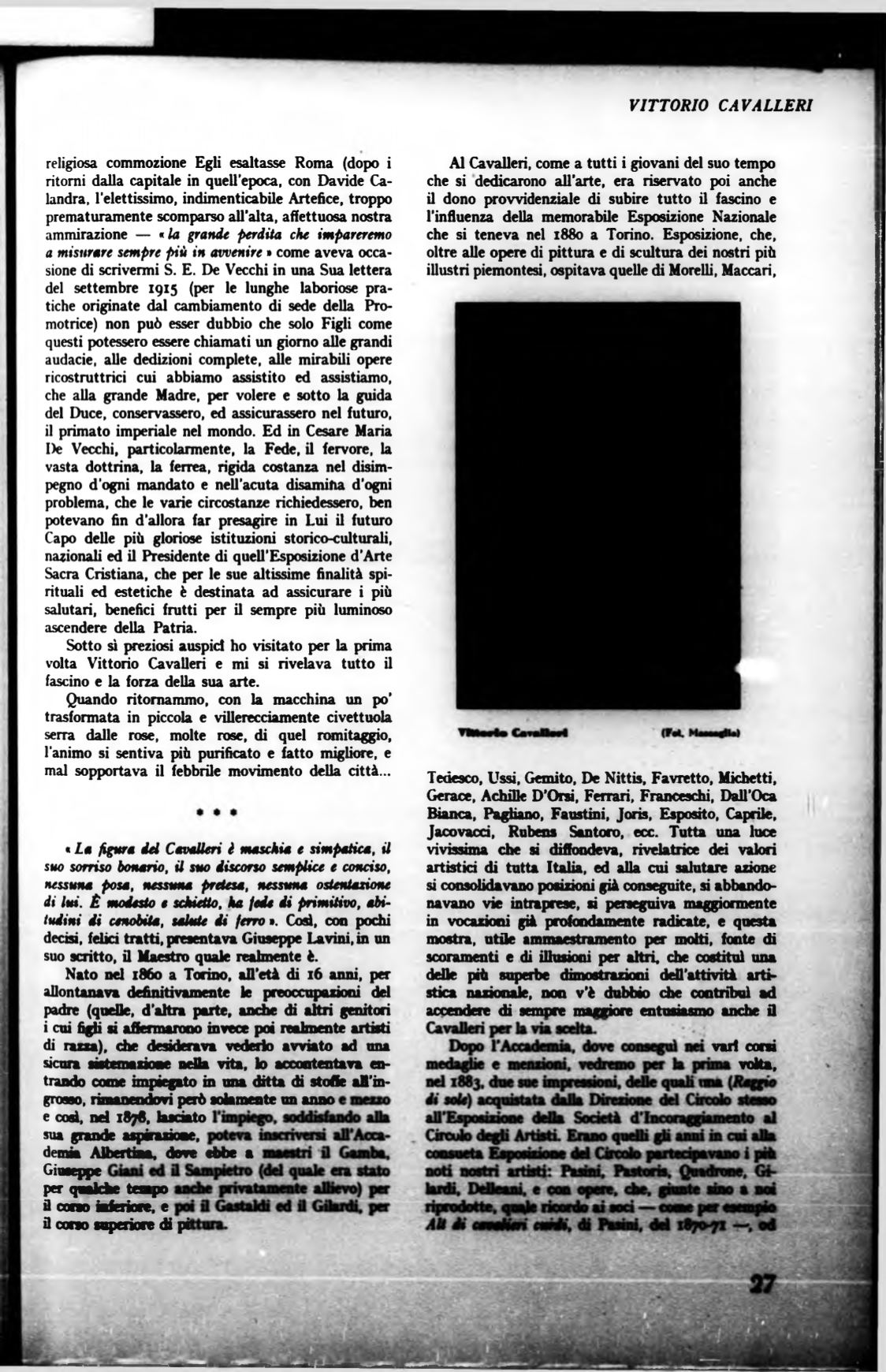
VITTORIO CAVALLERI
religiosa commozione Egli esaltasse Roma (dopo i
ritorni dalla capitale in quell'epoca, con Davide Ca
landra, l’elettissimo, indimenticabile Artefice, troppo
prematuramente scomparso all’alta, affettuosa nostra
ammirazione —
*la grande perdita che impareremo
a misurare sempre più in avvenire
»come aveva occa
sione di scrivermi S. E. De Vecchi in una Sua lettera
del settembre 1915 (per le lunghe laboriose pra
tiche originate dal cambiamento di sede della Pro
motrice) non può esser dubbio che solo Figli come
questi potessero essere chiamati un giorno alle grandi
audacie, alle dedizioni complete, alle mirabili opere
ricostruttrici cui abbiamo assistito ed assistiamo,
che alla grande Madre, per volere e sotto la guida
del Duce, conservassero, ed assicurassero nel futuro,
il primato imperiale nel mondo. Ed in Cesare Maria
I)e Vecchi, particolarmente, la Fede, il fervore, la
vasta dottrina, la ferrea, rìgida costanza nel disim
pegno d'ogni mandato e nell’acuta disamifia d’ogni
problema, che le varie circostanze richiedessero, ben
potevano fin d’allora far presagire in Lui il futuro
Capo delle più gloriose istituzioni storico-culturali,
nazionali ed il Presidente di quell’Esposizione d’Arte
Sacra Cristiana, che per le sue altissime finalità spi
rituali ed estetiche è destinata ad assicurare i più
salutari, benefici frutti per il sempre più luminoso
ascendere della Patria.
Sotto sì preziosi auspici ho visitato per la prima
volta Vittorio Cavalieri e mi si rivelava tutto il
fascino e la forza della sua arte.
Quando ritornammo, con la macchina un po’
trasformata in piccola e villerecciamente civettuola
serra dalle rose, molte rose, di quel romitaggio,
l’animo si sentiva più purificato e fatto migliore, e
mal sopportava il febbrile movimento della città...
«
L a figura del C avalieri è m aschia e sim patica, il
suo
sorriso bonario, il suo discorso sem plice e conciso,
nessuna posa, nessuna pretesa, nessuna ostentazione
d i lu i. È modesto e schietto, ha fede d i prim itivo, abi
tudini d i cenobita, salute d i ferro
». Cori, con pochi
decisi, felici tratti, presentava Giuseppe Lavini, in un
suo
scrìtto, il Maestro quale realmente è.
Nato nel 1860 a Torino, all’età di 16 anni, per
allontanava definitivamente le preoccupazioni del
padre (quelle, d’altra parte, anche di altri genitori
i cui figli si affermarono invece poi realmente artisti
di razza), che desiderava vedalo avviato ad una
sicura sistemazione nella vita, lo accontentava en
trando come impiegato in una ditta di stoffe afl’in-
grosso, rimanendovi però solamente un anno
e cori, nel 1878, lasciato
sua grande aspirazione,
demia Albertina, dove ebbe a
Giuseppe
per qualche tempo
il cono inferiore, e
3
cono superiore di pi
Al Cavalieri, come a tutti i giovani del suo tempo
che si dedicarono all’arte, era riservato poi anche
il dono provvidenziale di subire tutto il fascino e
l’influenza della memorabile Esposizione Nazionale
che si teneva nel 1880 a Torino. Esposizione, che,
oltre alle opere di pittura e di scultura dei nostri più
illustri piemontesi, ospitava quelle di Morelli, Maccari,
Tedesco, Ussi, Gemito, De Nittis, Favretto, Mkhetti,
Gerace, Achille D’Orsi, Ferrari, Franceschi, Dall’Oca
Bianca, Pagliano, Faustini, Joris, Esposito, Caprile,
Jacovacci, Rubens Santoro, ecc. Tutta una luce
vivissima che si diffondeva, rivelatrice dei valori
artistici di tutta Italia, ed alla cui salutare azione
si consolidavano posizioni già conseguite, si abbando
navano vie intraprese, si perseguiva maggiormente
in vocazioni già profondamente radicate, e questa
mostra, utile ammaestramento per molti, fonte di
scoramenti e di illusioni per altri, che costituì una
delle più superbe dimostrazioni dell'attività arti
stica nazionale, non v’è dubbio che contribuì ad
accendere di sempre maggiore entusiasmo anche il
vari coni
volta.


















