
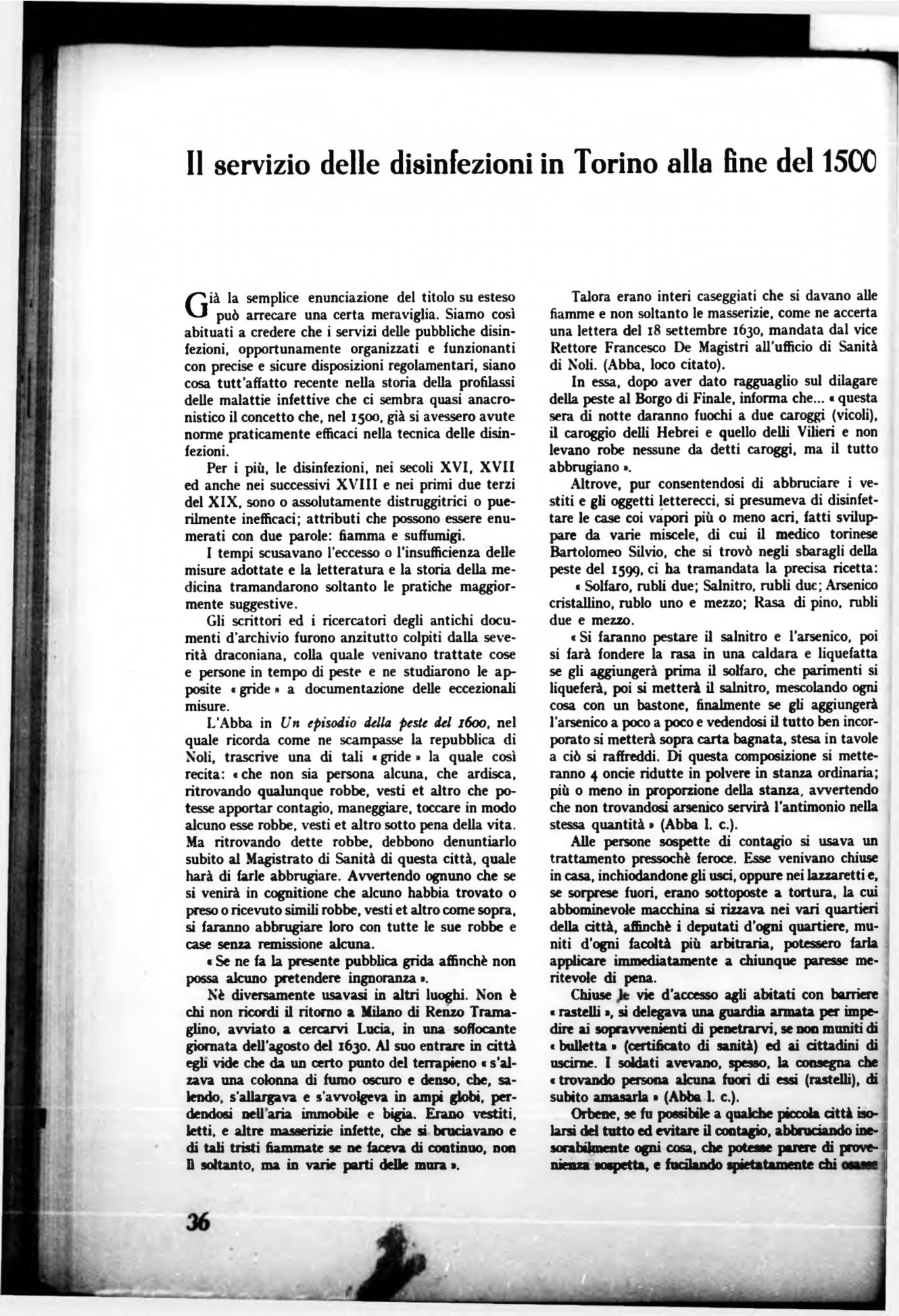
Il servizio delle disinfezioni in Torino alla fine del 1500
G
ià la semplice enunciazione del titolo su esteso
può arrecare una certa meraviglia. Siamo così
abituati a credere che i servizi delle pubbliche disin
fezioni, opportunamente organizzati e funzionanti
con precise e sicure disposizioni regolamentari, siano
cosa tutt'affatto recente nella storia della profilassi
delle malattie infettive che ci sembra quasi anacro
nistico il concetto che, nel 1500, già si avessero avute
norme praticamente efficaci nella tecnica delle disin
fezioni.
Per i più, le disinfezioni, nei secoli XVI, XVII
ed anche nei successivi XVIII e nei primi due terzi
del XIX, sono o assolutamente distruggitrici o pue
rilmente inefficaci; attributi che possono essere enu
merati con due parole: fiamma e suffumigi.
I
tempi scusavano l’eccesso o l’insufficienza delle
misure adottate e la letteratura e la storia della me
dicina tramandarono soltanto le pratiche maggior
mente suggestive.
Gli scrittori ed i ricercatori degli antichi docu
menti d’archivio furono anzitutto colpiti dalla seve
rità draconiana, colla quale venivano trattate cose
e persone in tempo di peste e ne studiarono le ap
posite «gride
»
a documentazione delle eccezionali
misure.
L’Abba in
Un episodio della peste del 1600,
nel
quale ricorda come ne scampasse la repubblica di
Noli, trascrive una di tali «gride » la quale così
recita: «che non sia persona alcuna, che ardisca,
ritrovando qualunque robbe, vesti et altro che po
tesse apportar contagio, maneggiare, toccare in modo
alcuno esse robbe, vesti et altro sotto pena della vita.
Ma ritrovando dette robbe, debbono denuntiarlo
subito al Magistrato di Sanità di questa città, quale
harà di farle abbrugiare. Avvertendo ognuno che se
si venirà in cognitione che alcuno habbia trovato o
presoo ricevuto simili robbe, vesti et altro come sopra,
si faranno abbrugiare loro con tutte le sue robbe e
case senza remissione alcuna.
«Se ne fa la presente pubblica grida affinchè non
possa alcuno pretendere ingnoranza ».
Nè diversamente usavasi in altri luoghi. Non è
chi non ricordi il ritorno a Milano di Renzo Trama
glino, avviato a cercarvi Lucia, in una soffocante
giornata dell’agosto del 1630. Al suo entrare in città
egli vide che da un certo punto del terrapieno «s’al
zava una colonna di fumo oscuro e denso, che, sa
lendo, s’allargava e s'avvolgeva in ampi globi, per
dendosi nell aria immobile e bigia. Erano vestiti,
letti, e altre masserizie infette, che si bruciavano e
di tali tristi fiammate se ne faceva di continuo, non
lì soltanto, ma in varie parti delle mura ».
Talora erano interi caseggiati che si davano alle
fiamme e non soltanto le masserizie, come ne accerta
una lettera del 18 settembre 1630, mandata dal vice
Rettore Francesco De Magistri all’ufficio di Sanità
di Noli. (Abba, loco citato).
In essa, dopo aver dato ragguaglio sul dilagare
della peste al Borgo di Finale, informa che... «questa
sera di notte daranno fuochi a due caroggi (vicoli),
il caroggio delli Hebrei e quello delli Vilieri e non
levano robe nessune da detti caroggi, ma il tutto
abbrugiano ».
Altrove, pur consentendosi di abbruciare i ve
stiti e gli oggetti letterecci, si presumeva di disinfet
tare le case coi vapori più o meno acri, fatti svilup
pare da varie miscele, di cui il medico torinese
Bartolomeo Silvio, che si trovò negli sbaragli della
peste del 1599, ci ha tramandata la precisa ricetta:
«Solfara, rubli due; Salnitro, rubli due; Arsenico
cristallino, rublo uno e mezzo; Rasa di pino, rubli
due e mezzo.
«Si faranno pestare il salnitro e l’arsenico, poi
si farà fondere la rasa in una caldara e liquefatta
se gli aggiungerà prima il solfara, che parimenti si
liqueferà, poi si metterà il salnitro, mescolando ogni
cosa con un bastone, finalmente se gli aggiungerà
l’arsenico a poco a poco e vedendosi il tutto ben incor
porato si metterà sopra carta bagnata, stesa in tavole
a ciò si raffreddi. Di questa composizione si mette
ranno 4 onde ridutte in polvere in stanza ordinaria;
più o meno in proporzione della stanza, avvertendo
che non trovandosi arsenico servirà l’antimonio nella
stessa quantità » (Abba
1
. c.).
Alle persone sospette di contagio si usava un
trattamento pressoché feroce. Esse venivano chiuse
incasa, inchiodandonegli usci, oppure nei lazzaretti e,
se sorprese fuori, erano sottoposte a tortura, la cui
abbominevole macchina si rizzava nei vari quartieri
della città, affinchè i deputati d’ogni quartiere, mu
niti d’ogni facoltà più arbitraria, potessero farla
applicare immediatamente a chiunque paresse me
ritevole di pena.
Chiuse
vie d’accesso agli abitati con barriere
«rastelh », si delegava una guardia armata per impe
dire ai sopravvenienti di
penetrarvi,
se
non
muniti di
«bulletta » (certificato di sanità) ed ai cittadini
di
uscirne. I soldati avevano, spesso, la consegna che
«trovando persona alcuna fuori di essi (rastelli),
di
subito amasarla »(Abba L c.).
Orbene,
se fu
possibile a qualche piccola d ttà iso
larsi del tu tto ed evitare il contagio, abbruciando ine
sorabilmente ogni cosa, che potesse parere di prove
nienza sospetta, e fucilando spietatamente d ii
— |


















