
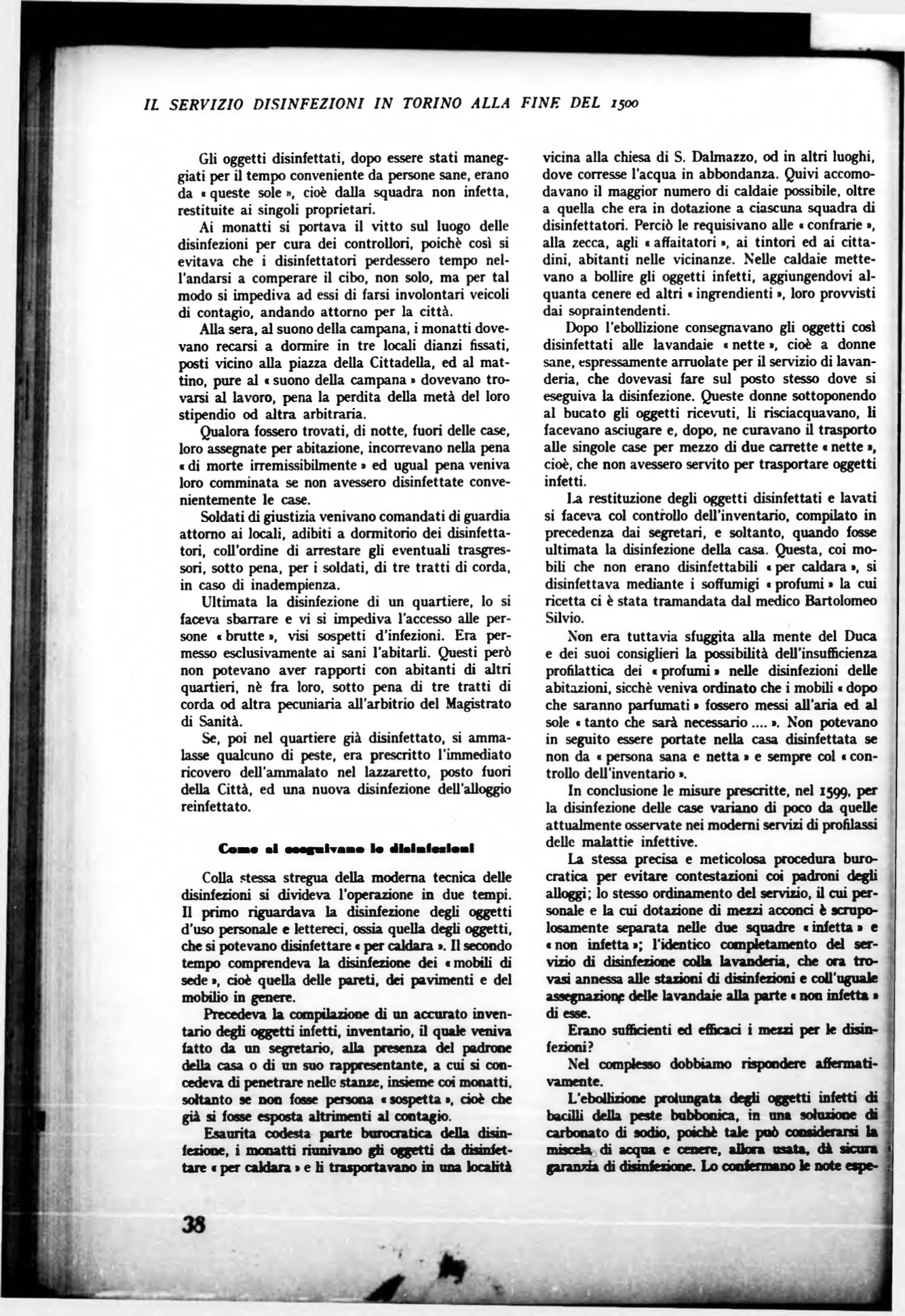
IL SERVIZIO DISINFEZIONI IN TORINO ALLA FINE DEL
1500
Gli oggetti disinfettati, dopo essere stati maneg
giati per il tempo conveniente da persone sane, erano
da «queste sole », cioè dalla squadra non infetta,
restituite ai singoli proprietari.
Ai monatti si portava il vitto sul luogo delle
disinfezioni per cura dei controllori, poiché così si
evitava che i disinfettatori perdessero tempo nel-
l’andarsi a comperare il cibo, non solo, ma per tal
modo si impediva ad essi di farsi involontari veicoli
di contagio, andando attorno per la città.
Alla sera, al suono della campana, i monatti dove
vano recarsi a dormire in tre locali dianzi fissati,
posti vicino alla piazza della Cittadella, ed al mat
tino, pure al «suono della campana »dovevano tro
varsi al lavoro, pena la perdita della metà del loro
stipendio od altra arbitraria.
Qualora fossero trovati, di notte, fuori delle case,
loro assegnate per abitazione, incorrevano nella pena
«di morte irremissibilmente » ed ugual pena veniva
loro comminata se non avessero disinfettate conve
nientemente le case.
Soldati di giustizia venivano comandati di guardia
attorno ai locali, adibiti a dormitorio dei disinfetta
tori, coll’ordine di arrestare gli eventuali trasgres
sori, sotto pena, per i soldati, di tre tratti di corda,
in caso di inadempienza.
Ultimata la disinfezione di un quartiere, lo si
faceva sbarrare e vi si impediva l’accesso alle per
sone «brutte », visi sospetti d’infezioni. Era per
messo esclusivamente ai sani l’abitarU. Questi però
non potevano aver rapporti con abitanti di altri
quartieri, nè fra loro, sotto pena di tre tratti di
corda od altra pecuniaria all’arbitrio del Magistrato
di Sanità.
Se, poi nel quartiere già disinfettato, si amma
lasse qualcuno di peste, era prescritto l’immediato
ricovero dell’ammalato nel lazzaretto, posto fuori
della Città, ed una nuova disinfezione dell’alloggio
reinfettato.
Coac al Mcgnivano la disinfczioni
Colla stessa stregua della moderna tecnica delle
disinfezioni si divideva l’operazione in due tempi.
Il primo riguardava la disinfezione degli oggetti
d’uso personale e lettereci, ossia quella degli oggetti,
che si potevano disinfettare « per caldara ». Il secondo
tempo comprendeva la disinfezione dei «mobili di
sede », cioè quella delle pareti, dei pavimenti e del
mobilio in genere.
Precedeva la compilazione di un accu rato inven
tario degli oggetti infetti, inventario, il quale veniva
fatto da un segretario, alla presenza del padrone
della casa o di un suo rappresentante, a cui si con
cedeva di penetrare nelle stanze, insieme coi monatti,
soltanto se non fosse persona « sospetta », cioè che
già si fosse esposta altrim enti a l contagio.
Esaurita codesta parte burocratica della disin
fezione, i monatti riunivano gli oggetti da disinfet
tare «per caldara »e li trasportavano in una località
vicina alla chiesa di S. Dalmazzo, od in altri luoghi,
dove corresse l’acqua in abbondanza. Quivi accomo
davano il maggior numero di caldaie possibile, oltre
a quella che era in dotazione a ciascuna squadra di
disinfettatori. Perciò le requisivano alle «confrarie »,
alla zecca, agli «affaitatori », ai tintori ed ai citta
dini, abitanti nelle vicinanze. Nelle caldaie mette
vano a bollire gli oggetti infetti, aggiungendovi al
quanta cenere ed altri «ingrendienti », loro provvisti
dai sopraintendenti.
Dopo l’ebollizione consegnavano gli oggetti cosi
disinfettati alle lavandaie «nette », cioè a donne
sane, espressamente arruolate per il servizio di lavan
deria, che dovevasi fare sul posto stesso dove si
eseguiva la disinfezione. Queste donne sottoponendo
al bucato gli oggetti ricevuti, li risciacquavano, li
facevano asciugare e, dopo, ne curavano il trasporto
alle singole case per mezzo di due carrette «nette »,
cioè, che non avessero servito per trasportare oggetti
infetti.
I.a restituzione degli oggetti disinfettati e lavati
si faceva col controllo dell’inventario, compilato in
precedenza dai segretari, e soltanto, quando fosse
ultimata la disinfezione della casa. Questa, coi mo
bili che non erano disinfettabili «per caldara », si
disinfettava mediante i soffumigai «profumi » la cui
ricetta ci è stata tramandata dal medico Bartolomeo
Silvio.
Non era tuttavia sfuggita alla mente del Duca
e dei suoi consiglieri la possibilità dell’insufficienza
profilattica dei «profumi » nelle disinfezioni delle
abitazioni, sicché veniva ordinato che i mobili «dopo
che saranno parfumati » fossero messi all’aria ed al
sole «tanto che sarà necessario .... ». Non potevano
in seguito essere portate nella casa disinfettata se
non da «persona sana e netta »e sempre col «con
trollo dell’inventario ».
In conclusione le misure prescritte, nel 1599, per
la disinfezione delle case variano di poco da quelle
attualmente osservate nei moderni servizi di profilassi
delle malattie infettive.
La stessa precisa e meticolosa procedura buro
cratica per evitare contestazioni coi padroni degli
alloggi; lo stesso ordinamento del servizio, il cui per
sonale e la cui dotazione di mezzi acconci è scrupo
losamente separata nelle due squadre «infetta ■e
«non infetta»; l ’identico completamento del ser
vizio di disinfezione cdla lavanderia, che ora tro
vasi annessa alle stazioni di disinfezioni e coll’uguale
assegnazione delle lavandaie alla parte ■ non infetta •
di esse.
Erano sufficienti ed efficaci i mezzi per le disin
fezioni?
Nel complesso dobbiamo rispondere affermati
vamente.
L’ebollizione prolungata degli oggetti infetti di
bacilli della peste bubbonica, in una soluzione di
carbonato di sodio, poiché tale può considerarsi la
miscela di acqua e cenere, allora osata, dà sicura *
garanzia di disinleziooe. Lo confermano le note cape- ;


















