
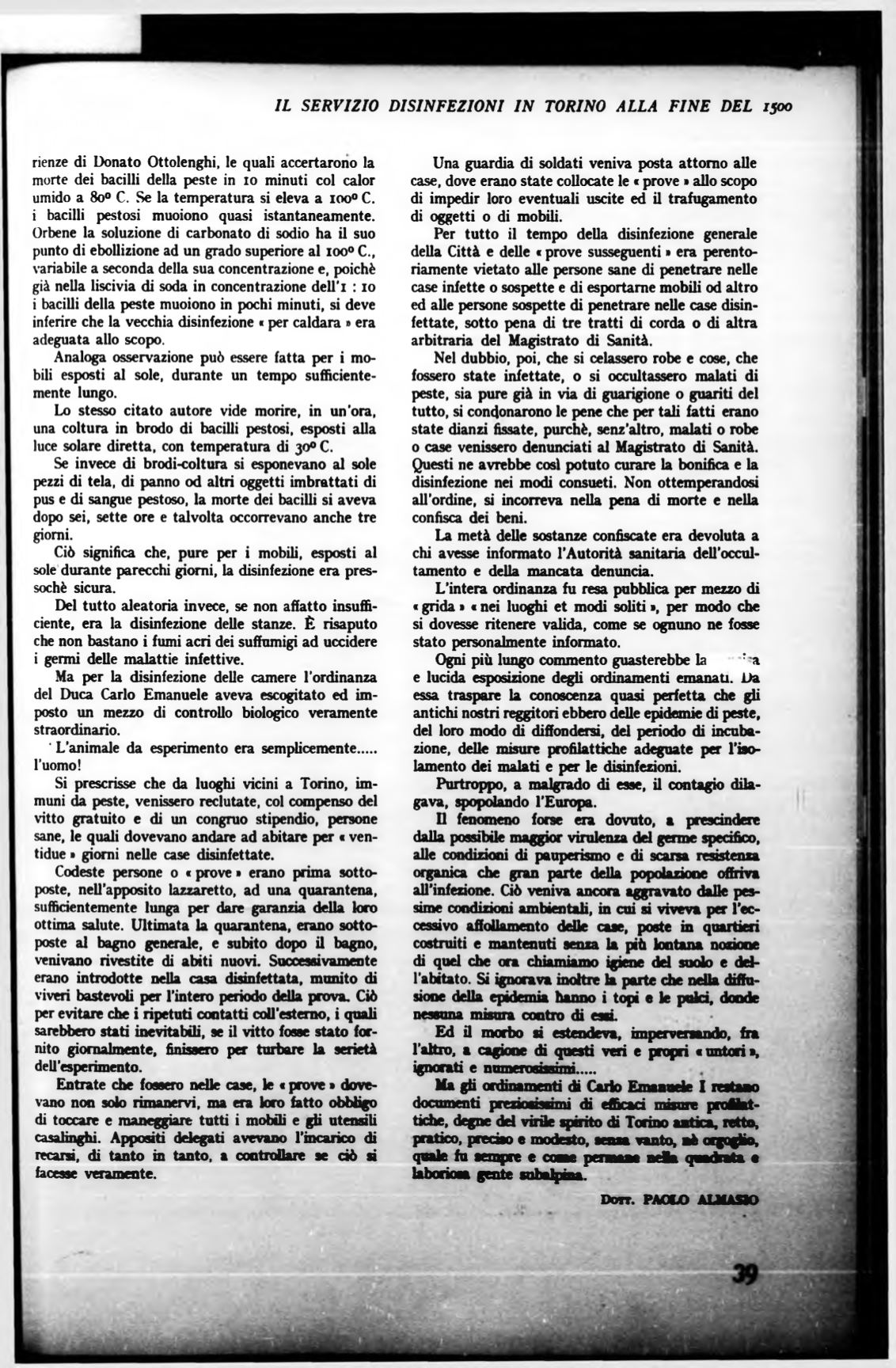
IL SERVIZIO DISINFEZIONI IN TORINO ALLA F IN E DEL
1500
rienze di Donato Ottolenghi, le quali accertarono la
morte dei bacilli della peste in 10 minuti col calor
umido a 8o° C. Se la temperatura si eleva a ioo° C.
i bacilli pestosi muoiono quasi istantaneamente.
Orbene la soluzione di carbonato di sodio ha il suo
punto di ebollizione ad un grado superiore al ioo° C.,
variabile a seconda della sua concentrazione e, poiché
già nella liscivia di soda in concentrazione dell'i : 10
i bacilli della peste muoiono in pochi minuti, si deve
inferire che la vecchia disinfezione «per caldara »era
adeguata allo scopo.
Analoga osservazione può essere fatta per i mo
bili esposti al sole, durante un tempo sufficiente-
mente lungo.
Lo stesso citato autore vide morire, in un’ora,
una coltura in brodo di bacilli pestosi, esposti alla
luce solare diretta, con temperatura di 30° C.
Se invece di brodi-coltura si esponevano al sole
pezzi di tela, di panno od altri oggetti imbrattati di
pus e di sangue pestoso, la morte dei baciUi si aveva
dopo sei, sette ore e talvolta occorrevano anche tre
giorni.
Ciò significa che, pure per i mobili, esposti al
sole durante parecchi giorni, la disinfezione era pres
soché sicura.
Del tutto aleatoria invece, se non affatto insuffi
ciente, era la disinfezione delle stanze. È risaputo
che non bastano i fumi acri dei suffumigi ad uccidere
i germi delle malattie infettive.
Ma per la disinfezione delle camere l’ordinanza
del Duca Carlo Emanuele aveva escogitato ed im
posto un mezzo di controllo biologico veramente
straordinario.
' L’animale da esperimento era semplicemente....
l’uomo!
Si prescrisse che da luoghi vicini a Torino, im
muni da peste, venissero reclutate, col compenso del
vitto gratuito e di un congruo stipendio, persone
sane, le quali dovevano andare ad abitare per «ven-
tidue » giorni nelle case disinfettate.
Codeste persone o «prove » erano prima sotto
poste, nell’apposito lazzaretto, ad una quarantena,
sufficientemente lunga per dare garanzia della loro
ottima salute. Ultimata la quarantena, erano sotto
poste al bagno generale, e subito dopo il bagno,
venivano rivestite di abiti nuovi. Successivamente
erano introdotte nella casa disinfettata, monito di
viveri bastevoli per l’intero periodo della prova. Ciò
per evitare che i ripetuti contatti coll’esterno, i quali
sarebbero stati inevitabili, se il vitto fosse stato for
nito giornalmente, finissero per turbare la serietà
dell’esperimento.
Entrate che fossero nelle case, le «prove >dove
vano non solo rimanervi, ma era loro fatto obbligo
di toccare e maneggiare tutti i mobili e gli utensili
casalinghi. Appositi delegati avevano l’incarico di
recarsi, di tanto in tanto, a controllare se dò si
facesse veramente.
Una guardia di soldati veniva posta attorno alle
case, dove erano state collocate le «prove »allo scopo
di impedir loro eventuali uscite ed il trafugamento
di oggetti o di mobili.
Per tutto il tempo della disinfezione generale
della Città e delle «prove susseguenti »era perento
riamente vietato alle persone sane di penetrare nelle
case infette o sospette e di esportarne mobili od altro
ed alle persone sospette di penetrare nelle case disin
fettate, sotto pena di tre tratti di corda o di altra
arbitraria del Magistrato di Sanità.
Nel dubbio, poi, che si celassero robe e cose, che
fossero state infettate, o si occultassero malati di
peste, sia pure già in via di guarigione o guariti del
tutto, si condonarono le pene che per tali fatti erano
state dianzi fissate, purché, senz’altro, malati o robe
0 case venissero denunciati al Magistrato di Sanità.
Questi ne avrebbe così potuto curare la bonifica e la
disinfezione nei modi consueti. Non ottemperandosi
all’ordine, si incorreva nella pena di morte e nella
confisca dei beni.
La metà delle sostanze confiscate era devoluta a
chi avesse informato l’Autorità sanitaria dell’occul
tamento e della mancata denuncia.
L’intera ordinanza fu resa pubblica per mezzo di
«grida »«nei luoghi et modi soliti », per modo che
si dovesse ritenere valida, come se ognuno ne fosse
stato personalmente informato.
Ogni più lungo commento guasterebbe la
: a
e lucida esposizione degli ordinamenti emanati. Da
essa traspare la conoscenza quasi perfetta che gli
antichi nostri reggitori ebbero delle epidemie di peste,
del loro modo di diffondersi, del periodo di incuba
zione, delle misure profilattiche adeguate per l’iso
lamento dei malati e per le disinfezioni.
Purtroppo, a malgrado di esse, il contagio dila
gava, spopolando l’Europa.
Il
fenomeno forse era dovuto, a prescindere
dalla possibile maggior virulenza del game specifico,
alle condizioni di pauperismo e di scarsa resistenza
organica che gran parte della popolazione offriva
all’infezione. Ciò veniva ancora aggravato dalle pes
sime condizioni ambientali, in cui si viveva per l’ec
cessivo affilamento delle case, poste in quartieri
costruiti e mantenuti senza la più lontana nozione
di quel che ora chiamiamo igiene del soolo e del
l’abitato. Si ignorava inoltre la parte che nella diffu
sione della epidemia hanno i topi e le palò, donde
nessuna misura contro di essi.
Ed il morbo si estendeva, imperversando, fra
l’altro, a cagione di questi veri e propri «untori»,
ignorati e numerosissimi....
Ha gli ordinamenti di Cario Emanuele I restano
documenti preziosissimi di efficaci misure profilat
tiche, degne del virile spirito di Torino antica, ietto,
pratico, preciso e modesto, senza vanto, nè orgoglio,
quale fu sempre e come permane nella quadrata •
laboriosa gente subalpina.
D
ott
. PAOLO ALMASIO


















